Minimale lo è sempre stata a cominciare dai numeri della sua filmografia, composta da appena sette film in ventidue anni di carriera. Per una come Kelly Reichardt la regia è sempre stata una questione di fede ai suoi personaggi e alle loro storie, così diverse dall’immaginario dominante da valere la pena di aspettare per filmarli al momento giusto. Marginale ma tenace il cinema della Reichardt è riuscito negli anni a raccontare l’altra America creando un universo a se stante che è poi quello di cui abbiamo provato a scrivere nella monografia dedicata alla regista americana. Coscienti di farlo in uno spazio come quello di un blog poco adatto alla sua lunghezza siamo però sicuri di offrire ai nostri lettori un unicum nel suo genere, non esistendo traccia di una letteratura che abbia trattato l’argomento.
Carlo Cerofolini.
Il deserto gentile di Kelly Reichardt
di Alessandro D'Orazio
I am soft and silly and my name is Lillianaloo
And sir you're fair black fashion for this winter's passion oo
I've been sold by sailors, I've been worn by tailors, soldiers wound me
But you my captain are medication for my reputation
- L.Nyro -
Forse non è più possibile guardare all’America (per ciò che qui preme, indipendentemente dalle contingenze politiche) con quell’ingenuità senza ombre che riponeva in essa - e parliamo di un numero imprecisato, con ogni probabilità enorme, di uomini e donne - parte delle aspettative di materializzazione di un vagheggiato Mondo Nuovo, ossia di uno spazio non solo geografico entro cui provare la tenuta dei limiti del sogno circa una completa realizzazione personale, ma pure di un luogo segreto entro cui nutrire l’ideale sempre puro, lo slancio originario della sua eterna promessa. Il più che verosimile venire meno di tale condizione, diciamo così, privilegiata - che rimonta, volendo, alle ragioni stesse che hanno nutrito la genesi del Grande Paese - è ascrivibile a numerosi fattori, non ultimo quello evocato da un’espressione di certo logora eppure ancora in grado di circoscrivere con ragionevole approssimazione i termini di una questione così stringente: quella di trionfo della modernità. Che la cosiddetta modernità, infatti, in virtù della propria irresistibile inerzia alla razionalizzazione abbia, col tempo, eroso, assimilandoli man mano, ampi tratti dei confini della capacità proiettiva (nel senso di immaginativa) del nostro quotidiano in relazione alle sue ambizioni e al suo destino individuale e collettivo tentando di surrogarla nell’esaltazione spregiudicata quanto di fondo irriflessiva dell’eterno presente con l’infaticabile promozione di un desiderio di stampo per lo più materialistico, è constatazione di verificabile evidenza, quindi difficilmente oppugnabile.  La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.
La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.
 La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.
La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.***
Il senso di spaesamento - non di rado venato di disgusto e rancore - delle giovani generazioni; la sorda ma non meno contundente impressione di progressiva espulsione avvertita da frange di quelle più adulte, sono solo i sintomi macroscopici di un disagio più capillare - materiale, psicologico, emotivo - che ormai nemmeno la consolidata frequentazione di un osteso benessere riesce, non si pretende a contenere ma neanche a dissimulare conducendo, per strade diverse purtuttavia affini, talvolta a una asprezza violenta, talaltre a una sorta di malmostosa rassegnazione o, ancora, a una apatica indifferenza, come pure a una flebile sebbene tenace aspettazione. In questa, che è una lacerazione anzitutto interiore, della quale è l’individuo in primis a valutarne sulla propria pelle l’estensione e la radicalità, si insinua il Cinema di un autore schivo ma avvertito e partecipe come Kelly Reichardt - classe 1964 - pronto a cogliere le durezze di una condizione sempre meno umana, quanto in grado di cernere i segni - per quanto esili, ambivalenti o, addirittura, per tanto senso comune, non remunerativi - che a tale abrasivo orientamento tentano di porre argine.
Del resto, questa curiosità/capacità di indagare senza preconcetti un-mondo-dentro-il-mondo, il mondo delle attese così spesso inconcludenti, delle frustrazioni irrisolte o irrisolvibili, delle speranze coraggiose ma malriposte come, per contro, delle consonanze imprevedibili, dei rifiati rubati alla consuetudine, della stramba purezza secreta da scampoli di marginalità oggigiorno nemmeno più censiti - facendo comunque salva la possibilità di una estrema riconciliazione nelle forme fluide, dolorosamente perseguite, magari, a mo’ di lascito di muti ripiegamenti e afflitte ma composte auto-limitazioni, di una fatale trascendenza del quotidiano - appartiene per prossimità originaria al termometro intimo americano, al suo spirito allo stesso tempo avventuroso e guardingo, brutale e ingenuo, avido e altruista, che uno dell’indole di Cormac McCarthy ha saputo con acume isolare (… dove cacciatori e taglialegna un tempo dormivano con gli stivali ai piedi alla luce morente dei loro mille fuochi e poi riprendevano il cammino, vecchi antenati teutonici con gli occhi accesi dal bagliore visionario di un’avidità sfrenata, ondate su ondate di violenti e folli col cervello pieno di equivalenti irreperibili di tutto ciò che fu, smilzi ariani col loro libercolo di scritti semitici decaduti che ridanno vita a tragedie e parabole là contenute, accecati e infiacchiti da una sete che nulla placa se non la restituzione all’oscurità assoluta) e con cui certo Cinema - quello della Reichardt, in particolare e per l’appunto - ha imparato a dialogare fin da subito, fin dagli echi autobiografici (non fosse che per i paraggi utilizzati, quelli natii della Contea di Dade, in Florida) e rapsodici (per l’alternanza ancora acerba, in sede espressiva, tra stasi intimiste, pause riflessive e subitanee accelerazioni delle linee narrative e relativi snodi) di un non convenzionale esordio, quale quello confezionato per River of grass (1994), vicenda in sottotono ma non meno sconcertante di un improbabile tentativo di liberazione sullo sfondo delle Everglades, approntato scommettendo su quel singolare tipo di inettitudine verso la vita patrimonio inesauribile della routine suburbana di tanti agglomerati a stelle e strisce, fatta di matrimoni nati inerti nonostante la prole (ossia, e per ironizzare, scevri, ad esempio, dell’inconveniente per cui l’abitudine prima o poi se ne appropri); di vaghi propositi ribellistici mescolati a istanze di riscatto personale ridotti a confusionari e goffi giri a vuoto: di maldestri colpi di testa perpetrati solo perché non si è in grado di stabilire un minimo comune denominatore tra gesti e conseguenze. La ronda di Cozy/Bowman e Ray Lee/Fassenden, compari pasticcioni in fuga da un quotidiano gramo - quello coniugale, per Cozy; uno vissuto da spiantato a carico della nonna, per Ray Lee - come poi da un omicidio di cui è dubbia la paternità oltreché l’effettiva esecuzione, offre più che altro alla Reichardt il destro per impratichirsi (qui, su un canovaccio ben collaudato a base di andirivieni e assestamenti tra le pieghe di una pseudo epopea criminale più subita che agita e umbratili detour interiori) con alcune leve psicologiche che via via verranno messe a fuoco sgrossando i lineamenti di un determinato personaggio ricorrente: un individuo (in specie donna) abitato da una inquietudine tanto indecifrabile nella sua travagliata gestazione (come che sia riconducibile, la prima, almeno in superficie, a un malessere che evoca sia l’inconsistenza oramai conclamata dei rapporti, sia il crescente senso di estraneità diffuso da un sistema socio-economico sempre più difficilmente distinguibile da un feudalesimo managerial-finanziario che a quei rapporti sottende), quanto irriducibile nella sua persistenza, posto di fronte a una serie di scelte che su tale inquietudine avrà ripercussioni significative. D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.
D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.
Del resto, questa curiosità/capacità di indagare senza preconcetti un-mondo-dentro-il-mondo, il mondo delle attese così spesso inconcludenti, delle frustrazioni irrisolte o irrisolvibili, delle speranze coraggiose ma malriposte come, per contro, delle consonanze imprevedibili, dei rifiati rubati alla consuetudine, della stramba purezza secreta da scampoli di marginalità oggigiorno nemmeno più censiti - facendo comunque salva la possibilità di una estrema riconciliazione nelle forme fluide, dolorosamente perseguite, magari, a mo’ di lascito di muti ripiegamenti e afflitte ma composte auto-limitazioni, di una fatale trascendenza del quotidiano - appartiene per prossimità originaria al termometro intimo americano, al suo spirito allo stesso tempo avventuroso e guardingo, brutale e ingenuo, avido e altruista, che uno dell’indole di Cormac McCarthy ha saputo con acume isolare (… dove cacciatori e taglialegna un tempo dormivano con gli stivali ai piedi alla luce morente dei loro mille fuochi e poi riprendevano il cammino, vecchi antenati teutonici con gli occhi accesi dal bagliore visionario di un’avidità sfrenata, ondate su ondate di violenti e folli col cervello pieno di equivalenti irreperibili di tutto ciò che fu, smilzi ariani col loro libercolo di scritti semitici decaduti che ridanno vita a tragedie e parabole là contenute, accecati e infiacchiti da una sete che nulla placa se non la restituzione all’oscurità assoluta) e con cui certo Cinema - quello della Reichardt, in particolare e per l’appunto - ha imparato a dialogare fin da subito, fin dagli echi autobiografici (non fosse che per i paraggi utilizzati, quelli natii della Contea di Dade, in Florida) e rapsodici (per l’alternanza ancora acerba, in sede espressiva, tra stasi intimiste, pause riflessive e subitanee accelerazioni delle linee narrative e relativi snodi) di un non convenzionale esordio, quale quello confezionato per River of grass (1994), vicenda in sottotono ma non meno sconcertante di un improbabile tentativo di liberazione sullo sfondo delle Everglades, approntato scommettendo su quel singolare tipo di inettitudine verso la vita patrimonio inesauribile della routine suburbana di tanti agglomerati a stelle e strisce, fatta di matrimoni nati inerti nonostante la prole (ossia, e per ironizzare, scevri, ad esempio, dell’inconveniente per cui l’abitudine prima o poi se ne appropri); di vaghi propositi ribellistici mescolati a istanze di riscatto personale ridotti a confusionari e goffi giri a vuoto: di maldestri colpi di testa perpetrati solo perché non si è in grado di stabilire un minimo comune denominatore tra gesti e conseguenze. La ronda di Cozy/Bowman e Ray Lee/Fassenden, compari pasticcioni in fuga da un quotidiano gramo - quello coniugale, per Cozy; uno vissuto da spiantato a carico della nonna, per Ray Lee - come poi da un omicidio di cui è dubbia la paternità oltreché l’effettiva esecuzione, offre più che altro alla Reichardt il destro per impratichirsi (qui, su un canovaccio ben collaudato a base di andirivieni e assestamenti tra le pieghe di una pseudo epopea criminale più subita che agita e umbratili detour interiori) con alcune leve psicologiche che via via verranno messe a fuoco sgrossando i lineamenti di un determinato personaggio ricorrente: un individuo (in specie donna) abitato da una inquietudine tanto indecifrabile nella sua travagliata gestazione (come che sia riconducibile, la prima, almeno in superficie, a un malessere che evoca sia l’inconsistenza oramai conclamata dei rapporti, sia il crescente senso di estraneità diffuso da un sistema socio-economico sempre più difficilmente distinguibile da un feudalesimo managerial-finanziario che a quei rapporti sottende), quanto irriducibile nella sua persistenza, posto di fronte a una serie di scelte che su tale inquietudine avrà ripercussioni significative.
 D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.
D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.***
Quanto detto si amplia e si precisa, modulando ovvie variazioni, già a partire dall’opera che segue, vale a dire Ode (1999) - mediometraggio in super 8 basato sul romanzo di Herman Raucher “Ode to Billy Joe”, a sua volta ispirato all’omonimo brano del ’67 di Bobby Gentry,  quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;
quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;  ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.
ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.
 quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;
quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;  ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.
ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.***
Indizio rivelatore in tal senso può essere considerato, per motivi diversi, il dittico comprendente due cortometraggi - l’uno dal titolo Then, a year (2001), l’altro a nome Travis (2004) - Già nel primo, infatti - un breve (14’) studio di montaggio per sequenze che alternano la suggestione di un teorico rapporto armonico tra i viventi sullo sfondo di fulgidi paesaggi naturali (si cominciano a vedere scorci di quel Nord Ovest americano che Kelly avrebbe setacciato, non solo metaforicamente, negli anni seguenti) a scene tratte da reportage televisivi inerenti il crimine (la regista ritrova, per l’occasione, la familiarità di argomenti già trattati - vd. “River of grass”- come echi di fatto ancora non sopiti relativi a parte di una giovinezza spesa assieme a genitori entrambi negli organici delle forze dell’ordine), a commento delle quali vengono riportati brani delle lettere scritte da Mary Kay Letourneau ai tempi della sua relazione proibita col minorenne Vili Faulaau (caso di cronaca, questo, verificatosi nella seconda metà degli anni Novanta e di una qual risonanza non solo negli Stati Uniti) - emerge con chiarezza la constatazione schietta ma non meno traumatica circa la trasformazione di un dualismo di fondo (in senso molto generale quello tra Natura e Cultura) in vera e propria frattura che sembra preludere a una netta presa di posizione, ovvero il pressante sospetto per cui se il nodo filosofico fondamentale - e, di conseguenza, il rovello espressivo, ossia il bivio cinematografico - è quello avvinto al bisogno di comprendere la legittimità se non, addirittura, la sostenibilità stessa dell’idea di un rapporto autentico dell’uomo con il mondo che è chiamato a sperimentare (e, tra l’altro, di gran parte del quale, oggigiorno, è pure artefice), il mondo della tarda modernità, quello, per intendersi, per lo più orbitante attorno a denaro, oggetti e immagini, allora la predetta opzione risulta azzardo sensato solo nel caso in cui la puntata è rivolta all’intimità e non alla collettività (intesa come mera aggregazione di interessi), alla cura e non alla dispersione (tendenza che avvicina Kelly a un’altra personalità poco accomodante dello scenario contemporaneo americano, Debra Granik), alla resistenza dignitosa e non alla realizzazione purchessia, cioè a una prospettiva che da una angolazione marginale riafferma il primato del tempo largo delle passioni (ovviamente non quelle ammannite dalla loro insistente caricatura pubblicitaria) su quello in costante astinenza dopaminica dei calcoli e dell’onnipervasivo qui-e-ora. D’altra parte e per certi aspetti, “Travis” (12’), il suo passo circolare, cadenzato sulla ripetizione in loop della durata di circa un minuto del compianto di una madre che non riesce a capacitarsi della perdita del figlio sullo scenario iracheno, non fa che estremizzare dal punto di vista linguistico lo iato già manifesto in “Then, a year” e il dolore frammisto a ogni contatto umano raccontato in “Ode”, giungendo a dissolverli in una manciata di immagini (forse persino appartenenti al patrimonio amatoriale della famiglia dello scomparso) dilatate ad arte alla consistenza di ammassi di colori che, senza posa, si inseguono e si sovrappongono amalgamandosi o dividendosi, in un impasto mutante talora in linea col brio imprevedibile degli acquerelli di Turner, talora in corrispondenza con i tagli netti di Rothko, a testimoniare come la frattura primaria cui abbiamo accennato riesca a farsi voragine di fronte al conflitto per eccellenza - la guerra - pura negazione che cancella qualunque istanza di comprensione e di visione, fino alla paralisi di una sofferenza che non può essere colmata ma, nutrendosi di scampoli fantasmatici o mnemonici, solo ripetuta nel vuoto.
***
Si sa: la vita, in specie quella professionale, è fatta anche di incontri. Uno di quelli importanti per Kelly Reichardt - e, come vedremo, non il solo - si è materializzato nella persona dello scrittore Jon Raymond, il sodalizio col quale condurrà alla realizzazione di ben quattro film (in elaborazione solitaria o in tandem). Il primo di essi è Old joy (2006), tratto proprio da uno dei racconti di Jon contenuto nella raccolta “Livability”, pre-testo letterario che, tra le altre cose, sancisce lo spostamento convinto del Cinema di Kelly nel Grande Ovest americano o, quantomeno, il suo concentrarsi sulle sollecitazioni esercitate dalle vastità naturali (e relativi silenzi, comunità minuscole, vite chissà quanto a fondo avvinte da un destino di impermeabile ripetizione) sul singolo che sceglie di immergervisi o si trova a subirlo. Nello specifico, ci troviamo in Oregon dove due amici, Mark/London e Kurt/Oldham (per dire gli incontri o i ritorni: Paul Oldham - citato qui come Will - è lo stesso che aveva composto la colonna sonora di “Ode” - vd. - tra l’altro uno in grado di ritagliarsi un posto d’onore nella tradizione della canzone americana con album del livello di “I see a darkness” - 1999 -) si ritrovano e decidono di passare una giornata del fine settimana insieme presso le sorgenti calde (Bagby Hot Springs) delle Cascade Mountains.  Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,
Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,  dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.
dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.
 Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,
Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,  dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.
dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.***
Abbandono e solitudine che permeano di sé - ma con maggiore insistenza e producendo, a voler sottilizzare, una precoce incrinatura nella fiducia concessa dal Cinema della regista al paesaggio americano come tramite di elezione per il trascendimento, quantunque momentaneo, dell’umano travaglio esistenziale - la parabola narrata in Wendy and Lucy (2008), opera che Kelly porta a termine (tra i produttori esecutivi è citato anche Todd Haynes, figura nota di un gruppo affiatato che ne sostiene da sempre l’itinerario artistico e tra cui vale la pena di ricordare, proprio in ragione della continuità del loro supporto, Larry Fessenden - già attore in “River of grass” -; quindi Susan A. Stoner, Anish e Rajen Savjani, Neil Kopp e Vincent Savino) curando insieme a Jon Raymond l’adattamento di un altro suo racconto, “Train choir”. A riprova di quanto accennato, già in via preliminare, un aspetto subito risalta: ciò che in “Old joy” - e vale a dire l’anonimato asettico connaturato alla coabitazione metropolitana, la schiacciante mediazione del do ut des del denaro, i loro addentellati fatti di indifferenza, sudditanza passiva a un novero di regole scritte e non, norme, precetti che, in teoria, dovrebbero qualificarne l’essenza ma a conti fatti sanciscono solo la sostanziale mancanza di umanità del sistema che individuano - era utilizzato come memento o basso continuo da provare a tenere a bada e, quando possibile, contrastare, non foss’altro, come visto, che per un fine settimana, in “Wendy and Lucy”, 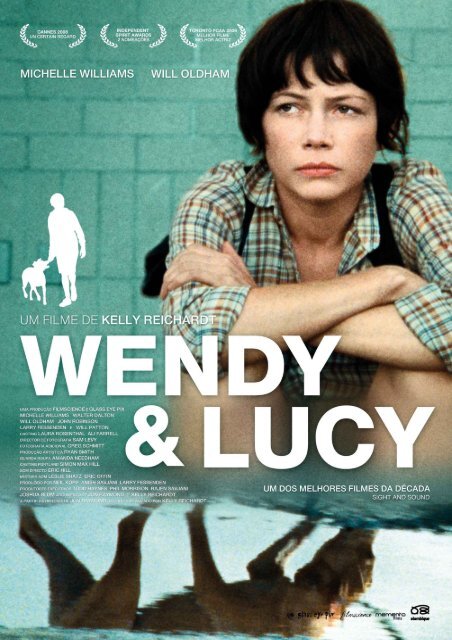 senza infingimenti o attese, assurge a contesto imprescindibile e pregnante che tutto approssima alla propria inerzia, pena l’emarginazione, la morte civile. Accediamo, in altre parole e in apertura di film, a una nuova rotazione di prospettiva, al cambiamento del punto di vista con cui inquadrare gli eventi - pochi, laconici e, per la loro conclamata invisibilità, ancor più dolorosi - centrati qui sulla individuazione di una condizione in potenza ostile o, quantomeno, disagiata (uno snodo ferroviario all’alba su cui comincia il periplo lento ma inesorabile del gigantesco risiko dei capitali in movimento introduce alla prevalenza di un ingranaggio in cui l’elemento artificiale detta, per mera sproporzione delle forze in campo, i principi, i ritmi e i limiti della convivenza, il senso e lo scopo della sua stessa plausibilità, risultando in conclusione vincente, simbolico nastro trasportatore che, nel caso, rispedirà al mittente la merce scaduta di nome Wendy), quanto invece, in “Old joy” (partecipe un mattino attutito dal canto degli uccelli e da sonnolente attività minime) latrice di congiunture non necessariamente impraticabili o funeste. In tal senso, il personaggio di Wendy Carroll (ancora un incontro fortunato per la Reichardt, ossia Michelle Williams - corpo minuto e viso pulito che nascondono, oltre a una naturale ritrosia, il contegno dignitoso di una garbata risolutezza - che ritroveremo protagonista di altre storie), ragazza in viaggio assieme alla cagnetta Lucy (sì, quella di “Old joy”, di cui veniamo a sapere essere un incrocio di taglia piccola tra un cane da caccia e un retriever) su una vecchia Honda Accord dell’88, soldi contati in tasca, in transito per l’Oregon alla volta dell’Alaska dove intende, secondo generici progetti, trovare lavoro, magari nell’industria ittica (“Là cercano gente”, dice più per prammatica che per convincimento), sembra prestarsi a modello per una automatica sovrapposizione tra le aspettative connesse a un altro ben noto feticcio della cultura yankee, a dire quello che indica nel viaggio lo strumento più a portata di mano per innescare un processo di rigenerazione personale e di riscatto, e la pletora di coloro che a vario titolo ha visto disattesa o tradita la sua promessa. Contrariamente a un immaginario cinematografico - e letterario - di grande spessore e rilevanza (pensiamo, per rimanere al punto, a tutto ciò che sta intorno a un termine come frontiera e alle implicazioni che esso sollecita per ciò che attiene a una ipotetica ridefinizione dell’individuo in riferimento alla sua mentalità, alla capacità di opporsi alle traversie, alla resistenza, anche fisica, di fronte a forze che non conosce o si rivelano riottose al confronto dialettico se non, banalmente, superiori), Wendy si colloca altresì in una posizione intermedia, molto più sfumata. Ovvero: la sua ricerca non è orientata a una precisa rivendicazione in grado di restituirle - mettiamo - qualcosa da cui si sente di esser stata ingiustamente tagliata fuori. Tantomeno persegue la fatidica seconda occasione (non avendo, con ogni probabilità, neanche mancato la prima). Il cuore del suo vagabondaggio, della sua placida adesione ai piaceri minuti di una esistenza raminga (i rari momenti in cui Wendy sorride e ha l’aria felice è quando gioca con Lucy al lancio e al riporto del bastone), è per molti aspetti affine a una ribellione poetica (per sua natura fragile, quindi in potenza destinata allo smacco, ancor di più se il mondo che dovrebbe, oltreché partorirla, sostenerla, un po’ come accadeva agli amanti infelici di “Ode”, considera la visione poetica delle cose poco più di un trastullo o di un vacuo velleitarismo), all’anywhere out of the world di baudelairiana memoria (A me sembra che starei sempre bene là dove non sono, e di questa questione di trasloco discuto di continuo con l’anima mia), in cui un animo sensibile - e quello di Wendy lo è - anela a un altrove che il prosaico rincorrersi dei giorni votato alla conversione materialistica di ciascuno dei suoi istanti non fa che deprimere, cioè, alla fine, rifiutare. L’intuizione interessante della Reichardt - e, prima ancora, di Raymond - sta quindi nel tentativo di misurare, spogliando le situazioni di qualunque orpello sociologico o strumentalmente polemico, allo stato dei fatti, ossia sulla soglia di una cruciale transizione storica - l’attuale - ciò che resta, non solo e non tanto delle aspirazioni dell’individuo ma dell’investimento passionale che alle predette aspirazioni dovrebbe sottendere per scongiurarne la retrocessione ad anodina accumulazione di esperienze. Se Wendy fugge da un grigiore fatto di mal tollerata prossimità con la sorella Deb/ O’Connell e il di lei marito Dan/Blash (ciò che a noi è dato di vedere a riprova dell’esistenza di questo legame è solo una breve e stanca conversazione telefonica), là, a Muncie, Indiana, cioè a miglia e miglia di distanza, non è per tastare il polso al sogno americano nella sua declinazione di successo e/o riconoscimento: quello o, meglio, il suo rovescio - e, chissà, nulla vieta di pensare anche per fattivo concorso - lo conosce fin troppo bene. A premerle, suggerisce la Reichardt, è l’idea, o l’ambizione o l’equivoco o il delirio, non importa - e, a insistere, è quasi una sfida di valenza politica, questa, una dichiarazione di intenti - di provare su di sé la tenuta della voglia di vivere il più possibile in ragione della propria natura (just be, direbbe Iggy Pop) all’interno di una realtà tarata - e ossessivamente propagandata - sul soddisfacimento dei desideri e dei sogni del singolo. La risposta a tale aut-aut implica, allo stesso tempo, una torsione della drammaturgia in “Wendy and Lucy” e l’emergere di una nota pessimista nel Cinema di Kelly, destinata a precisarsi nei film successivi fino a trovare precaria requie in un qual perplesso disincanto. Quello che però risulta chiaro al momento, e che Wendy sperimenta sulla sua pelle, è il progressivo scollamento dalla società-degli-uomini, i cui anaffettivi ma formalmente ineccepibili rituali la prostrano al limite dello sconcerto, ben oltre il sollievo regalato dalla presenza di Lucy e - quando anche questo verrà meno - dalla fatalistica premura del custode del parcheggio/Dalton (lo stesso che, sempre in rispetto dei regolamenti, l’aveva invitata ad allontanarsi dalla piazzola scena del suo primo pernottamento in auto) col quale instaurerà, alla fine, nonostante tutto, uno straccio di intesa che, dalla necessità (l’anziano guardiano offre il proprio telefono a Wendy per chiamare il canile dove si presume possa essere stata condotta Lucy dopo la sua evitabilissima scomparsa), si aprirà almeno alla condivisione di un laconico scetticismo (“C’è poco lavoro qua intorno, eh ?”, osserva Wendy. “Direi proprio di sì”, fa il tale. “Non riesco a capire cosa faccia la gente tutto il giorno. Prima c’era una fabbrica. Ora non c’è più niente”). Detto in maniera più semplice: la constatazione da fare e che, mano mano, per Wendy assume il sapore amaro della certezza, è che in un mondo in cui l’unico mezzo di interpretazione delle sue manifestazioni e dei suoi vincoli è il denaro, non si può vivere ma solo fallire, subire, patire, e tanto più inutilmente quanto più la subdola capacità di persuasione di quello non fa che blandire l’amor proprio e la vanità di ciascun individuo in ogni istante della giornata. Ecco, in sintesi, la ragione ultima della triste epopea capitata a Wendy in un sobborgo (presumibilmente) di Portland, privo di tutto ma non della razionalità sufficiente a isolare una persona, a renderla invisibile. Ed ecco perché appare quasi uno stupido calvario il suo sbattersi dall’acribia educata ma inflessibile di un posteggiatore, alla solerzia inquisitiva di un garzone di supermercato che, sorpresala nel furto assurdo, camusiano, di una scatoletta di cibo per cani - Wendy aveva i soldi per pagarla - dal quale cerca di venir fuori adducendo una giustificazione poco credibile fornendo, per sovrappiù, il tempo necessario a qualcuno di passaggio di impadronirsi di Lucy parcheggiata fuori ad aspettare, la apostrofa davanti al superiore come una che va punita senza esitazione, soprattutto perché “le regole vanno rispettate e bisogna dare l’esempio”. Stessa storia per la sollecitudine distante riservatale poi da una addetta del canile municipale o per la concretezza ragionieristica impartitale da un meccanico (interpretato da un assertivo Will Patton), e fingendo di sorvolare sulla burocratica inettitudine della Polizia locale, capace di rubarle mezza giornata di vita per accertamenti elementari non mancando di comminarle, a cose fatte e chiarito il mezzo equivoco, una multa di 50 $ senza una parola di conforto o di incoraggiamento, anzi invitandola tacitamente a togliersi dai piedi. Se, quindi, dal punto di vista della tipicità della storia raccontata “Wendy and Lucy”
senza infingimenti o attese, assurge a contesto imprescindibile e pregnante che tutto approssima alla propria inerzia, pena l’emarginazione, la morte civile. Accediamo, in altre parole e in apertura di film, a una nuova rotazione di prospettiva, al cambiamento del punto di vista con cui inquadrare gli eventi - pochi, laconici e, per la loro conclamata invisibilità, ancor più dolorosi - centrati qui sulla individuazione di una condizione in potenza ostile o, quantomeno, disagiata (uno snodo ferroviario all’alba su cui comincia il periplo lento ma inesorabile del gigantesco risiko dei capitali in movimento introduce alla prevalenza di un ingranaggio in cui l’elemento artificiale detta, per mera sproporzione delle forze in campo, i principi, i ritmi e i limiti della convivenza, il senso e lo scopo della sua stessa plausibilità, risultando in conclusione vincente, simbolico nastro trasportatore che, nel caso, rispedirà al mittente la merce scaduta di nome Wendy), quanto invece, in “Old joy” (partecipe un mattino attutito dal canto degli uccelli e da sonnolente attività minime) latrice di congiunture non necessariamente impraticabili o funeste. In tal senso, il personaggio di Wendy Carroll (ancora un incontro fortunato per la Reichardt, ossia Michelle Williams - corpo minuto e viso pulito che nascondono, oltre a una naturale ritrosia, il contegno dignitoso di una garbata risolutezza - che ritroveremo protagonista di altre storie), ragazza in viaggio assieme alla cagnetta Lucy (sì, quella di “Old joy”, di cui veniamo a sapere essere un incrocio di taglia piccola tra un cane da caccia e un retriever) su una vecchia Honda Accord dell’88, soldi contati in tasca, in transito per l’Oregon alla volta dell’Alaska dove intende, secondo generici progetti, trovare lavoro, magari nell’industria ittica (“Là cercano gente”, dice più per prammatica che per convincimento), sembra prestarsi a modello per una automatica sovrapposizione tra le aspettative connesse a un altro ben noto feticcio della cultura yankee, a dire quello che indica nel viaggio lo strumento più a portata di mano per innescare un processo di rigenerazione personale e di riscatto, e la pletora di coloro che a vario titolo ha visto disattesa o tradita la sua promessa. Contrariamente a un immaginario cinematografico - e letterario - di grande spessore e rilevanza (pensiamo, per rimanere al punto, a tutto ciò che sta intorno a un termine come frontiera e alle implicazioni che esso sollecita per ciò che attiene a una ipotetica ridefinizione dell’individuo in riferimento alla sua mentalità, alla capacità di opporsi alle traversie, alla resistenza, anche fisica, di fronte a forze che non conosce o si rivelano riottose al confronto dialettico se non, banalmente, superiori), Wendy si colloca altresì in una posizione intermedia, molto più sfumata. Ovvero: la sua ricerca non è orientata a una precisa rivendicazione in grado di restituirle - mettiamo - qualcosa da cui si sente di esser stata ingiustamente tagliata fuori. Tantomeno persegue la fatidica seconda occasione (non avendo, con ogni probabilità, neanche mancato la prima). Il cuore del suo vagabondaggio, della sua placida adesione ai piaceri minuti di una esistenza raminga (i rari momenti in cui Wendy sorride e ha l’aria felice è quando gioca con Lucy al lancio e al riporto del bastone), è per molti aspetti affine a una ribellione poetica (per sua natura fragile, quindi in potenza destinata allo smacco, ancor di più se il mondo che dovrebbe, oltreché partorirla, sostenerla, un po’ come accadeva agli amanti infelici di “Ode”, considera la visione poetica delle cose poco più di un trastullo o di un vacuo velleitarismo), all’anywhere out of the world di baudelairiana memoria (A me sembra che starei sempre bene là dove non sono, e di questa questione di trasloco discuto di continuo con l’anima mia), in cui un animo sensibile - e quello di Wendy lo è - anela a un altrove che il prosaico rincorrersi dei giorni votato alla conversione materialistica di ciascuno dei suoi istanti non fa che deprimere, cioè, alla fine, rifiutare. L’intuizione interessante della Reichardt - e, prima ancora, di Raymond - sta quindi nel tentativo di misurare, spogliando le situazioni di qualunque orpello sociologico o strumentalmente polemico, allo stato dei fatti, ossia sulla soglia di una cruciale transizione storica - l’attuale - ciò che resta, non solo e non tanto delle aspirazioni dell’individuo ma dell’investimento passionale che alle predette aspirazioni dovrebbe sottendere per scongiurarne la retrocessione ad anodina accumulazione di esperienze. Se Wendy fugge da un grigiore fatto di mal tollerata prossimità con la sorella Deb/ O’Connell e il di lei marito Dan/Blash (ciò che a noi è dato di vedere a riprova dell’esistenza di questo legame è solo una breve e stanca conversazione telefonica), là, a Muncie, Indiana, cioè a miglia e miglia di distanza, non è per tastare il polso al sogno americano nella sua declinazione di successo e/o riconoscimento: quello o, meglio, il suo rovescio - e, chissà, nulla vieta di pensare anche per fattivo concorso - lo conosce fin troppo bene. A premerle, suggerisce la Reichardt, è l’idea, o l’ambizione o l’equivoco o il delirio, non importa - e, a insistere, è quasi una sfida di valenza politica, questa, una dichiarazione di intenti - di provare su di sé la tenuta della voglia di vivere il più possibile in ragione della propria natura (just be, direbbe Iggy Pop) all’interno di una realtà tarata - e ossessivamente propagandata - sul soddisfacimento dei desideri e dei sogni del singolo. La risposta a tale aut-aut implica, allo stesso tempo, una torsione della drammaturgia in “Wendy and Lucy” e l’emergere di una nota pessimista nel Cinema di Kelly, destinata a precisarsi nei film successivi fino a trovare precaria requie in un qual perplesso disincanto. Quello che però risulta chiaro al momento, e che Wendy sperimenta sulla sua pelle, è il progressivo scollamento dalla società-degli-uomini, i cui anaffettivi ma formalmente ineccepibili rituali la prostrano al limite dello sconcerto, ben oltre il sollievo regalato dalla presenza di Lucy e - quando anche questo verrà meno - dalla fatalistica premura del custode del parcheggio/Dalton (lo stesso che, sempre in rispetto dei regolamenti, l’aveva invitata ad allontanarsi dalla piazzola scena del suo primo pernottamento in auto) col quale instaurerà, alla fine, nonostante tutto, uno straccio di intesa che, dalla necessità (l’anziano guardiano offre il proprio telefono a Wendy per chiamare il canile dove si presume possa essere stata condotta Lucy dopo la sua evitabilissima scomparsa), si aprirà almeno alla condivisione di un laconico scetticismo (“C’è poco lavoro qua intorno, eh ?”, osserva Wendy. “Direi proprio di sì”, fa il tale. “Non riesco a capire cosa faccia la gente tutto il giorno. Prima c’era una fabbrica. Ora non c’è più niente”). Detto in maniera più semplice: la constatazione da fare e che, mano mano, per Wendy assume il sapore amaro della certezza, è che in un mondo in cui l’unico mezzo di interpretazione delle sue manifestazioni e dei suoi vincoli è il denaro, non si può vivere ma solo fallire, subire, patire, e tanto più inutilmente quanto più la subdola capacità di persuasione di quello non fa che blandire l’amor proprio e la vanità di ciascun individuo in ogni istante della giornata. Ecco, in sintesi, la ragione ultima della triste epopea capitata a Wendy in un sobborgo (presumibilmente) di Portland, privo di tutto ma non della razionalità sufficiente a isolare una persona, a renderla invisibile. Ed ecco perché appare quasi uno stupido calvario il suo sbattersi dall’acribia educata ma inflessibile di un posteggiatore, alla solerzia inquisitiva di un garzone di supermercato che, sorpresala nel furto assurdo, camusiano, di una scatoletta di cibo per cani - Wendy aveva i soldi per pagarla - dal quale cerca di venir fuori adducendo una giustificazione poco credibile fornendo, per sovrappiù, il tempo necessario a qualcuno di passaggio di impadronirsi di Lucy parcheggiata fuori ad aspettare, la apostrofa davanti al superiore come una che va punita senza esitazione, soprattutto perché “le regole vanno rispettate e bisogna dare l’esempio”. Stessa storia per la sollecitudine distante riservatale poi da una addetta del canile municipale o per la concretezza ragionieristica impartitale da un meccanico (interpretato da un assertivo Will Patton), e fingendo di sorvolare sulla burocratica inettitudine della Polizia locale, capace di rubarle mezza giornata di vita per accertamenti elementari non mancando di comminarle, a cose fatte e chiarito il mezzo equivoco, una multa di 50 $ senza una parola di conforto o di incoraggiamento, anzi invitandola tacitamente a togliersi dai piedi. Se, quindi, dal punto di vista della tipicità della storia raccontata “Wendy and Lucy”  segna chiaramente un momento di riflessione utile a registrare lo smarrimento conseguente al sospetto di un graduale restringimento degli spazi concessi a una comunione che non sia solo il prodotto materiale delle voglie e degli opportunismi quotidiani, in ambito espressivo esso certifica il raggiungimento da parte della Reichardt di una maggiore compattezza stilistica - i primi piani diventano meno frequenti ma più caratterizzanti; la mdp si muove con morbida circospezione, anticipando e accompagnando il passo delle scene: il montaggio, sempre a cura dell’autrice, conferma l’innata scaltrezza con cui vengono avvicendati istanti di improvvise o nervose prese di posizione a intervalli meditativi o sospesi su un crinale narrativo o emotivo - Menzione a parte va inoltre riservata al lavoro sulla luce compiuto da Sam Levy, abile a giocare sulle cromie complementari comuni a un lucore tiepido diffuso sui visi e su specifici particolari urbani, e sulle tinte pastello o, talora, più decise, per gli interni e le alternanze del panorama. Come pure non è eccessivo ricordare la prova di Michelle Williams nei panni di Wendy, la sua mitezza misconosciuta da madonna laica (di quelle care, per dire, a certe intuizioni di Antonello da Messina), taciturna, quasi asessuata in bermuda e felpa, epperò disposta a tentare la via della comprensione nel dialogo e alla fine più incredula che delusa nel trovarsi invece di fronte sempre e solo griglie orarie, politiche aziendali, listini prezzi, preventivi di spesa e procedure legali. E quando ciò non accade, nel doversi adattare alla calma fittizia del paesaggio, qui ritratto nei suoi recessi più inospitali, di ambiente scampato per caso alle impellenze dell’industrializzazione e ridotto a ricettacolo del rancore e dell’emarginazione sociale (durante una notte passata nella vegetazione a ridosso della ferrovia Wendy trasalisce svegliandosi agli improperi di uno svitato che le racconta di come la gente lo guardi solo come fosse “immondizia”, percependo la sua “debolezza”). Evenienze che, in ogni caso, non le impediscono di forzare il suo destino - e quello del film - verso una direzione inaspettata e in parte ancora in linea con quello slancio spirituale ricettivo e magnanimo che Kelly aveva sempre concesso ai suoi personaggi a mo’ di argine da frapporre al caos secreto dal cosiddetto deserto del reale (® S. Zizek). Così, ritrovata Lucy presso una famiglia del posto che nel frattempo aveva deciso di prendersene cura, assume una dolcezza particolare, struggente, il gesto di rinuncia compiuto da Wendy, un sacrificio personale, l’ennesimo, mitigato stavolta da una sofferta bugia (“Tornerò a prenderti appena avrò un po’ di soldi”), nel tentativo di donare a un’altra creatura quella fatalità di felicità che a lei è preclusa o forse attingibile solo anywhere out of the world.
segna chiaramente un momento di riflessione utile a registrare lo smarrimento conseguente al sospetto di un graduale restringimento degli spazi concessi a una comunione che non sia solo il prodotto materiale delle voglie e degli opportunismi quotidiani, in ambito espressivo esso certifica il raggiungimento da parte della Reichardt di una maggiore compattezza stilistica - i primi piani diventano meno frequenti ma più caratterizzanti; la mdp si muove con morbida circospezione, anticipando e accompagnando il passo delle scene: il montaggio, sempre a cura dell’autrice, conferma l’innata scaltrezza con cui vengono avvicendati istanti di improvvise o nervose prese di posizione a intervalli meditativi o sospesi su un crinale narrativo o emotivo - Menzione a parte va inoltre riservata al lavoro sulla luce compiuto da Sam Levy, abile a giocare sulle cromie complementari comuni a un lucore tiepido diffuso sui visi e su specifici particolari urbani, e sulle tinte pastello o, talora, più decise, per gli interni e le alternanze del panorama. Come pure non è eccessivo ricordare la prova di Michelle Williams nei panni di Wendy, la sua mitezza misconosciuta da madonna laica (di quelle care, per dire, a certe intuizioni di Antonello da Messina), taciturna, quasi asessuata in bermuda e felpa, epperò disposta a tentare la via della comprensione nel dialogo e alla fine più incredula che delusa nel trovarsi invece di fronte sempre e solo griglie orarie, politiche aziendali, listini prezzi, preventivi di spesa e procedure legali. E quando ciò non accade, nel doversi adattare alla calma fittizia del paesaggio, qui ritratto nei suoi recessi più inospitali, di ambiente scampato per caso alle impellenze dell’industrializzazione e ridotto a ricettacolo del rancore e dell’emarginazione sociale (durante una notte passata nella vegetazione a ridosso della ferrovia Wendy trasalisce svegliandosi agli improperi di uno svitato che le racconta di come la gente lo guardi solo come fosse “immondizia”, percependo la sua “debolezza”). Evenienze che, in ogni caso, non le impediscono di forzare il suo destino - e quello del film - verso una direzione inaspettata e in parte ancora in linea con quello slancio spirituale ricettivo e magnanimo che Kelly aveva sempre concesso ai suoi personaggi a mo’ di argine da frapporre al caos secreto dal cosiddetto deserto del reale (® S. Zizek). Così, ritrovata Lucy presso una famiglia del posto che nel frattempo aveva deciso di prendersene cura, assume una dolcezza particolare, struggente, il gesto di rinuncia compiuto da Wendy, un sacrificio personale, l’ennesimo, mitigato stavolta da una sofferta bugia (“Tornerò a prenderti appena avrò un po’ di soldi”), nel tentativo di donare a un’altra creatura quella fatalità di felicità che a lei è preclusa o forse attingibile solo anywhere out of the world.
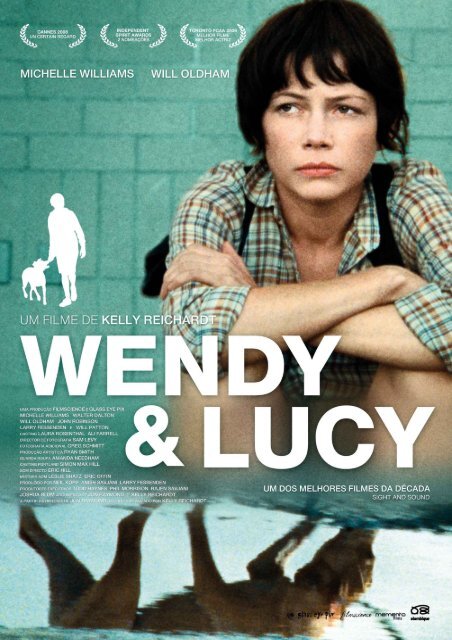 senza infingimenti o attese, assurge a contesto imprescindibile e pregnante che tutto approssima alla propria inerzia, pena l’emarginazione, la morte civile. Accediamo, in altre parole e in apertura di film, a una nuova rotazione di prospettiva, al cambiamento del punto di vista con cui inquadrare gli eventi - pochi, laconici e, per la loro conclamata invisibilità, ancor più dolorosi - centrati qui sulla individuazione di una condizione in potenza ostile o, quantomeno, disagiata (uno snodo ferroviario all’alba su cui comincia il periplo lento ma inesorabile del gigantesco risiko dei capitali in movimento introduce alla prevalenza di un ingranaggio in cui l’elemento artificiale detta, per mera sproporzione delle forze in campo, i principi, i ritmi e i limiti della convivenza, il senso e lo scopo della sua stessa plausibilità, risultando in conclusione vincente, simbolico nastro trasportatore che, nel caso, rispedirà al mittente la merce scaduta di nome Wendy), quanto invece, in “Old joy” (partecipe un mattino attutito dal canto degli uccelli e da sonnolente attività minime) latrice di congiunture non necessariamente impraticabili o funeste. In tal senso, il personaggio di Wendy Carroll (ancora un incontro fortunato per la Reichardt, ossia Michelle Williams - corpo minuto e viso pulito che nascondono, oltre a una naturale ritrosia, il contegno dignitoso di una garbata risolutezza - che ritroveremo protagonista di altre storie), ragazza in viaggio assieme alla cagnetta Lucy (sì, quella di “Old joy”, di cui veniamo a sapere essere un incrocio di taglia piccola tra un cane da caccia e un retriever) su una vecchia Honda Accord dell’88, soldi contati in tasca, in transito per l’Oregon alla volta dell’Alaska dove intende, secondo generici progetti, trovare lavoro, magari nell’industria ittica (“Là cercano gente”, dice più per prammatica che per convincimento), sembra prestarsi a modello per una automatica sovrapposizione tra le aspettative connesse a un altro ben noto feticcio della cultura yankee, a dire quello che indica nel viaggio lo strumento più a portata di mano per innescare un processo di rigenerazione personale e di riscatto, e la pletora di coloro che a vario titolo ha visto disattesa o tradita la sua promessa. Contrariamente a un immaginario cinematografico - e letterario - di grande spessore e rilevanza (pensiamo, per rimanere al punto, a tutto ciò che sta intorno a un termine come frontiera e alle implicazioni che esso sollecita per ciò che attiene a una ipotetica ridefinizione dell’individuo in riferimento alla sua mentalità, alla capacità di opporsi alle traversie, alla resistenza, anche fisica, di fronte a forze che non conosce o si rivelano riottose al confronto dialettico se non, banalmente, superiori), Wendy si colloca altresì in una posizione intermedia, molto più sfumata. Ovvero: la sua ricerca non è orientata a una precisa rivendicazione in grado di restituirle - mettiamo - qualcosa da cui si sente di esser stata ingiustamente tagliata fuori. Tantomeno persegue la fatidica seconda occasione (non avendo, con ogni probabilità, neanche mancato la prima). Il cuore del suo vagabondaggio, della sua placida adesione ai piaceri minuti di una esistenza raminga (i rari momenti in cui Wendy sorride e ha l’aria felice è quando gioca con Lucy al lancio e al riporto del bastone), è per molti aspetti affine a una ribellione poetica (per sua natura fragile, quindi in potenza destinata allo smacco, ancor di più se il mondo che dovrebbe, oltreché partorirla, sostenerla, un po’ come accadeva agli amanti infelici di “Ode”, considera la visione poetica delle cose poco più di un trastullo o di un vacuo velleitarismo), all’anywhere out of the world di baudelairiana memoria (A me sembra che starei sempre bene là dove non sono, e di questa questione di trasloco discuto di continuo con l’anima mia), in cui un animo sensibile - e quello di Wendy lo è - anela a un altrove che il prosaico rincorrersi dei giorni votato alla conversione materialistica di ciascuno dei suoi istanti non fa che deprimere, cioè, alla fine, rifiutare. L’intuizione interessante della Reichardt - e, prima ancora, di Raymond - sta quindi nel tentativo di misurare, spogliando le situazioni di qualunque orpello sociologico o strumentalmente polemico, allo stato dei fatti, ossia sulla soglia di una cruciale transizione storica - l’attuale - ciò che resta, non solo e non tanto delle aspirazioni dell’individuo ma dell’investimento passionale che alle predette aspirazioni dovrebbe sottendere per scongiurarne la retrocessione ad anodina accumulazione di esperienze. Se Wendy fugge da un grigiore fatto di mal tollerata prossimità con la sorella Deb/ O’Connell e il di lei marito Dan/Blash (ciò che a noi è dato di vedere a riprova dell’esistenza di questo legame è solo una breve e stanca conversazione telefonica), là, a Muncie, Indiana, cioè a miglia e miglia di distanza, non è per tastare il polso al sogno americano nella sua declinazione di successo e/o riconoscimento: quello o, meglio, il suo rovescio - e, chissà, nulla vieta di pensare anche per fattivo concorso - lo conosce fin troppo bene. A premerle, suggerisce la Reichardt, è l’idea, o l’ambizione o l’equivoco o il delirio, non importa - e, a insistere, è quasi una sfida di valenza politica, questa, una dichiarazione di intenti - di provare su di sé la tenuta della voglia di vivere il più possibile in ragione della propria natura (just be, direbbe Iggy Pop) all’interno di una realtà tarata - e ossessivamente propagandata - sul soddisfacimento dei desideri e dei sogni del singolo. La risposta a tale aut-aut implica, allo stesso tempo, una torsione della drammaturgia in “Wendy and Lucy” e l’emergere di una nota pessimista nel Cinema di Kelly, destinata a precisarsi nei film successivi fino a trovare precaria requie in un qual perplesso disincanto. Quello che però risulta chiaro al momento, e che Wendy sperimenta sulla sua pelle, è il progressivo scollamento dalla società-degli-uomini, i cui anaffettivi ma formalmente ineccepibili rituali la prostrano al limite dello sconcerto, ben oltre il sollievo regalato dalla presenza di Lucy e - quando anche questo verrà meno - dalla fatalistica premura del custode del parcheggio/Dalton (lo stesso che, sempre in rispetto dei regolamenti, l’aveva invitata ad allontanarsi dalla piazzola scena del suo primo pernottamento in auto) col quale instaurerà, alla fine, nonostante tutto, uno straccio di intesa che, dalla necessità (l’anziano guardiano offre il proprio telefono a Wendy per chiamare il canile dove si presume possa essere stata condotta Lucy dopo la sua evitabilissima scomparsa), si aprirà almeno alla condivisione di un laconico scetticismo (“C’è poco lavoro qua intorno, eh ?”, osserva Wendy. “Direi proprio di sì”, fa il tale. “Non riesco a capire cosa faccia la gente tutto il giorno. Prima c’era una fabbrica. Ora non c’è più niente”). Detto in maniera più semplice: la constatazione da fare e che, mano mano, per Wendy assume il sapore amaro della certezza, è che in un mondo in cui l’unico mezzo di interpretazione delle sue manifestazioni e dei suoi vincoli è il denaro, non si può vivere ma solo fallire, subire, patire, e tanto più inutilmente quanto più la subdola capacità di persuasione di quello non fa che blandire l’amor proprio e la vanità di ciascun individuo in ogni istante della giornata. Ecco, in sintesi, la ragione ultima della triste epopea capitata a Wendy in un sobborgo (presumibilmente) di Portland, privo di tutto ma non della razionalità sufficiente a isolare una persona, a renderla invisibile. Ed ecco perché appare quasi uno stupido calvario il suo sbattersi dall’acribia educata ma inflessibile di un posteggiatore, alla solerzia inquisitiva di un garzone di supermercato che, sorpresala nel furto assurdo, camusiano, di una scatoletta di cibo per cani - Wendy aveva i soldi per pagarla - dal quale cerca di venir fuori adducendo una giustificazione poco credibile fornendo, per sovrappiù, il tempo necessario a qualcuno di passaggio di impadronirsi di Lucy parcheggiata fuori ad aspettare, la apostrofa davanti al superiore come una che va punita senza esitazione, soprattutto perché “le regole vanno rispettate e bisogna dare l’esempio”. Stessa storia per la sollecitudine distante riservatale poi da una addetta del canile municipale o per la concretezza ragionieristica impartitale da un meccanico (interpretato da un assertivo Will Patton), e fingendo di sorvolare sulla burocratica inettitudine della Polizia locale, capace di rubarle mezza giornata di vita per accertamenti elementari non mancando di comminarle, a cose fatte e chiarito il mezzo equivoco, una multa di 50 $ senza una parola di conforto o di incoraggiamento, anzi invitandola tacitamente a togliersi dai piedi. Se, quindi, dal punto di vista della tipicità della storia raccontata “Wendy and Lucy”
senza infingimenti o attese, assurge a contesto imprescindibile e pregnante che tutto approssima alla propria inerzia, pena l’emarginazione, la morte civile. Accediamo, in altre parole e in apertura di film, a una nuova rotazione di prospettiva, al cambiamento del punto di vista con cui inquadrare gli eventi - pochi, laconici e, per la loro conclamata invisibilità, ancor più dolorosi - centrati qui sulla individuazione di una condizione in potenza ostile o, quantomeno, disagiata (uno snodo ferroviario all’alba su cui comincia il periplo lento ma inesorabile del gigantesco risiko dei capitali in movimento introduce alla prevalenza di un ingranaggio in cui l’elemento artificiale detta, per mera sproporzione delle forze in campo, i principi, i ritmi e i limiti della convivenza, il senso e lo scopo della sua stessa plausibilità, risultando in conclusione vincente, simbolico nastro trasportatore che, nel caso, rispedirà al mittente la merce scaduta di nome Wendy), quanto invece, in “Old joy” (partecipe un mattino attutito dal canto degli uccelli e da sonnolente attività minime) latrice di congiunture non necessariamente impraticabili o funeste. In tal senso, il personaggio di Wendy Carroll (ancora un incontro fortunato per la Reichardt, ossia Michelle Williams - corpo minuto e viso pulito che nascondono, oltre a una naturale ritrosia, il contegno dignitoso di una garbata risolutezza - che ritroveremo protagonista di altre storie), ragazza in viaggio assieme alla cagnetta Lucy (sì, quella di “Old joy”, di cui veniamo a sapere essere un incrocio di taglia piccola tra un cane da caccia e un retriever) su una vecchia Honda Accord dell’88, soldi contati in tasca, in transito per l’Oregon alla volta dell’Alaska dove intende, secondo generici progetti, trovare lavoro, magari nell’industria ittica (“Là cercano gente”, dice più per prammatica che per convincimento), sembra prestarsi a modello per una automatica sovrapposizione tra le aspettative connesse a un altro ben noto feticcio della cultura yankee, a dire quello che indica nel viaggio lo strumento più a portata di mano per innescare un processo di rigenerazione personale e di riscatto, e la pletora di coloro che a vario titolo ha visto disattesa o tradita la sua promessa. Contrariamente a un immaginario cinematografico - e letterario - di grande spessore e rilevanza (pensiamo, per rimanere al punto, a tutto ciò che sta intorno a un termine come frontiera e alle implicazioni che esso sollecita per ciò che attiene a una ipotetica ridefinizione dell’individuo in riferimento alla sua mentalità, alla capacità di opporsi alle traversie, alla resistenza, anche fisica, di fronte a forze che non conosce o si rivelano riottose al confronto dialettico se non, banalmente, superiori), Wendy si colloca altresì in una posizione intermedia, molto più sfumata. Ovvero: la sua ricerca non è orientata a una precisa rivendicazione in grado di restituirle - mettiamo - qualcosa da cui si sente di esser stata ingiustamente tagliata fuori. Tantomeno persegue la fatidica seconda occasione (non avendo, con ogni probabilità, neanche mancato la prima). Il cuore del suo vagabondaggio, della sua placida adesione ai piaceri minuti di una esistenza raminga (i rari momenti in cui Wendy sorride e ha l’aria felice è quando gioca con Lucy al lancio e al riporto del bastone), è per molti aspetti affine a una ribellione poetica (per sua natura fragile, quindi in potenza destinata allo smacco, ancor di più se il mondo che dovrebbe, oltreché partorirla, sostenerla, un po’ come accadeva agli amanti infelici di “Ode”, considera la visione poetica delle cose poco più di un trastullo o di un vacuo velleitarismo), all’anywhere out of the world di baudelairiana memoria (A me sembra che starei sempre bene là dove non sono, e di questa questione di trasloco discuto di continuo con l’anima mia), in cui un animo sensibile - e quello di Wendy lo è - anela a un altrove che il prosaico rincorrersi dei giorni votato alla conversione materialistica di ciascuno dei suoi istanti non fa che deprimere, cioè, alla fine, rifiutare. L’intuizione interessante della Reichardt - e, prima ancora, di Raymond - sta quindi nel tentativo di misurare, spogliando le situazioni di qualunque orpello sociologico o strumentalmente polemico, allo stato dei fatti, ossia sulla soglia di una cruciale transizione storica - l’attuale - ciò che resta, non solo e non tanto delle aspirazioni dell’individuo ma dell’investimento passionale che alle predette aspirazioni dovrebbe sottendere per scongiurarne la retrocessione ad anodina accumulazione di esperienze. Se Wendy fugge da un grigiore fatto di mal tollerata prossimità con la sorella Deb/ O’Connell e il di lei marito Dan/Blash (ciò che a noi è dato di vedere a riprova dell’esistenza di questo legame è solo una breve e stanca conversazione telefonica), là, a Muncie, Indiana, cioè a miglia e miglia di distanza, non è per tastare il polso al sogno americano nella sua declinazione di successo e/o riconoscimento: quello o, meglio, il suo rovescio - e, chissà, nulla vieta di pensare anche per fattivo concorso - lo conosce fin troppo bene. A premerle, suggerisce la Reichardt, è l’idea, o l’ambizione o l’equivoco o il delirio, non importa - e, a insistere, è quasi una sfida di valenza politica, questa, una dichiarazione di intenti - di provare su di sé la tenuta della voglia di vivere il più possibile in ragione della propria natura (just be, direbbe Iggy Pop) all’interno di una realtà tarata - e ossessivamente propagandata - sul soddisfacimento dei desideri e dei sogni del singolo. La risposta a tale aut-aut implica, allo stesso tempo, una torsione della drammaturgia in “Wendy and Lucy” e l’emergere di una nota pessimista nel Cinema di Kelly, destinata a precisarsi nei film successivi fino a trovare precaria requie in un qual perplesso disincanto. Quello che però risulta chiaro al momento, e che Wendy sperimenta sulla sua pelle, è il progressivo scollamento dalla società-degli-uomini, i cui anaffettivi ma formalmente ineccepibili rituali la prostrano al limite dello sconcerto, ben oltre il sollievo regalato dalla presenza di Lucy e - quando anche questo verrà meno - dalla fatalistica premura del custode del parcheggio/Dalton (lo stesso che, sempre in rispetto dei regolamenti, l’aveva invitata ad allontanarsi dalla piazzola scena del suo primo pernottamento in auto) col quale instaurerà, alla fine, nonostante tutto, uno straccio di intesa che, dalla necessità (l’anziano guardiano offre il proprio telefono a Wendy per chiamare il canile dove si presume possa essere stata condotta Lucy dopo la sua evitabilissima scomparsa), si aprirà almeno alla condivisione di un laconico scetticismo (“C’è poco lavoro qua intorno, eh ?”, osserva Wendy. “Direi proprio di sì”, fa il tale. “Non riesco a capire cosa faccia la gente tutto il giorno. Prima c’era una fabbrica. Ora non c’è più niente”). Detto in maniera più semplice: la constatazione da fare e che, mano mano, per Wendy assume il sapore amaro della certezza, è che in un mondo in cui l’unico mezzo di interpretazione delle sue manifestazioni e dei suoi vincoli è il denaro, non si può vivere ma solo fallire, subire, patire, e tanto più inutilmente quanto più la subdola capacità di persuasione di quello non fa che blandire l’amor proprio e la vanità di ciascun individuo in ogni istante della giornata. Ecco, in sintesi, la ragione ultima della triste epopea capitata a Wendy in un sobborgo (presumibilmente) di Portland, privo di tutto ma non della razionalità sufficiente a isolare una persona, a renderla invisibile. Ed ecco perché appare quasi uno stupido calvario il suo sbattersi dall’acribia educata ma inflessibile di un posteggiatore, alla solerzia inquisitiva di un garzone di supermercato che, sorpresala nel furto assurdo, camusiano, di una scatoletta di cibo per cani - Wendy aveva i soldi per pagarla - dal quale cerca di venir fuori adducendo una giustificazione poco credibile fornendo, per sovrappiù, il tempo necessario a qualcuno di passaggio di impadronirsi di Lucy parcheggiata fuori ad aspettare, la apostrofa davanti al superiore come una che va punita senza esitazione, soprattutto perché “le regole vanno rispettate e bisogna dare l’esempio”. Stessa storia per la sollecitudine distante riservatale poi da una addetta del canile municipale o per la concretezza ragionieristica impartitale da un meccanico (interpretato da un assertivo Will Patton), e fingendo di sorvolare sulla burocratica inettitudine della Polizia locale, capace di rubarle mezza giornata di vita per accertamenti elementari non mancando di comminarle, a cose fatte e chiarito il mezzo equivoco, una multa di 50 $ senza una parola di conforto o di incoraggiamento, anzi invitandola tacitamente a togliersi dai piedi. Se, quindi, dal punto di vista della tipicità della storia raccontata “Wendy and Lucy”  segna chiaramente un momento di riflessione utile a registrare lo smarrimento conseguente al sospetto di un graduale restringimento degli spazi concessi a una comunione che non sia solo il prodotto materiale delle voglie e degli opportunismi quotidiani, in ambito espressivo esso certifica il raggiungimento da parte della Reichardt di una maggiore compattezza stilistica - i primi piani diventano meno frequenti ma più caratterizzanti; la mdp si muove con morbida circospezione, anticipando e accompagnando il passo delle scene: il montaggio, sempre a cura dell’autrice, conferma l’innata scaltrezza con cui vengono avvicendati istanti di improvvise o nervose prese di posizione a intervalli meditativi o sospesi su un crinale narrativo o emotivo - Menzione a parte va inoltre riservata al lavoro sulla luce compiuto da Sam Levy, abile a giocare sulle cromie complementari comuni a un lucore tiepido diffuso sui visi e su specifici particolari urbani, e sulle tinte pastello o, talora, più decise, per gli interni e le alternanze del panorama. Come pure non è eccessivo ricordare la prova di Michelle Williams nei panni di Wendy, la sua mitezza misconosciuta da madonna laica (di quelle care, per dire, a certe intuizioni di Antonello da Messina), taciturna, quasi asessuata in bermuda e felpa, epperò disposta a tentare la via della comprensione nel dialogo e alla fine più incredula che delusa nel trovarsi invece di fronte sempre e solo griglie orarie, politiche aziendali, listini prezzi, preventivi di spesa e procedure legali. E quando ciò non accade, nel doversi adattare alla calma fittizia del paesaggio, qui ritratto nei suoi recessi più inospitali, di ambiente scampato per caso alle impellenze dell’industrializzazione e ridotto a ricettacolo del rancore e dell’emarginazione sociale (durante una notte passata nella vegetazione a ridosso della ferrovia Wendy trasalisce svegliandosi agli improperi di uno svitato che le racconta di come la gente lo guardi solo come fosse “immondizia”, percependo la sua “debolezza”). Evenienze che, in ogni caso, non le impediscono di forzare il suo destino - e quello del film - verso una direzione inaspettata e in parte ancora in linea con quello slancio spirituale ricettivo e magnanimo che Kelly aveva sempre concesso ai suoi personaggi a mo’ di argine da frapporre al caos secreto dal cosiddetto deserto del reale (® S. Zizek). Così, ritrovata Lucy presso una famiglia del posto che nel frattempo aveva deciso di prendersene cura, assume una dolcezza particolare, struggente, il gesto di rinuncia compiuto da Wendy, un sacrificio personale, l’ennesimo, mitigato stavolta da una sofferta bugia (“Tornerò a prenderti appena avrò un po’ di soldi”), nel tentativo di donare a un’altra creatura quella fatalità di felicità che a lei è preclusa o forse attingibile solo anywhere out of the world.
segna chiaramente un momento di riflessione utile a registrare lo smarrimento conseguente al sospetto di un graduale restringimento degli spazi concessi a una comunione che non sia solo il prodotto materiale delle voglie e degli opportunismi quotidiani, in ambito espressivo esso certifica il raggiungimento da parte della Reichardt di una maggiore compattezza stilistica - i primi piani diventano meno frequenti ma più caratterizzanti; la mdp si muove con morbida circospezione, anticipando e accompagnando il passo delle scene: il montaggio, sempre a cura dell’autrice, conferma l’innata scaltrezza con cui vengono avvicendati istanti di improvvise o nervose prese di posizione a intervalli meditativi o sospesi su un crinale narrativo o emotivo - Menzione a parte va inoltre riservata al lavoro sulla luce compiuto da Sam Levy, abile a giocare sulle cromie complementari comuni a un lucore tiepido diffuso sui visi e su specifici particolari urbani, e sulle tinte pastello o, talora, più decise, per gli interni e le alternanze del panorama. Come pure non è eccessivo ricordare la prova di Michelle Williams nei panni di Wendy, la sua mitezza misconosciuta da madonna laica (di quelle care, per dire, a certe intuizioni di Antonello da Messina), taciturna, quasi asessuata in bermuda e felpa, epperò disposta a tentare la via della comprensione nel dialogo e alla fine più incredula che delusa nel trovarsi invece di fronte sempre e solo griglie orarie, politiche aziendali, listini prezzi, preventivi di spesa e procedure legali. E quando ciò non accade, nel doversi adattare alla calma fittizia del paesaggio, qui ritratto nei suoi recessi più inospitali, di ambiente scampato per caso alle impellenze dell’industrializzazione e ridotto a ricettacolo del rancore e dell’emarginazione sociale (durante una notte passata nella vegetazione a ridosso della ferrovia Wendy trasalisce svegliandosi agli improperi di uno svitato che le racconta di come la gente lo guardi solo come fosse “immondizia”, percependo la sua “debolezza”). Evenienze che, in ogni caso, non le impediscono di forzare il suo destino - e quello del film - verso una direzione inaspettata e in parte ancora in linea con quello slancio spirituale ricettivo e magnanimo che Kelly aveva sempre concesso ai suoi personaggi a mo’ di argine da frapporre al caos secreto dal cosiddetto deserto del reale (® S. Zizek). Così, ritrovata Lucy presso una famiglia del posto che nel frattempo aveva deciso di prendersene cura, assume una dolcezza particolare, struggente, il gesto di rinuncia compiuto da Wendy, un sacrificio personale, l’ennesimo, mitigato stavolta da una sofferta bugia (“Tornerò a prenderti appena avrò un po’ di soldi”), nel tentativo di donare a un’altra creatura quella fatalità di felicità che a lei è preclusa o forse attingibile solo anywhere out of the world.***
Rigore espressivo è un termine impegnativo, per altro subdolamente incline a trasformarsi in zavorra concettuale allorché adoperato come grimaldello di comodo. Eppure è complicato astenersi da un simile accorgimento retorico al cospetto di un’opera come Meek’s cutoff (2010), che Kelly realizza affidandosi ancora una volta - la terza - alla scrittura di Jon Raymond. Rigore che, a guardar bene, si rapprende però attorno a uno stato d’animo che, per la prima volta, intride l’intreccio di una retrospettiva cupezza ammonitrice, figlia di un fatalismo poco o punto clemente - anzi, a suo modo primigenio, impenetrabile e occhiuto - lungi, per dire, tanto dalla comunicativa ingenua di “Old joy”, quanto dalla demoralizzazione smarrita di “Wendy and Lucy”. Il Cinema della Reichardt, in altre parole, con “Meek’s cutoff” - western-non-western privo com’è di eroi, orfano di qualunque epos (men che mai quello della promise land, nel caso inesistente o, è lo stesso, irraggiungibile, come sottolineato pure dagli Steely Dan: No marigolds in the promise land/There’s a hole in the ground/Where they used to grow…), da quello delle esplorazioni nel cuore della wilderness, a quello del destino manifesto del bipede bianco guidato dal suo dio (quello degregoriano che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia) alla conquista di tutto ciò che in nome di questi egli è sicuro gli spetti, passando per il mito fondativo dell’uomo-con-la-pistola  che esercita e impone la propria volontà anche attraverso la violenza - affronta il suo redde rationem al modo di non potersi esimere dall’interrogarsi circa i limiti dell’esperienza umana come concorso di contraddizioni forse affatto componibili, neanche in rapporto alla fatica di abitare il mondo al passo di un ritrovato senso di equilibrio nella precarietà, di armonia parziale nell’evidente finitudine del suo tempo e dei suoi atti (vedi alcuni momenti di “River of grass” ma soprattutto di “Old joy”), appoggiando la legittimità - e l’irriducibilità - del proprio assunto sulle spalle larghe della Storia, sulla sedimentazione progressiva dei suoi episodi, così spesso compatibili con una lettura che li addita simili a sentenze severe. Il motivo occasionale di “Meek’s cutoff” retrodata, appunto, a un accidente del passato, a una singolare epopea realmente consumatasi tra la primavera e l’estate del 1845 sul quadrante nord-occidentale del territorio americano (verosimilmente nell’area interessata dall’Oregon Trail - sentiero di migrazione utilizzato dalle carovane di coloni in cerca di migliori opportunità a Ovest, tra Missouri, Kansas, Nebraska, attraverso Wyoming e Idaho, fino in Oregon -), nella finzione ristretto a un pugno di famiglie - tre, per l’esattezza - sotto l’egida del trapper e scout Stephen Meek/Greenwood, deciso a intraprendere una scorciatoia (quella del titolo) da lui in precedenza aperta (1842) che prevede, con l’attraversamento dell’Oregon Desert, un taglio consistente al tragitto imposto ai convogli (i cosiddetti wagon trains) con carri (i prairie shooners) in direzione di una delle mete di elezione del tempo, i pascoli e le pianure del Nord-Ovest, in specie quelli della Willamette Valley (estensione - per ribadire i ricorsi reichardtiani - circondata da quelle Cascade Mountains già obiettivo dei protagonisti di “Old joy” - vd. -), traguardo finale della sparuta compagine del film. In una regione selvaggia, per ampi segmenti ancora vergine (ricordiamo che gli Stati Uniti dell’epoca erano poco più di una nazione appena nata in cui la conoscenza delle sue zone più periferiche - e relativa pianificazione delle vie di comunicazione - era tutta da completare), dimora secolare di tribù indigene di norma ostili, tenta, come detto, di farsi strada verso un ipotetico futuro il drappello formato da un barbuto apripista - pittoresco incrocio tra un cowboy e un cacciatore di pelli, uomo-dalle-mille-avventure a cui non è estraneo il tono paradossale/istrionico (“Non ci siamo persi. Stiamo solo cercando la strada”, recita alle insistite obiezioni dei suoi dante causa), come quello ispirato per magnificare i personali trascorsi - e da tre esigui gruppi familiari, quello dei Tetherow, Emily e Soloman (altri ricorsi: ritroviamo tanto Wendy Williams che Will Patton); quello dei Gately, Millie e Thomas (nuove entrate, invece, per Zoe Kazan e Paul Dano), e quello dei White, Glory/Henderson, William/Huff e il piccolo Jimmy/Nelson. L’incedere dell’anabasi, escluso l’abbrivio dedicato all’approvvigionamento di acqua durante la pausa che introduce al guado di un fiume, è da subito stentato, penoso quasi (venendo incontro, anche se tendenzialmente per contrasto, a una delle numerose affermazioni fatte da Thoreau riguardo il lento ma inesorabile inaridimento del legame tra l’uomo e l’habitat che ne consente la sopravvivenza: La vera semplicità e nudità della vita dell’uomo nelle età primitive implicavano questo vantaggio, per lo meno: lasciavano l’uomo ospite della natura. Quando si era ristorato con cibo e con sonno, egli meditava nuovamente il suo viaggio. Dimorava, per dir così, sotto una tenda in questo mondo, e varcava le valli o attraversava le pianure o saliva sulle sommità dei monti. Ma, ahimè !, gli uomini ora sono diventati strumenti dei loro strumenti. L’uomo che quand’era affamato coglieva i frutti liberamente, è diventato contadino; e colui che, per riposare si stendeva sotto un albero, è diventato il guardiano della propria casa. Ora non ci accampiamo più per la notte, ma invece ci siamo piantati sulla terra e abbiamo dimenticato il cielo. Abbiamo adottato il cristianesimo semplicemente come un migliore metodo di agricoltura). Ovvero il paesaggio mostra presto il suo vero volto di luogo inospitale, come infastidito dalla presenza importuna degli uomini, latore di una diffidenza originaria che riecheggia nei brani biblici affidati alla lettura a voce alta di Jimmy (Col sudore della fronte guadagnerai il pane, finché tornerai alla terra. Perché dalla terra provieni, di polvere sei fatto. E nella polvere tornerai) e man mano determina la costruzione delle inquadrature quanto l’ampiezza dei piani di ripresa. Quasi oblique e un tanto scentrate un certo numero delle prime, in corrispondenza di movimenti della mdp che tendono a sottolineare con sottile perfidia il procedere macchinoso e sostanzialmente alla cieca del gruppo (i suoi gesti resi goffi dagli abiti pesanti e rallentati dalla sabbia e dal sole) nella incipiente desolazione circostante; di preferenza giocata sulla lontananza la seconda, con le silhouette dei protagonisti schiacciate da una distanza che ne certifica al tempo l’insignificanza della condizione e la vacuità delle pretese, ossia, di base, il distacco da un mondo bene in grado di fare a meno di loro, come evoca spietatamente il contenuto del già citato testo sacro, non a caso emanazione del dio impassibile, perché austero, dell’Antico Testamento. Di conseguenza - sembra constatare Kelly - anche l’ipotesi di una trascendenza esperibile sfuma o si riduce a beffarda illusione, con l’aggravante di un precedente storico inutilizzato come monito per il domani. Nel senso che ciò che, almeno fino a “Old joy”, prova a configurarsi come sforzo, per quanto in partenza esposto all’equivoco e al tradimento, tuttavia interno a un orizzonte che non si sottrae al desiderio di superamento delle angustie dell’hic et nunc, di quella consuetudine avvilente che trova nello schema della ripetizione il principio della propria indistruttibilità, in “Meek’s cutoff” diventa il riproporsi di un estenuante girare a vuoto (il film può essere visto come la cronistoria di un tragitto circolare intervallato dalle soste imposte dal ritmo circadiano: in mezzo solo i gesti della resistenza quotidiana e le poche parole di sconcerto o disperata insofferenza verso l’inconcludente peregrinare di Meek): nel deserto, a conti fatti più grande della voglia stessa di attraversarlo; sotto il sole che non concede scampo (William crolla sfinito al termine di sistematiche privazioni indotte dalla carenza di cibo e dalla marce forzate); tra la polvere che si insinua sotto e dentro tessuti dalla foggia rigida e dal taglio fin troppo formale; alla ricerca di acqua che non basta mai; nel cigolio monotono dei carri, unico commento a un’inerzia immune anche al suono; attorno a una vegetazione spoglia e ad alture che sembrano tutte uguali, fino alla conclusione presso un albero macilento che segna più il confine della prostrazione che la meraviglia di un nuovo inizio. In generale, nei meandri di un frangente esistenziale la cui singolarità e drammaticità rischia di continuo di regredire a mera iperbole linguistica, tanta è la crudezza della sua essenza. E anche durante i rari momenti di una esperienza così impegnativa e frustrante da prevedere quasi suo malgrado istanti di stremata dolcezza (la condivisione serale, davanti al fuoco dell’ennesimo accampamento, di razionate vettovaglie; la disponibilità di Emily a ricucire il mocassino slabbrato dell’Indiano ostaggio/Roudeau al fine di stabilire un simulacro di rapporto con l’Altro - oltreché carpirne l’accondiscendenza in modo da penetrarne la più accurata conoscenza del territorio -), Kelly suggerisce che sono la fatalità e la contingenza a prevalere (varie volte la carovana è costretta a tornare sui propri passi o ad aggirare ostacoli naturali che Meek non conosce o non è stato in grado di prevedere; la transizione di uno dei carri entro una depressione rocciosa si risolve in un disastro, suscitando tanto la trattenuta ilarità dell’Indiano quanto l’ira di Meek e la contro-reazione ferma di Emily). E’ quel senso di negazione e inutilità, tutt’uno con un paesaggio scabro, silenzioso e ostinato (mai così lontano, per fare un esempio, dai primitivi stupori malickiani), con crepuscoli rapidi e scostanti, preludi di oscurità piene e compatte, così aderenti ai corpi da lasciarli emergere alla luce solo di quando in quando, che circoscrive e ridefinisce l’ambito del possibile, in un avvitamento di natura difensiva destinato a rimanere nel Cinema della regista della Florida come testimonianza di una aporia svelatasi tale mano mano che venivano saggiati gli estremi di un sentire così poco in sintonia con il tono-generale-del-mondo al punto da lasciar balenare qua e là i segni di una umanissima stanchezza venata di delusione, a chiudere, non solo idealmente, il periplo senza esito di Wendy in “Wendy and Lucy”,
che esercita e impone la propria volontà anche attraverso la violenza - affronta il suo redde rationem al modo di non potersi esimere dall’interrogarsi circa i limiti dell’esperienza umana come concorso di contraddizioni forse affatto componibili, neanche in rapporto alla fatica di abitare il mondo al passo di un ritrovato senso di equilibrio nella precarietà, di armonia parziale nell’evidente finitudine del suo tempo e dei suoi atti (vedi alcuni momenti di “River of grass” ma soprattutto di “Old joy”), appoggiando la legittimità - e l’irriducibilità - del proprio assunto sulle spalle larghe della Storia, sulla sedimentazione progressiva dei suoi episodi, così spesso compatibili con una lettura che li addita simili a sentenze severe. Il motivo occasionale di “Meek’s cutoff” retrodata, appunto, a un accidente del passato, a una singolare epopea realmente consumatasi tra la primavera e l’estate del 1845 sul quadrante nord-occidentale del territorio americano (verosimilmente nell’area interessata dall’Oregon Trail - sentiero di migrazione utilizzato dalle carovane di coloni in cerca di migliori opportunità a Ovest, tra Missouri, Kansas, Nebraska, attraverso Wyoming e Idaho, fino in Oregon -), nella finzione ristretto a un pugno di famiglie - tre, per l’esattezza - sotto l’egida del trapper e scout Stephen Meek/Greenwood, deciso a intraprendere una scorciatoia (quella del titolo) da lui in precedenza aperta (1842) che prevede, con l’attraversamento dell’Oregon Desert, un taglio consistente al tragitto imposto ai convogli (i cosiddetti wagon trains) con carri (i prairie shooners) in direzione di una delle mete di elezione del tempo, i pascoli e le pianure del Nord-Ovest, in specie quelli della Willamette Valley (estensione - per ribadire i ricorsi reichardtiani - circondata da quelle Cascade Mountains già obiettivo dei protagonisti di “Old joy” - vd. -), traguardo finale della sparuta compagine del film. In una regione selvaggia, per ampi segmenti ancora vergine (ricordiamo che gli Stati Uniti dell’epoca erano poco più di una nazione appena nata in cui la conoscenza delle sue zone più periferiche - e relativa pianificazione delle vie di comunicazione - era tutta da completare), dimora secolare di tribù indigene di norma ostili, tenta, come detto, di farsi strada verso un ipotetico futuro il drappello formato da un barbuto apripista - pittoresco incrocio tra un cowboy e un cacciatore di pelli, uomo-dalle-mille-avventure a cui non è estraneo il tono paradossale/istrionico (“Non ci siamo persi. Stiamo solo cercando la strada”, recita alle insistite obiezioni dei suoi dante causa), come quello ispirato per magnificare i personali trascorsi - e da tre esigui gruppi familiari, quello dei Tetherow, Emily e Soloman (altri ricorsi: ritroviamo tanto Wendy Williams che Will Patton); quello dei Gately, Millie e Thomas (nuove entrate, invece, per Zoe Kazan e Paul Dano), e quello dei White, Glory/Henderson, William/Huff e il piccolo Jimmy/Nelson. L’incedere dell’anabasi, escluso l’abbrivio dedicato all’approvvigionamento di acqua durante la pausa che introduce al guado di un fiume, è da subito stentato, penoso quasi (venendo incontro, anche se tendenzialmente per contrasto, a una delle numerose affermazioni fatte da Thoreau riguardo il lento ma inesorabile inaridimento del legame tra l’uomo e l’habitat che ne consente la sopravvivenza: La vera semplicità e nudità della vita dell’uomo nelle età primitive implicavano questo vantaggio, per lo meno: lasciavano l’uomo ospite della natura. Quando si era ristorato con cibo e con sonno, egli meditava nuovamente il suo viaggio. Dimorava, per dir così, sotto una tenda in questo mondo, e varcava le valli o attraversava le pianure o saliva sulle sommità dei monti. Ma, ahimè !, gli uomini ora sono diventati strumenti dei loro strumenti. L’uomo che quand’era affamato coglieva i frutti liberamente, è diventato contadino; e colui che, per riposare si stendeva sotto un albero, è diventato il guardiano della propria casa. Ora non ci accampiamo più per la notte, ma invece ci siamo piantati sulla terra e abbiamo dimenticato il cielo. Abbiamo adottato il cristianesimo semplicemente come un migliore metodo di agricoltura). Ovvero il paesaggio mostra presto il suo vero volto di luogo inospitale, come infastidito dalla presenza importuna degli uomini, latore di una diffidenza originaria che riecheggia nei brani biblici affidati alla lettura a voce alta di Jimmy (Col sudore della fronte guadagnerai il pane, finché tornerai alla terra. Perché dalla terra provieni, di polvere sei fatto. E nella polvere tornerai) e man mano determina la costruzione delle inquadrature quanto l’ampiezza dei piani di ripresa. Quasi oblique e un tanto scentrate un certo numero delle prime, in corrispondenza di movimenti della mdp che tendono a sottolineare con sottile perfidia il procedere macchinoso e sostanzialmente alla cieca del gruppo (i suoi gesti resi goffi dagli abiti pesanti e rallentati dalla sabbia e dal sole) nella incipiente desolazione circostante; di preferenza giocata sulla lontananza la seconda, con le silhouette dei protagonisti schiacciate da una distanza che ne certifica al tempo l’insignificanza della condizione e la vacuità delle pretese, ossia, di base, il distacco da un mondo bene in grado di fare a meno di loro, come evoca spietatamente il contenuto del già citato testo sacro, non a caso emanazione del dio impassibile, perché austero, dell’Antico Testamento. Di conseguenza - sembra constatare Kelly - anche l’ipotesi di una trascendenza esperibile sfuma o si riduce a beffarda illusione, con l’aggravante di un precedente storico inutilizzato come monito per il domani. Nel senso che ciò che, almeno fino a “Old joy”, prova a configurarsi come sforzo, per quanto in partenza esposto all’equivoco e al tradimento, tuttavia interno a un orizzonte che non si sottrae al desiderio di superamento delle angustie dell’hic et nunc, di quella consuetudine avvilente che trova nello schema della ripetizione il principio della propria indistruttibilità, in “Meek’s cutoff” diventa il riproporsi di un estenuante girare a vuoto (il film può essere visto come la cronistoria di un tragitto circolare intervallato dalle soste imposte dal ritmo circadiano: in mezzo solo i gesti della resistenza quotidiana e le poche parole di sconcerto o disperata insofferenza verso l’inconcludente peregrinare di Meek): nel deserto, a conti fatti più grande della voglia stessa di attraversarlo; sotto il sole che non concede scampo (William crolla sfinito al termine di sistematiche privazioni indotte dalla carenza di cibo e dalla marce forzate); tra la polvere che si insinua sotto e dentro tessuti dalla foggia rigida e dal taglio fin troppo formale; alla ricerca di acqua che non basta mai; nel cigolio monotono dei carri, unico commento a un’inerzia immune anche al suono; attorno a una vegetazione spoglia e ad alture che sembrano tutte uguali, fino alla conclusione presso un albero macilento che segna più il confine della prostrazione che la meraviglia di un nuovo inizio. In generale, nei meandri di un frangente esistenziale la cui singolarità e drammaticità rischia di continuo di regredire a mera iperbole linguistica, tanta è la crudezza della sua essenza. E anche durante i rari momenti di una esperienza così impegnativa e frustrante da prevedere quasi suo malgrado istanti di stremata dolcezza (la condivisione serale, davanti al fuoco dell’ennesimo accampamento, di razionate vettovaglie; la disponibilità di Emily a ricucire il mocassino slabbrato dell’Indiano ostaggio/Roudeau al fine di stabilire un simulacro di rapporto con l’Altro - oltreché carpirne l’accondiscendenza in modo da penetrarne la più accurata conoscenza del territorio -), Kelly suggerisce che sono la fatalità e la contingenza a prevalere (varie volte la carovana è costretta a tornare sui propri passi o ad aggirare ostacoli naturali che Meek non conosce o non è stato in grado di prevedere; la transizione di uno dei carri entro una depressione rocciosa si risolve in un disastro, suscitando tanto la trattenuta ilarità dell’Indiano quanto l’ira di Meek e la contro-reazione ferma di Emily). E’ quel senso di negazione e inutilità, tutt’uno con un paesaggio scabro, silenzioso e ostinato (mai così lontano, per fare un esempio, dai primitivi stupori malickiani), con crepuscoli rapidi e scostanti, preludi di oscurità piene e compatte, così aderenti ai corpi da lasciarli emergere alla luce solo di quando in quando, che circoscrive e ridefinisce l’ambito del possibile, in un avvitamento di natura difensiva destinato a rimanere nel Cinema della regista della Florida come testimonianza di una aporia svelatasi tale mano mano che venivano saggiati gli estremi di un sentire così poco in sintonia con il tono-generale-del-mondo al punto da lasciar balenare qua e là i segni di una umanissima stanchezza venata di delusione, a chiudere, non solo idealmente, il periplo senza esito di Wendy in “Wendy and Lucy”,  a dire universalizzandone il contenuto in una sorta di arresa mestizia ma su scala più grande: geografica, storica, antropologica (non è forse un caso che i film di Kelly, a partire proprio da “Meek’s cutoff”, dilatino la propria durata, si facciano cioè e al contempo più riflessivi e più tormentati, come in cerca di una via d’uscita che le opere anteriori avevano scorto o la cui carente reperibilità avevano lenito nella scommessa su una partecipazione al flusso degli eventi ancora passibile di contropartita spirituale). Girato in Oregon entro una cornice compatibile coi fatti descritti, “Meek’s cutoff” di certo ne restituisce le autentiche sfumature di luce e di colore. Quanto questa, infatti, è per lo più radente, contrariamente a quanto notato in precedenza (un esempio per tutti: “Ode” - vd. -), impietosa sui corpi e sugli oggetti come un giudizio senza indulgenza, gli altri, di contro e solo in apparente contraddizione, risultano discreti e quasi benevoli nel loro adagiarsi su una affranta tonalità pastello, sottolineata dal lavoro di Christopher Blauvelt sulle gradazioni chiare e chiarissime di norma sfumate le une nelle altre in una rincorsa sovente astratta (in uno spazio ove convergono, tra le possibili, l’irrequieta quotidianità di Homer, l’impassibilità presaga di Wyeth, come gli sprazzi di tregua nervosa in ognuno di loro: tavolozza, per altri versi e con ulteriori accorgimenti, già al lavoro in “Travis” - vd. -), che riesce ad amalgamare e finanche a sovrapporre, pressoché senza soluzione di continuità, il bianco alcalino del deserto all’ocra pallido e impalpabile della sabbia; il cotone grezzo delle vesti fruste al profilo deciso delle rocce, come al turchese finissimo delle distese liquide colte in lontananza, senza che tale sottile e penosa sensazione di inconsistenza si raffreddi e si coaguli nelle contate parentesi spese all’ombra di uno sperone sporgente o di una depressione, prima che, sul crinale dell’imbrunire, il lucore tenue dei fuochi delle attività di conforto sorprenda occhi resi febbrili dalla stanchezza nella fissità incredula di certe visioni nere di Goya, retaggio metafisico a cui sfugge l’Indiano Cayuse, fatto della stessa materia bruna dei monti circostanti e pronto a ritornarvi senza voltarsi indietro, tantomeno verso un albero piantato al centro del nulla.
a dire universalizzandone il contenuto in una sorta di arresa mestizia ma su scala più grande: geografica, storica, antropologica (non è forse un caso che i film di Kelly, a partire proprio da “Meek’s cutoff”, dilatino la propria durata, si facciano cioè e al contempo più riflessivi e più tormentati, come in cerca di una via d’uscita che le opere anteriori avevano scorto o la cui carente reperibilità avevano lenito nella scommessa su una partecipazione al flusso degli eventi ancora passibile di contropartita spirituale). Girato in Oregon entro una cornice compatibile coi fatti descritti, “Meek’s cutoff” di certo ne restituisce le autentiche sfumature di luce e di colore. Quanto questa, infatti, è per lo più radente, contrariamente a quanto notato in precedenza (un esempio per tutti: “Ode” - vd. -), impietosa sui corpi e sugli oggetti come un giudizio senza indulgenza, gli altri, di contro e solo in apparente contraddizione, risultano discreti e quasi benevoli nel loro adagiarsi su una affranta tonalità pastello, sottolineata dal lavoro di Christopher Blauvelt sulle gradazioni chiare e chiarissime di norma sfumate le une nelle altre in una rincorsa sovente astratta (in uno spazio ove convergono, tra le possibili, l’irrequieta quotidianità di Homer, l’impassibilità presaga di Wyeth, come gli sprazzi di tregua nervosa in ognuno di loro: tavolozza, per altri versi e con ulteriori accorgimenti, già al lavoro in “Travis” - vd. -), che riesce ad amalgamare e finanche a sovrapporre, pressoché senza soluzione di continuità, il bianco alcalino del deserto all’ocra pallido e impalpabile della sabbia; il cotone grezzo delle vesti fruste al profilo deciso delle rocce, come al turchese finissimo delle distese liquide colte in lontananza, senza che tale sottile e penosa sensazione di inconsistenza si raffreddi e si coaguli nelle contate parentesi spese all’ombra di uno sperone sporgente o di una depressione, prima che, sul crinale dell’imbrunire, il lucore tenue dei fuochi delle attività di conforto sorprenda occhi resi febbrili dalla stanchezza nella fissità incredula di certe visioni nere di Goya, retaggio metafisico a cui sfugge l’Indiano Cayuse, fatto della stessa materia bruna dei monti circostanti e pronto a ritornarvi senza voltarsi indietro, tantomeno verso un albero piantato al centro del nulla.
 che esercita e impone la propria volontà anche attraverso la violenza - affronta il suo redde rationem al modo di non potersi esimere dall’interrogarsi circa i limiti dell’esperienza umana come concorso di contraddizioni forse affatto componibili, neanche in rapporto alla fatica di abitare il mondo al passo di un ritrovato senso di equilibrio nella precarietà, di armonia parziale nell’evidente finitudine del suo tempo e dei suoi atti (vedi alcuni momenti di “River of grass” ma soprattutto di “Old joy”), appoggiando la legittimità - e l’irriducibilità - del proprio assunto sulle spalle larghe della Storia, sulla sedimentazione progressiva dei suoi episodi, così spesso compatibili con una lettura che li addita simili a sentenze severe. Il motivo occasionale di “Meek’s cutoff” retrodata, appunto, a un accidente del passato, a una singolare epopea realmente consumatasi tra la primavera e l’estate del 1845 sul quadrante nord-occidentale del territorio americano (verosimilmente nell’area interessata dall’Oregon Trail - sentiero di migrazione utilizzato dalle carovane di coloni in cerca di migliori opportunità a Ovest, tra Missouri, Kansas, Nebraska, attraverso Wyoming e Idaho, fino in Oregon -), nella finzione ristretto a un pugno di famiglie - tre, per l’esattezza - sotto l’egida del trapper e scout Stephen Meek/Greenwood, deciso a intraprendere una scorciatoia (quella del titolo) da lui in precedenza aperta (1842) che prevede, con l’attraversamento dell’Oregon Desert, un taglio consistente al tragitto imposto ai convogli (i cosiddetti wagon trains) con carri (i prairie shooners) in direzione di una delle mete di elezione del tempo, i pascoli e le pianure del Nord-Ovest, in specie quelli della Willamette Valley (estensione - per ribadire i ricorsi reichardtiani - circondata da quelle Cascade Mountains già obiettivo dei protagonisti di “Old joy” - vd. -), traguardo finale della sparuta compagine del film. In una regione selvaggia, per ampi segmenti ancora vergine (ricordiamo che gli Stati Uniti dell’epoca erano poco più di una nazione appena nata in cui la conoscenza delle sue zone più periferiche - e relativa pianificazione delle vie di comunicazione - era tutta da completare), dimora secolare di tribù indigene di norma ostili, tenta, come detto, di farsi strada verso un ipotetico futuro il drappello formato da un barbuto apripista - pittoresco incrocio tra un cowboy e un cacciatore di pelli, uomo-dalle-mille-avventure a cui non è estraneo il tono paradossale/istrionico (“Non ci siamo persi. Stiamo solo cercando la strada”, recita alle insistite obiezioni dei suoi dante causa), come quello ispirato per magnificare i personali trascorsi - e da tre esigui gruppi familiari, quello dei Tetherow, Emily e Soloman (altri ricorsi: ritroviamo tanto Wendy Williams che Will Patton); quello dei Gately, Millie e Thomas (nuove entrate, invece, per Zoe Kazan e Paul Dano), e quello dei White, Glory/Henderson, William/Huff e il piccolo Jimmy/Nelson. L’incedere dell’anabasi, escluso l’abbrivio dedicato all’approvvigionamento di acqua durante la pausa che introduce al guado di un fiume, è da subito stentato, penoso quasi (venendo incontro, anche se tendenzialmente per contrasto, a una delle numerose affermazioni fatte da Thoreau riguardo il lento ma inesorabile inaridimento del legame tra l’uomo e l’habitat che ne consente la sopravvivenza: La vera semplicità e nudità della vita dell’uomo nelle età primitive implicavano questo vantaggio, per lo meno: lasciavano l’uomo ospite della natura. Quando si era ristorato con cibo e con sonno, egli meditava nuovamente il suo viaggio. Dimorava, per dir così, sotto una tenda in questo mondo, e varcava le valli o attraversava le pianure o saliva sulle sommità dei monti. Ma, ahimè !, gli uomini ora sono diventati strumenti dei loro strumenti. L’uomo che quand’era affamato coglieva i frutti liberamente, è diventato contadino; e colui che, per riposare si stendeva sotto un albero, è diventato il guardiano della propria casa. Ora non ci accampiamo più per la notte, ma invece ci siamo piantati sulla terra e abbiamo dimenticato il cielo. Abbiamo adottato il cristianesimo semplicemente come un migliore metodo di agricoltura). Ovvero il paesaggio mostra presto il suo vero volto di luogo inospitale, come infastidito dalla presenza importuna degli uomini, latore di una diffidenza originaria che riecheggia nei brani biblici affidati alla lettura a voce alta di Jimmy (Col sudore della fronte guadagnerai il pane, finché tornerai alla terra. Perché dalla terra provieni, di polvere sei fatto. E nella polvere tornerai) e man mano determina la costruzione delle inquadrature quanto l’ampiezza dei piani di ripresa. Quasi oblique e un tanto scentrate un certo numero delle prime, in corrispondenza di movimenti della mdp che tendono a sottolineare con sottile perfidia il procedere macchinoso e sostanzialmente alla cieca del gruppo (i suoi gesti resi goffi dagli abiti pesanti e rallentati dalla sabbia e dal sole) nella incipiente desolazione circostante; di preferenza giocata sulla lontananza la seconda, con le silhouette dei protagonisti schiacciate da una distanza che ne certifica al tempo l’insignificanza della condizione e la vacuità delle pretese, ossia, di base, il distacco da un mondo bene in grado di fare a meno di loro, come evoca spietatamente il contenuto del già citato testo sacro, non a caso emanazione del dio impassibile, perché austero, dell’Antico Testamento. Di conseguenza - sembra constatare Kelly - anche l’ipotesi di una trascendenza esperibile sfuma o si riduce a beffarda illusione, con l’aggravante di un precedente storico inutilizzato come monito per il domani. Nel senso che ciò che, almeno fino a “Old joy”, prova a configurarsi come sforzo, per quanto in partenza esposto all’equivoco e al tradimento, tuttavia interno a un orizzonte che non si sottrae al desiderio di superamento delle angustie dell’hic et nunc, di quella consuetudine avvilente che trova nello schema della ripetizione il principio della propria indistruttibilità, in “Meek’s cutoff” diventa il riproporsi di un estenuante girare a vuoto (il film può essere visto come la cronistoria di un tragitto circolare intervallato dalle soste imposte dal ritmo circadiano: in mezzo solo i gesti della resistenza quotidiana e le poche parole di sconcerto o disperata insofferenza verso l’inconcludente peregrinare di Meek): nel deserto, a conti fatti più grande della voglia stessa di attraversarlo; sotto il sole che non concede scampo (William crolla sfinito al termine di sistematiche privazioni indotte dalla carenza di cibo e dalla marce forzate); tra la polvere che si insinua sotto e dentro tessuti dalla foggia rigida e dal taglio fin troppo formale; alla ricerca di acqua che non basta mai; nel cigolio monotono dei carri, unico commento a un’inerzia immune anche al suono; attorno a una vegetazione spoglia e ad alture che sembrano tutte uguali, fino alla conclusione presso un albero macilento che segna più il confine della prostrazione che la meraviglia di un nuovo inizio. In generale, nei meandri di un frangente esistenziale la cui singolarità e drammaticità rischia di continuo di regredire a mera iperbole linguistica, tanta è la crudezza della sua essenza. E anche durante i rari momenti di una esperienza così impegnativa e frustrante da prevedere quasi suo malgrado istanti di stremata dolcezza (la condivisione serale, davanti al fuoco dell’ennesimo accampamento, di razionate vettovaglie; la disponibilità di Emily a ricucire il mocassino slabbrato dell’Indiano ostaggio/Roudeau al fine di stabilire un simulacro di rapporto con l’Altro - oltreché carpirne l’accondiscendenza in modo da penetrarne la più accurata conoscenza del territorio -), Kelly suggerisce che sono la fatalità e la contingenza a prevalere (varie volte la carovana è costretta a tornare sui propri passi o ad aggirare ostacoli naturali che Meek non conosce o non è stato in grado di prevedere; la transizione di uno dei carri entro una depressione rocciosa si risolve in un disastro, suscitando tanto la trattenuta ilarità dell’Indiano quanto l’ira di Meek e la contro-reazione ferma di Emily). E’ quel senso di negazione e inutilità, tutt’uno con un paesaggio scabro, silenzioso e ostinato (mai così lontano, per fare un esempio, dai primitivi stupori malickiani), con crepuscoli rapidi e scostanti, preludi di oscurità piene e compatte, così aderenti ai corpi da lasciarli emergere alla luce solo di quando in quando, che circoscrive e ridefinisce l’ambito del possibile, in un avvitamento di natura difensiva destinato a rimanere nel Cinema della regista della Florida come testimonianza di una aporia svelatasi tale mano mano che venivano saggiati gli estremi di un sentire così poco in sintonia con il tono-generale-del-mondo al punto da lasciar balenare qua e là i segni di una umanissima stanchezza venata di delusione, a chiudere, non solo idealmente, il periplo senza esito di Wendy in “Wendy and Lucy”,
che esercita e impone la propria volontà anche attraverso la violenza - affronta il suo redde rationem al modo di non potersi esimere dall’interrogarsi circa i limiti dell’esperienza umana come concorso di contraddizioni forse affatto componibili, neanche in rapporto alla fatica di abitare il mondo al passo di un ritrovato senso di equilibrio nella precarietà, di armonia parziale nell’evidente finitudine del suo tempo e dei suoi atti (vedi alcuni momenti di “River of grass” ma soprattutto di “Old joy”), appoggiando la legittimità - e l’irriducibilità - del proprio assunto sulle spalle larghe della Storia, sulla sedimentazione progressiva dei suoi episodi, così spesso compatibili con una lettura che li addita simili a sentenze severe. Il motivo occasionale di “Meek’s cutoff” retrodata, appunto, a un accidente del passato, a una singolare epopea realmente consumatasi tra la primavera e l’estate del 1845 sul quadrante nord-occidentale del territorio americano (verosimilmente nell’area interessata dall’Oregon Trail - sentiero di migrazione utilizzato dalle carovane di coloni in cerca di migliori opportunità a Ovest, tra Missouri, Kansas, Nebraska, attraverso Wyoming e Idaho, fino in Oregon -), nella finzione ristretto a un pugno di famiglie - tre, per l’esattezza - sotto l’egida del trapper e scout Stephen Meek/Greenwood, deciso a intraprendere una scorciatoia (quella del titolo) da lui in precedenza aperta (1842) che prevede, con l’attraversamento dell’Oregon Desert, un taglio consistente al tragitto imposto ai convogli (i cosiddetti wagon trains) con carri (i prairie shooners) in direzione di una delle mete di elezione del tempo, i pascoli e le pianure del Nord-Ovest, in specie quelli della Willamette Valley (estensione - per ribadire i ricorsi reichardtiani - circondata da quelle Cascade Mountains già obiettivo dei protagonisti di “Old joy” - vd. -), traguardo finale della sparuta compagine del film. In una regione selvaggia, per ampi segmenti ancora vergine (ricordiamo che gli Stati Uniti dell’epoca erano poco più di una nazione appena nata in cui la conoscenza delle sue zone più periferiche - e relativa pianificazione delle vie di comunicazione - era tutta da completare), dimora secolare di tribù indigene di norma ostili, tenta, come detto, di farsi strada verso un ipotetico futuro il drappello formato da un barbuto apripista - pittoresco incrocio tra un cowboy e un cacciatore di pelli, uomo-dalle-mille-avventure a cui non è estraneo il tono paradossale/istrionico (“Non ci siamo persi. Stiamo solo cercando la strada”, recita alle insistite obiezioni dei suoi dante causa), come quello ispirato per magnificare i personali trascorsi - e da tre esigui gruppi familiari, quello dei Tetherow, Emily e Soloman (altri ricorsi: ritroviamo tanto Wendy Williams che Will Patton); quello dei Gately, Millie e Thomas (nuove entrate, invece, per Zoe Kazan e Paul Dano), e quello dei White, Glory/Henderson, William/Huff e il piccolo Jimmy/Nelson. L’incedere dell’anabasi, escluso l’abbrivio dedicato all’approvvigionamento di acqua durante la pausa che introduce al guado di un fiume, è da subito stentato, penoso quasi (venendo incontro, anche se tendenzialmente per contrasto, a una delle numerose affermazioni fatte da Thoreau riguardo il lento ma inesorabile inaridimento del legame tra l’uomo e l’habitat che ne consente la sopravvivenza: La vera semplicità e nudità della vita dell’uomo nelle età primitive implicavano questo vantaggio, per lo meno: lasciavano l’uomo ospite della natura. Quando si era ristorato con cibo e con sonno, egli meditava nuovamente il suo viaggio. Dimorava, per dir così, sotto una tenda in questo mondo, e varcava le valli o attraversava le pianure o saliva sulle sommità dei monti. Ma, ahimè !, gli uomini ora sono diventati strumenti dei loro strumenti. L’uomo che quand’era affamato coglieva i frutti liberamente, è diventato contadino; e colui che, per riposare si stendeva sotto un albero, è diventato il guardiano della propria casa. Ora non ci accampiamo più per la notte, ma invece ci siamo piantati sulla terra e abbiamo dimenticato il cielo. Abbiamo adottato il cristianesimo semplicemente come un migliore metodo di agricoltura). Ovvero il paesaggio mostra presto il suo vero volto di luogo inospitale, come infastidito dalla presenza importuna degli uomini, latore di una diffidenza originaria che riecheggia nei brani biblici affidati alla lettura a voce alta di Jimmy (Col sudore della fronte guadagnerai il pane, finché tornerai alla terra. Perché dalla terra provieni, di polvere sei fatto. E nella polvere tornerai) e man mano determina la costruzione delle inquadrature quanto l’ampiezza dei piani di ripresa. Quasi oblique e un tanto scentrate un certo numero delle prime, in corrispondenza di movimenti della mdp che tendono a sottolineare con sottile perfidia il procedere macchinoso e sostanzialmente alla cieca del gruppo (i suoi gesti resi goffi dagli abiti pesanti e rallentati dalla sabbia e dal sole) nella incipiente desolazione circostante; di preferenza giocata sulla lontananza la seconda, con le silhouette dei protagonisti schiacciate da una distanza che ne certifica al tempo l’insignificanza della condizione e la vacuità delle pretese, ossia, di base, il distacco da un mondo bene in grado di fare a meno di loro, come evoca spietatamente il contenuto del già citato testo sacro, non a caso emanazione del dio impassibile, perché austero, dell’Antico Testamento. Di conseguenza - sembra constatare Kelly - anche l’ipotesi di una trascendenza esperibile sfuma o si riduce a beffarda illusione, con l’aggravante di un precedente storico inutilizzato come monito per il domani. Nel senso che ciò che, almeno fino a “Old joy”, prova a configurarsi come sforzo, per quanto in partenza esposto all’equivoco e al tradimento, tuttavia interno a un orizzonte che non si sottrae al desiderio di superamento delle angustie dell’hic et nunc, di quella consuetudine avvilente che trova nello schema della ripetizione il principio della propria indistruttibilità, in “Meek’s cutoff” diventa il riproporsi di un estenuante girare a vuoto (il film può essere visto come la cronistoria di un tragitto circolare intervallato dalle soste imposte dal ritmo circadiano: in mezzo solo i gesti della resistenza quotidiana e le poche parole di sconcerto o disperata insofferenza verso l’inconcludente peregrinare di Meek): nel deserto, a conti fatti più grande della voglia stessa di attraversarlo; sotto il sole che non concede scampo (William crolla sfinito al termine di sistematiche privazioni indotte dalla carenza di cibo e dalla marce forzate); tra la polvere che si insinua sotto e dentro tessuti dalla foggia rigida e dal taglio fin troppo formale; alla ricerca di acqua che non basta mai; nel cigolio monotono dei carri, unico commento a un’inerzia immune anche al suono; attorno a una vegetazione spoglia e ad alture che sembrano tutte uguali, fino alla conclusione presso un albero macilento che segna più il confine della prostrazione che la meraviglia di un nuovo inizio. In generale, nei meandri di un frangente esistenziale la cui singolarità e drammaticità rischia di continuo di regredire a mera iperbole linguistica, tanta è la crudezza della sua essenza. E anche durante i rari momenti di una esperienza così impegnativa e frustrante da prevedere quasi suo malgrado istanti di stremata dolcezza (la condivisione serale, davanti al fuoco dell’ennesimo accampamento, di razionate vettovaglie; la disponibilità di Emily a ricucire il mocassino slabbrato dell’Indiano ostaggio/Roudeau al fine di stabilire un simulacro di rapporto con l’Altro - oltreché carpirne l’accondiscendenza in modo da penetrarne la più accurata conoscenza del territorio -), Kelly suggerisce che sono la fatalità e la contingenza a prevalere (varie volte la carovana è costretta a tornare sui propri passi o ad aggirare ostacoli naturali che Meek non conosce o non è stato in grado di prevedere; la transizione di uno dei carri entro una depressione rocciosa si risolve in un disastro, suscitando tanto la trattenuta ilarità dell’Indiano quanto l’ira di Meek e la contro-reazione ferma di Emily). E’ quel senso di negazione e inutilità, tutt’uno con un paesaggio scabro, silenzioso e ostinato (mai così lontano, per fare un esempio, dai primitivi stupori malickiani), con crepuscoli rapidi e scostanti, preludi di oscurità piene e compatte, così aderenti ai corpi da lasciarli emergere alla luce solo di quando in quando, che circoscrive e ridefinisce l’ambito del possibile, in un avvitamento di natura difensiva destinato a rimanere nel Cinema della regista della Florida come testimonianza di una aporia svelatasi tale mano mano che venivano saggiati gli estremi di un sentire così poco in sintonia con il tono-generale-del-mondo al punto da lasciar balenare qua e là i segni di una umanissima stanchezza venata di delusione, a chiudere, non solo idealmente, il periplo senza esito di Wendy in “Wendy and Lucy”,  a dire universalizzandone il contenuto in una sorta di arresa mestizia ma su scala più grande: geografica, storica, antropologica (non è forse un caso che i film di Kelly, a partire proprio da “Meek’s cutoff”, dilatino la propria durata, si facciano cioè e al contempo più riflessivi e più tormentati, come in cerca di una via d’uscita che le opere anteriori avevano scorto o la cui carente reperibilità avevano lenito nella scommessa su una partecipazione al flusso degli eventi ancora passibile di contropartita spirituale). Girato in Oregon entro una cornice compatibile coi fatti descritti, “Meek’s cutoff” di certo ne restituisce le autentiche sfumature di luce e di colore. Quanto questa, infatti, è per lo più radente, contrariamente a quanto notato in precedenza (un esempio per tutti: “Ode” - vd. -), impietosa sui corpi e sugli oggetti come un giudizio senza indulgenza, gli altri, di contro e solo in apparente contraddizione, risultano discreti e quasi benevoli nel loro adagiarsi su una affranta tonalità pastello, sottolineata dal lavoro di Christopher Blauvelt sulle gradazioni chiare e chiarissime di norma sfumate le une nelle altre in una rincorsa sovente astratta (in uno spazio ove convergono, tra le possibili, l’irrequieta quotidianità di Homer, l’impassibilità presaga di Wyeth, come gli sprazzi di tregua nervosa in ognuno di loro: tavolozza, per altri versi e con ulteriori accorgimenti, già al lavoro in “Travis” - vd. -), che riesce ad amalgamare e finanche a sovrapporre, pressoché senza soluzione di continuità, il bianco alcalino del deserto all’ocra pallido e impalpabile della sabbia; il cotone grezzo delle vesti fruste al profilo deciso delle rocce, come al turchese finissimo delle distese liquide colte in lontananza, senza che tale sottile e penosa sensazione di inconsistenza si raffreddi e si coaguli nelle contate parentesi spese all’ombra di uno sperone sporgente o di una depressione, prima che, sul crinale dell’imbrunire, il lucore tenue dei fuochi delle attività di conforto sorprenda occhi resi febbrili dalla stanchezza nella fissità incredula di certe visioni nere di Goya, retaggio metafisico a cui sfugge l’Indiano Cayuse, fatto della stessa materia bruna dei monti circostanti e pronto a ritornarvi senza voltarsi indietro, tantomeno verso un albero piantato al centro del nulla.
a dire universalizzandone il contenuto in una sorta di arresa mestizia ma su scala più grande: geografica, storica, antropologica (non è forse un caso che i film di Kelly, a partire proprio da “Meek’s cutoff”, dilatino la propria durata, si facciano cioè e al contempo più riflessivi e più tormentati, come in cerca di una via d’uscita che le opere anteriori avevano scorto o la cui carente reperibilità avevano lenito nella scommessa su una partecipazione al flusso degli eventi ancora passibile di contropartita spirituale). Girato in Oregon entro una cornice compatibile coi fatti descritti, “Meek’s cutoff” di certo ne restituisce le autentiche sfumature di luce e di colore. Quanto questa, infatti, è per lo più radente, contrariamente a quanto notato in precedenza (un esempio per tutti: “Ode” - vd. -), impietosa sui corpi e sugli oggetti come un giudizio senza indulgenza, gli altri, di contro e solo in apparente contraddizione, risultano discreti e quasi benevoli nel loro adagiarsi su una affranta tonalità pastello, sottolineata dal lavoro di Christopher Blauvelt sulle gradazioni chiare e chiarissime di norma sfumate le une nelle altre in una rincorsa sovente astratta (in uno spazio ove convergono, tra le possibili, l’irrequieta quotidianità di Homer, l’impassibilità presaga di Wyeth, come gli sprazzi di tregua nervosa in ognuno di loro: tavolozza, per altri versi e con ulteriori accorgimenti, già al lavoro in “Travis” - vd. -), che riesce ad amalgamare e finanche a sovrapporre, pressoché senza soluzione di continuità, il bianco alcalino del deserto all’ocra pallido e impalpabile della sabbia; il cotone grezzo delle vesti fruste al profilo deciso delle rocce, come al turchese finissimo delle distese liquide colte in lontananza, senza che tale sottile e penosa sensazione di inconsistenza si raffreddi e si coaguli nelle contate parentesi spese all’ombra di uno sperone sporgente o di una depressione, prima che, sul crinale dell’imbrunire, il lucore tenue dei fuochi delle attività di conforto sorprenda occhi resi febbrili dalla stanchezza nella fissità incredula di certe visioni nere di Goya, retaggio metafisico a cui sfugge l’Indiano Cayuse, fatto della stessa materia bruna dei monti circostanti e pronto a ritornarvi senza voltarsi indietro, tantomeno verso un albero piantato al centro del nulla.***
Nulla che, tra i tanti jolly del suo mazzo, può contare su quello non indifferente di poter assumere svariate fisionomie, una delle più controverse delle quali è di sicuro quella ideologico-revanscista, a individuare una specie di - a questo punto - consequenziale, brutalizzando Houellebecq, “restringimento del dominio della lotta” nel personale percorso cinematografico della Reichardt, entro lo specifico di un film come Night moves (2013), impegno assunto da Kelly a quattro mani con Jon Raymond alla ricerca della forma più consona per restituire il chiaro disagio maturato a seguito del manifestarsi della natura dolorosamente disorientante del rapporto che lega la spinta a conciliare in una dimensione non solo materiale - quindi meramente narrativa - la parabola umana e le evidenze (ripensamenti, apatie, ipocrisie, opportunismi, reali insormontabilità di carattere fisico) che ne ridimensionano, quando non inquinano, mutilano o impediscono, la realizzazione. In tal senso può essere messa a fuoco, anche se non risolta, la vicenda dei tre eco-attivisti ritratti nell’opera a partire dal coacervo inquieto quanto torbido delle loro pulsioni, quei movimenti notturni che non ricalcano tanto e solo lo spirito per certi versi criptico dei loro comportamenti, quanto alludono a un grumo oscuro e inattingibile che ne agita gli animi, in un crescendo di gesti incauti, improbabili e/o irresponsabili e, per sovrappiù, tragicamente inconcludenti, a certificare la pressoché totale immanenza della loro esperienza. Parliamo qui di primato dell’immanenza a scapito della più volte sottolineata ipotesi di trascendenza perseguita fin dall’inizio dal Cinema di Kelly, perché la quasi totalità delle vicissitudini che coinvolge i tre protagonisti - Josh/Eisenberg, taciturno e tormentato addetto presso una cooperativa di prodotti biologici; Dena/Fanning, ragazza borghese solitaria e apprensiva convertita a un ecologismo oltranzista, e lo sfuggente Harmon/Sarsgaard, un passato militare, dalle reali motivazioni indecifrabili ma dalle sufficienti competenze tecniche per allestire un attentato, si sviluppano all’interno di un perimetro di talmente immediata individuazione da lasciare poco spazio, pur nel rispetto formale delle sue prerogative (descrizione lineare della ripetitività della routine giornaliera; dialogare anodino o neutro; espressività recitativa ridotta all’essenziale; frattura traumatica della circolarità degli eventi; chiusura giocata su una inerzia insinuante, et.), al superamento dell’evidenza concreta dei fatti, anzi talvolta accentuandone, come già visto in “Meek’s cutoff”, la componente di più accessibile immedesimazione (là era il sostrato western-avventuroso; qui la correzione thriller), tralasciando quasi del tutto quella sospensione, quella specie di spiritualismo materialista (l’accorgimento per il dettaglio minimale e la promessa metaforica della sua persistenza; l’enigmatica assenza o la vacuità stranamente indagatrice di uno sguardo; lo straniamento conseguente a un particolare punto di vista gettato sul paesaggio, et.), utile a facilitare l’emersione di un imponderabile. In altre parole, “Night moves” (omonimo, tra l’altro, del celebre contro-noir di Penn, di cui condivide la cupa atmosfera avvolta attorno a un mondo caotico e irrazionale a cui ci si illude di potersi opporre tentando di far chiarezza in sé stessi o, come in questo caso, puntando sul gesto eclatante a mo’ di ecumenica metanoia), fin da subito - il film si apre su Josh e Dena che compiono una rapida ricognizione lungo il tratto agibile della diga che hanno intenzione di far saltare al fine di sollecitare un uso più equo delle scarse risorse idriche (ci si lamenta, infatti, che molta acqua venga impiegata per il mantenimento dei sempre più numerosi campi da golf della zona), la continua penuria delle quali sta via via creando difficoltà sempre più grandi agli agricoltori delle aree a cavallo tra la Contea di Jackson e quella di Klamath, nell’Oregon meridionale, teatro della storia - organizza il proprio incedere secondo un classico concatenarsi di situazioni destinate a precipitare in un climax delittuoso denunciando, per ineluttabile coerenza, si potrebbe dire, la resa all’opacità del reale (al deserto senza fatalità delle contingenze), a una sua conclamata inattaccabilità in relazione a ogni atteggiamento che non le sia conforme, unanimità a cui volgersi nella speranza di un oltrepassamento solo nell’ottica di una separazione netta, di una cesura non riproducibile se non nelle fogge di una apparenza sinistra quanto irridente (emblematica a riguardo la sequenza in cui Josh, aspettando Dena nei locali esterni di un centro sauna in odore di ambiente new age, si imbatte nei corpi nudi e cadenti di alcune ospiti, specchio deformato e minaccioso questo, a ben vedere, della placida carnalità giovanile catturata, ad esempio, in “Old joy”). D’altra parte, è il movimento stesso della linea narrativa a riproporre ora il periplo tortuoso ma infecondo di “Meek’s cutoff”, anziché quello, a modo suo schietto dello stesso ”Old joy”, per non dire di quello sconclusionato però, a tratti, spensierato e promettente di “River of grass”: dall’andirivieni per procacciarsi il materiale necessario a portare a termine il sabotaggio (oltre 250 kg. di fertilizzante al nitrato di amile estorto per puro sfinimento al suo riluttante rivenditore/Le Gros), al sopralluogo in barca (la night moves del titolo, che servirà poi da contenitore per l’esplosivo) attraverso una vasta depressione inondata come compensazione dei dislivelli creati a monte dalla diga e ingombra di spogli tronchi a mollo come lapidi vegetali emerse, a futura memoria dei pedaggi dovuti alla modernizzazione; giù fino alla tensione innescata durante la notte fatale da una presenza molesta tale da compromettere il piano, e passando per le incomprensioni che mascherano una qual diffidenza, se non addirittura ostilità, fra i tre caratteri principali, accomunati forse da un massimalismo di principio, per quanto schematico e limitativo (i tre sembrano sussistere solo in ragione dell’autoimposto ruolo di esecutori di un atto materiale - nel caso, scellerato - senza altro a integrarne e giustificarne i giorni, oltreché la militanza), ma di certo non complementari. Josh, infatti, come ricordato, è tanto meticoloso quanto teso oltremodo; Dena dissimula la propria fragilità dietro un contegno e una pignoleria da maestrina (durante il sopraccitato sopralluogo snocciola con precisione ma senza il minimo coinvolgimento le cifre che fotografano il progressivo assottigliarsi della fauna oceanica a fronte del costante incremento della pesca intensiva); Harmon ostenta disinvoltura ma, a volte, sembra persino disinteressato all’impresa o semplicemente assorto in altri pensieri. Ciò che vediamo mano mano delinearsi, cioè, al posto di un rigoroso ed equilibrato alternarsi di piani statici e altrettali inquadrature centrate sull’estrapolazione di dettagli per i quali è decisivo il tempo occorrente a isolarli (a dire, dando loro quella occasione di aprirsi, come visto lungo buona parte della filmografia di Kelly, a un senso ulteriore rispetto alla mera rappresentazione, sul genere di quelle things behind the sun indicate in altro ambito da Nick Drake - il paragone musicale potrebbe non apparire stravagante allorché si riflettesse sull’idea di considerare il percorso delle immagini anche come l’incontro di elementi di una partitura più ampia - And if you see what’s meant to be/Don’t name the day or try to say/It happened before… And see the sun when day is done/If only you see…), in generale sul riproporsi di un moto sotterraneo in grado alla fine di elevare l’opera al di sopra dei suoi moduli ricorrenti (aderenza o ribellione a un genere; plausibilità narrativa; matrice psicologica della recitazione; ruolo del commento sonoro, et.), è altresì un racconto opportunamente raffreddato al centro di una messinscena di impostazione canonica, all’interno della quale non mancano tanto l’elemento spettacolare imprevisto (ad azione compiuta, la sorte cinematografica si incarica di sistemare un villeggiante solitario sulla linea di distruzione della diga così laboriosamente fatta saltare, ampliando di fatto lo spettro delle fattispecie penali a carico dei tre: dall’attentato all’omicidio), quanto la componente emotivo-drammatica (Dena, presto rosa dai sensi di colpa comincia, violando la consegna del silenzio, a telefonare ai suoi complici in cerca di un modo per scrollarsi di dosso l’angoscia montante, innescando un vortice ansioso che travolgerà più il turbato Josh che il compassato Harmon, fino a un esito irrimediabile ma, in una simile logica di scelte stilistico/espressive, scontato, ossia l’eliminazione dell’anello debole/pericoloso: Dena, appunto).
quei movimenti notturni che non ricalcano tanto e solo lo spirito per certi versi criptico dei loro comportamenti, quanto alludono a un grumo oscuro e inattingibile che ne agita gli animi, in un crescendo di gesti incauti, improbabili e/o irresponsabili e, per sovrappiù, tragicamente inconcludenti, a certificare la pressoché totale immanenza della loro esperienza. Parliamo qui di primato dell’immanenza a scapito della più volte sottolineata ipotesi di trascendenza perseguita fin dall’inizio dal Cinema di Kelly, perché la quasi totalità delle vicissitudini che coinvolge i tre protagonisti - Josh/Eisenberg, taciturno e tormentato addetto presso una cooperativa di prodotti biologici; Dena/Fanning, ragazza borghese solitaria e apprensiva convertita a un ecologismo oltranzista, e lo sfuggente Harmon/Sarsgaard, un passato militare, dalle reali motivazioni indecifrabili ma dalle sufficienti competenze tecniche per allestire un attentato, si sviluppano all’interno di un perimetro di talmente immediata individuazione da lasciare poco spazio, pur nel rispetto formale delle sue prerogative (descrizione lineare della ripetitività della routine giornaliera; dialogare anodino o neutro; espressività recitativa ridotta all’essenziale; frattura traumatica della circolarità degli eventi; chiusura giocata su una inerzia insinuante, et.), al superamento dell’evidenza concreta dei fatti, anzi talvolta accentuandone, come già visto in “Meek’s cutoff”, la componente di più accessibile immedesimazione (là era il sostrato western-avventuroso; qui la correzione thriller), tralasciando quasi del tutto quella sospensione, quella specie di spiritualismo materialista (l’accorgimento per il dettaglio minimale e la promessa metaforica della sua persistenza; l’enigmatica assenza o la vacuità stranamente indagatrice di uno sguardo; lo straniamento conseguente a un particolare punto di vista gettato sul paesaggio, et.), utile a facilitare l’emersione di un imponderabile. In altre parole, “Night moves” (omonimo, tra l’altro, del celebre contro-noir di Penn, di cui condivide la cupa atmosfera avvolta attorno a un mondo caotico e irrazionale a cui ci si illude di potersi opporre tentando di far chiarezza in sé stessi o, come in questo caso, puntando sul gesto eclatante a mo’ di ecumenica metanoia), fin da subito - il film si apre su Josh e Dena che compiono una rapida ricognizione lungo il tratto agibile della diga che hanno intenzione di far saltare al fine di sollecitare un uso più equo delle scarse risorse idriche (ci si lamenta, infatti, che molta acqua venga impiegata per il mantenimento dei sempre più numerosi campi da golf della zona), la continua penuria delle quali sta via via creando difficoltà sempre più grandi agli agricoltori delle aree a cavallo tra la Contea di Jackson e quella di Klamath, nell’Oregon meridionale, teatro della storia - organizza il proprio incedere secondo un classico concatenarsi di situazioni destinate a precipitare in un climax delittuoso denunciando, per ineluttabile coerenza, si potrebbe dire, la resa all’opacità del reale (al deserto senza fatalità delle contingenze), a una sua conclamata inattaccabilità in relazione a ogni atteggiamento che non le sia conforme, unanimità a cui volgersi nella speranza di un oltrepassamento solo nell’ottica di una separazione netta, di una cesura non riproducibile se non nelle fogge di una apparenza sinistra quanto irridente (emblematica a riguardo la sequenza in cui Josh, aspettando Dena nei locali esterni di un centro sauna in odore di ambiente new age, si imbatte nei corpi nudi e cadenti di alcune ospiti, specchio deformato e minaccioso questo, a ben vedere, della placida carnalità giovanile catturata, ad esempio, in “Old joy”). D’altra parte, è il movimento stesso della linea narrativa a riproporre ora il periplo tortuoso ma infecondo di “Meek’s cutoff”, anziché quello, a modo suo schietto dello stesso ”Old joy”, per non dire di quello sconclusionato però, a tratti, spensierato e promettente di “River of grass”: dall’andirivieni per procacciarsi il materiale necessario a portare a termine il sabotaggio (oltre 250 kg. di fertilizzante al nitrato di amile estorto per puro sfinimento al suo riluttante rivenditore/Le Gros), al sopralluogo in barca (la night moves del titolo, che servirà poi da contenitore per l’esplosivo) attraverso una vasta depressione inondata come compensazione dei dislivelli creati a monte dalla diga e ingombra di spogli tronchi a mollo come lapidi vegetali emerse, a futura memoria dei pedaggi dovuti alla modernizzazione; giù fino alla tensione innescata durante la notte fatale da una presenza molesta tale da compromettere il piano, e passando per le incomprensioni che mascherano una qual diffidenza, se non addirittura ostilità, fra i tre caratteri principali, accomunati forse da un massimalismo di principio, per quanto schematico e limitativo (i tre sembrano sussistere solo in ragione dell’autoimposto ruolo di esecutori di un atto materiale - nel caso, scellerato - senza altro a integrarne e giustificarne i giorni, oltreché la militanza), ma di certo non complementari. Josh, infatti, come ricordato, è tanto meticoloso quanto teso oltremodo; Dena dissimula la propria fragilità dietro un contegno e una pignoleria da maestrina (durante il sopraccitato sopralluogo snocciola con precisione ma senza il minimo coinvolgimento le cifre che fotografano il progressivo assottigliarsi della fauna oceanica a fronte del costante incremento della pesca intensiva); Harmon ostenta disinvoltura ma, a volte, sembra persino disinteressato all’impresa o semplicemente assorto in altri pensieri. Ciò che vediamo mano mano delinearsi, cioè, al posto di un rigoroso ed equilibrato alternarsi di piani statici e altrettali inquadrature centrate sull’estrapolazione di dettagli per i quali è decisivo il tempo occorrente a isolarli (a dire, dando loro quella occasione di aprirsi, come visto lungo buona parte della filmografia di Kelly, a un senso ulteriore rispetto alla mera rappresentazione, sul genere di quelle things behind the sun indicate in altro ambito da Nick Drake - il paragone musicale potrebbe non apparire stravagante allorché si riflettesse sull’idea di considerare il percorso delle immagini anche come l’incontro di elementi di una partitura più ampia - And if you see what’s meant to be/Don’t name the day or try to say/It happened before… And see the sun when day is done/If only you see…), in generale sul riproporsi di un moto sotterraneo in grado alla fine di elevare l’opera al di sopra dei suoi moduli ricorrenti (aderenza o ribellione a un genere; plausibilità narrativa; matrice psicologica della recitazione; ruolo del commento sonoro, et.), è altresì un racconto opportunamente raffreddato al centro di una messinscena di impostazione canonica, all’interno della quale non mancano tanto l’elemento spettacolare imprevisto (ad azione compiuta, la sorte cinematografica si incarica di sistemare un villeggiante solitario sulla linea di distruzione della diga così laboriosamente fatta saltare, ampliando di fatto lo spettro delle fattispecie penali a carico dei tre: dall’attentato all’omicidio), quanto la componente emotivo-drammatica (Dena, presto rosa dai sensi di colpa comincia, violando la consegna del silenzio, a telefonare ai suoi complici in cerca di un modo per scrollarsi di dosso l’angoscia montante, innescando un vortice ansioso che travolgerà più il turbato Josh che il compassato Harmon, fino a un esito irrimediabile ma, in una simile logica di scelte stilistico/espressive, scontato, ossia l’eliminazione dell’anello debole/pericoloso: Dena, appunto).  Frangenti che il Cinema di Kelly aveva temperato, almeno fino a “Wendy and Lucy”, grazie alla particolare capacità di orchestrare una stilizzazione delicata dei suoi fondamenti, per cui alla destrezza di comporre immagini ieratiche di efficace caratura simbolica (pensiamo all’inquadratura modernissima, pressoché astratta, che indulge sul merci in partenza nell’incipit di “Wendy and Lucy” o al nitore quasi materno di certi frammenti rubati al cuore della foresta in “Old joy”), si abbinava, in semplice eppure miracolosa simbiosi, l’attenzione/scoperta della minuzia solo di primo acchito inessenziale, in realtà rivelatrice (il fragile incrocio, fra il tenero e l’arreso, degli sguardi di Bobby Lee e Billy Joe, in “Ode”, o le dita longilinee di Wendy che attraverso una recinzione cercano il muso curioso di Lucy, nel finale di “Wendy and Lucy” o, ancora, il passeggiare di Cozy in equilibrio su un muretto, con sullo sfondo l’eterno accordo misterioso tra cielo e mare, in “River of grass”, et.) e che in “Night moves”, invece, assume le fattezze di diligenti spostamenti laterali della mdp; di fugaci primi piani, più esasperati che dispensatori di promesse; di campi medi che portano-avanti-la-storia più che favorirne l’eco della suggestione. Diventa così conseguente l’arretramento su un piano di maggiore convenzionalità del dispositivo prettamente visuale messo all’opera da Kelly. Per dire: si delinea, tra l’altro e via via che Josh, Dena e Harmon si attrezzano per progettare ed eseguire il proprio proposito criminale, una costante diluizione di quell’approccio conoscitivo al paesaggio di reminiscenza fiamminga (che, come è noto, per l’analisi accurata dei particolari, una certa predilezione per i contesti allusivi, sovente evoca intriganti potenzialità allegoriche), presente - un paio di esempi - in “Ode” e in “Old joy”, a favore di una sua lettura più diretta, ossia in primis funzionale alle occorrenze di base del racconto, in accordo con la scelta utilitaristica dei personaggi (la Natura, per i tre eco-dinamitardi, è più che altro - ecco la matrice alla fin fine ideologica del loro agire - un insieme di strumenti da sfruttare in vista di uno scopo concreto, non l’occasione per recuperare/rinnovare il dialogo interrotto con il lato più spirituale della propria condizione umana), di per sé aliena da qualunque prospettiva trascendentale. Allo stesso modo partecipa lo spettro cromatico (e l’apporto offerto da Christopher Blauvelt anche in “Night moves” registra solo l’ennesimo ritorno nel Cinema della Reichardt di collaboratori che replicano la propria presenza al di là delle strettoie imposte dai rapporti di lavoro), con la predilezione, sulle tinte scure, di un grafismo quasi vistoso, in cui corpi, oggetti e sfondi vengono ben delineati per essere subito riconoscibili: vuoi per la presenza pressoché costante di una luce crepuscolare, quindi non troppo invadente, vuoi per la necessità drammaturgica di convogliare l’acme psicologico del film nelle sequenze notturne propriamente dette, emblemi inequivocabili di quel buio interiore che permea le figure cardine di una comunque insidiosa impenetrabilità, soprattutto per ciò che attiene alla traiettoria individuale di Josh, ossessiva e disperata una volta ceduto al precipitare degli avvenimenti come somma di decisioni indotte dalla radicalità di un’idea, spettro fuggiasco a cui non resta che il nulla, un nulla aspro e solitario (“Potremmo andare da qualche parte, in mezzo al nulla”, supplica al telefono a un evasivo e distaccato Harmon) a cui attaccarsi.
Frangenti che il Cinema di Kelly aveva temperato, almeno fino a “Wendy and Lucy”, grazie alla particolare capacità di orchestrare una stilizzazione delicata dei suoi fondamenti, per cui alla destrezza di comporre immagini ieratiche di efficace caratura simbolica (pensiamo all’inquadratura modernissima, pressoché astratta, che indulge sul merci in partenza nell’incipit di “Wendy and Lucy” o al nitore quasi materno di certi frammenti rubati al cuore della foresta in “Old joy”), si abbinava, in semplice eppure miracolosa simbiosi, l’attenzione/scoperta della minuzia solo di primo acchito inessenziale, in realtà rivelatrice (il fragile incrocio, fra il tenero e l’arreso, degli sguardi di Bobby Lee e Billy Joe, in “Ode”, o le dita longilinee di Wendy che attraverso una recinzione cercano il muso curioso di Lucy, nel finale di “Wendy and Lucy” o, ancora, il passeggiare di Cozy in equilibrio su un muretto, con sullo sfondo l’eterno accordo misterioso tra cielo e mare, in “River of grass”, et.) e che in “Night moves”, invece, assume le fattezze di diligenti spostamenti laterali della mdp; di fugaci primi piani, più esasperati che dispensatori di promesse; di campi medi che portano-avanti-la-storia più che favorirne l’eco della suggestione. Diventa così conseguente l’arretramento su un piano di maggiore convenzionalità del dispositivo prettamente visuale messo all’opera da Kelly. Per dire: si delinea, tra l’altro e via via che Josh, Dena e Harmon si attrezzano per progettare ed eseguire il proprio proposito criminale, una costante diluizione di quell’approccio conoscitivo al paesaggio di reminiscenza fiamminga (che, come è noto, per l’analisi accurata dei particolari, una certa predilezione per i contesti allusivi, sovente evoca intriganti potenzialità allegoriche), presente - un paio di esempi - in “Ode” e in “Old joy”, a favore di una sua lettura più diretta, ossia in primis funzionale alle occorrenze di base del racconto, in accordo con la scelta utilitaristica dei personaggi (la Natura, per i tre eco-dinamitardi, è più che altro - ecco la matrice alla fin fine ideologica del loro agire - un insieme di strumenti da sfruttare in vista di uno scopo concreto, non l’occasione per recuperare/rinnovare il dialogo interrotto con il lato più spirituale della propria condizione umana), di per sé aliena da qualunque prospettiva trascendentale. Allo stesso modo partecipa lo spettro cromatico (e l’apporto offerto da Christopher Blauvelt anche in “Night moves” registra solo l’ennesimo ritorno nel Cinema della Reichardt di collaboratori che replicano la propria presenza al di là delle strettoie imposte dai rapporti di lavoro), con la predilezione, sulle tinte scure, di un grafismo quasi vistoso, in cui corpi, oggetti e sfondi vengono ben delineati per essere subito riconoscibili: vuoi per la presenza pressoché costante di una luce crepuscolare, quindi non troppo invadente, vuoi per la necessità drammaturgica di convogliare l’acme psicologico del film nelle sequenze notturne propriamente dette, emblemi inequivocabili di quel buio interiore che permea le figure cardine di una comunque insidiosa impenetrabilità, soprattutto per ciò che attiene alla traiettoria individuale di Josh, ossessiva e disperata una volta ceduto al precipitare degli avvenimenti come somma di decisioni indotte dalla radicalità di un’idea, spettro fuggiasco a cui non resta che il nulla, un nulla aspro e solitario (“Potremmo andare da qualche parte, in mezzo al nulla”, supplica al telefono a un evasivo e distaccato Harmon) a cui attaccarsi.
 quei movimenti notturni che non ricalcano tanto e solo lo spirito per certi versi criptico dei loro comportamenti, quanto alludono a un grumo oscuro e inattingibile che ne agita gli animi, in un crescendo di gesti incauti, improbabili e/o irresponsabili e, per sovrappiù, tragicamente inconcludenti, a certificare la pressoché totale immanenza della loro esperienza. Parliamo qui di primato dell’immanenza a scapito della più volte sottolineata ipotesi di trascendenza perseguita fin dall’inizio dal Cinema di Kelly, perché la quasi totalità delle vicissitudini che coinvolge i tre protagonisti - Josh/Eisenberg, taciturno e tormentato addetto presso una cooperativa di prodotti biologici; Dena/Fanning, ragazza borghese solitaria e apprensiva convertita a un ecologismo oltranzista, e lo sfuggente Harmon/Sarsgaard, un passato militare, dalle reali motivazioni indecifrabili ma dalle sufficienti competenze tecniche per allestire un attentato, si sviluppano all’interno di un perimetro di talmente immediata individuazione da lasciare poco spazio, pur nel rispetto formale delle sue prerogative (descrizione lineare della ripetitività della routine giornaliera; dialogare anodino o neutro; espressività recitativa ridotta all’essenziale; frattura traumatica della circolarità degli eventi; chiusura giocata su una inerzia insinuante, et.), al superamento dell’evidenza concreta dei fatti, anzi talvolta accentuandone, come già visto in “Meek’s cutoff”, la componente di più accessibile immedesimazione (là era il sostrato western-avventuroso; qui la correzione thriller), tralasciando quasi del tutto quella sospensione, quella specie di spiritualismo materialista (l’accorgimento per il dettaglio minimale e la promessa metaforica della sua persistenza; l’enigmatica assenza o la vacuità stranamente indagatrice di uno sguardo; lo straniamento conseguente a un particolare punto di vista gettato sul paesaggio, et.), utile a facilitare l’emersione di un imponderabile. In altre parole, “Night moves” (omonimo, tra l’altro, del celebre contro-noir di Penn, di cui condivide la cupa atmosfera avvolta attorno a un mondo caotico e irrazionale a cui ci si illude di potersi opporre tentando di far chiarezza in sé stessi o, come in questo caso, puntando sul gesto eclatante a mo’ di ecumenica metanoia), fin da subito - il film si apre su Josh e Dena che compiono una rapida ricognizione lungo il tratto agibile della diga che hanno intenzione di far saltare al fine di sollecitare un uso più equo delle scarse risorse idriche (ci si lamenta, infatti, che molta acqua venga impiegata per il mantenimento dei sempre più numerosi campi da golf della zona), la continua penuria delle quali sta via via creando difficoltà sempre più grandi agli agricoltori delle aree a cavallo tra la Contea di Jackson e quella di Klamath, nell’Oregon meridionale, teatro della storia - organizza il proprio incedere secondo un classico concatenarsi di situazioni destinate a precipitare in un climax delittuoso denunciando, per ineluttabile coerenza, si potrebbe dire, la resa all’opacità del reale (al deserto senza fatalità delle contingenze), a una sua conclamata inattaccabilità in relazione a ogni atteggiamento che non le sia conforme, unanimità a cui volgersi nella speranza di un oltrepassamento solo nell’ottica di una separazione netta, di una cesura non riproducibile se non nelle fogge di una apparenza sinistra quanto irridente (emblematica a riguardo la sequenza in cui Josh, aspettando Dena nei locali esterni di un centro sauna in odore di ambiente new age, si imbatte nei corpi nudi e cadenti di alcune ospiti, specchio deformato e minaccioso questo, a ben vedere, della placida carnalità giovanile catturata, ad esempio, in “Old joy”). D’altra parte, è il movimento stesso della linea narrativa a riproporre ora il periplo tortuoso ma infecondo di “Meek’s cutoff”, anziché quello, a modo suo schietto dello stesso ”Old joy”, per non dire di quello sconclusionato però, a tratti, spensierato e promettente di “River of grass”: dall’andirivieni per procacciarsi il materiale necessario a portare a termine il sabotaggio (oltre 250 kg. di fertilizzante al nitrato di amile estorto per puro sfinimento al suo riluttante rivenditore/Le Gros), al sopralluogo in barca (la night moves del titolo, che servirà poi da contenitore per l’esplosivo) attraverso una vasta depressione inondata come compensazione dei dislivelli creati a monte dalla diga e ingombra di spogli tronchi a mollo come lapidi vegetali emerse, a futura memoria dei pedaggi dovuti alla modernizzazione; giù fino alla tensione innescata durante la notte fatale da una presenza molesta tale da compromettere il piano, e passando per le incomprensioni che mascherano una qual diffidenza, se non addirittura ostilità, fra i tre caratteri principali, accomunati forse da un massimalismo di principio, per quanto schematico e limitativo (i tre sembrano sussistere solo in ragione dell’autoimposto ruolo di esecutori di un atto materiale - nel caso, scellerato - senza altro a integrarne e giustificarne i giorni, oltreché la militanza), ma di certo non complementari. Josh, infatti, come ricordato, è tanto meticoloso quanto teso oltremodo; Dena dissimula la propria fragilità dietro un contegno e una pignoleria da maestrina (durante il sopraccitato sopralluogo snocciola con precisione ma senza il minimo coinvolgimento le cifre che fotografano il progressivo assottigliarsi della fauna oceanica a fronte del costante incremento della pesca intensiva); Harmon ostenta disinvoltura ma, a volte, sembra persino disinteressato all’impresa o semplicemente assorto in altri pensieri. Ciò che vediamo mano mano delinearsi, cioè, al posto di un rigoroso ed equilibrato alternarsi di piani statici e altrettali inquadrature centrate sull’estrapolazione di dettagli per i quali è decisivo il tempo occorrente a isolarli (a dire, dando loro quella occasione di aprirsi, come visto lungo buona parte della filmografia di Kelly, a un senso ulteriore rispetto alla mera rappresentazione, sul genere di quelle things behind the sun indicate in altro ambito da Nick Drake - il paragone musicale potrebbe non apparire stravagante allorché si riflettesse sull’idea di considerare il percorso delle immagini anche come l’incontro di elementi di una partitura più ampia - And if you see what’s meant to be/Don’t name the day or try to say/It happened before… And see the sun when day is done/If only you see…), in generale sul riproporsi di un moto sotterraneo in grado alla fine di elevare l’opera al di sopra dei suoi moduli ricorrenti (aderenza o ribellione a un genere; plausibilità narrativa; matrice psicologica della recitazione; ruolo del commento sonoro, et.), è altresì un racconto opportunamente raffreddato al centro di una messinscena di impostazione canonica, all’interno della quale non mancano tanto l’elemento spettacolare imprevisto (ad azione compiuta, la sorte cinematografica si incarica di sistemare un villeggiante solitario sulla linea di distruzione della diga così laboriosamente fatta saltare, ampliando di fatto lo spettro delle fattispecie penali a carico dei tre: dall’attentato all’omicidio), quanto la componente emotivo-drammatica (Dena, presto rosa dai sensi di colpa comincia, violando la consegna del silenzio, a telefonare ai suoi complici in cerca di un modo per scrollarsi di dosso l’angoscia montante, innescando un vortice ansioso che travolgerà più il turbato Josh che il compassato Harmon, fino a un esito irrimediabile ma, in una simile logica di scelte stilistico/espressive, scontato, ossia l’eliminazione dell’anello debole/pericoloso: Dena, appunto).
quei movimenti notturni che non ricalcano tanto e solo lo spirito per certi versi criptico dei loro comportamenti, quanto alludono a un grumo oscuro e inattingibile che ne agita gli animi, in un crescendo di gesti incauti, improbabili e/o irresponsabili e, per sovrappiù, tragicamente inconcludenti, a certificare la pressoché totale immanenza della loro esperienza. Parliamo qui di primato dell’immanenza a scapito della più volte sottolineata ipotesi di trascendenza perseguita fin dall’inizio dal Cinema di Kelly, perché la quasi totalità delle vicissitudini che coinvolge i tre protagonisti - Josh/Eisenberg, taciturno e tormentato addetto presso una cooperativa di prodotti biologici; Dena/Fanning, ragazza borghese solitaria e apprensiva convertita a un ecologismo oltranzista, e lo sfuggente Harmon/Sarsgaard, un passato militare, dalle reali motivazioni indecifrabili ma dalle sufficienti competenze tecniche per allestire un attentato, si sviluppano all’interno di un perimetro di talmente immediata individuazione da lasciare poco spazio, pur nel rispetto formale delle sue prerogative (descrizione lineare della ripetitività della routine giornaliera; dialogare anodino o neutro; espressività recitativa ridotta all’essenziale; frattura traumatica della circolarità degli eventi; chiusura giocata su una inerzia insinuante, et.), al superamento dell’evidenza concreta dei fatti, anzi talvolta accentuandone, come già visto in “Meek’s cutoff”, la componente di più accessibile immedesimazione (là era il sostrato western-avventuroso; qui la correzione thriller), tralasciando quasi del tutto quella sospensione, quella specie di spiritualismo materialista (l’accorgimento per il dettaglio minimale e la promessa metaforica della sua persistenza; l’enigmatica assenza o la vacuità stranamente indagatrice di uno sguardo; lo straniamento conseguente a un particolare punto di vista gettato sul paesaggio, et.), utile a facilitare l’emersione di un imponderabile. In altre parole, “Night moves” (omonimo, tra l’altro, del celebre contro-noir di Penn, di cui condivide la cupa atmosfera avvolta attorno a un mondo caotico e irrazionale a cui ci si illude di potersi opporre tentando di far chiarezza in sé stessi o, come in questo caso, puntando sul gesto eclatante a mo’ di ecumenica metanoia), fin da subito - il film si apre su Josh e Dena che compiono una rapida ricognizione lungo il tratto agibile della diga che hanno intenzione di far saltare al fine di sollecitare un uso più equo delle scarse risorse idriche (ci si lamenta, infatti, che molta acqua venga impiegata per il mantenimento dei sempre più numerosi campi da golf della zona), la continua penuria delle quali sta via via creando difficoltà sempre più grandi agli agricoltori delle aree a cavallo tra la Contea di Jackson e quella di Klamath, nell’Oregon meridionale, teatro della storia - organizza il proprio incedere secondo un classico concatenarsi di situazioni destinate a precipitare in un climax delittuoso denunciando, per ineluttabile coerenza, si potrebbe dire, la resa all’opacità del reale (al deserto senza fatalità delle contingenze), a una sua conclamata inattaccabilità in relazione a ogni atteggiamento che non le sia conforme, unanimità a cui volgersi nella speranza di un oltrepassamento solo nell’ottica di una separazione netta, di una cesura non riproducibile se non nelle fogge di una apparenza sinistra quanto irridente (emblematica a riguardo la sequenza in cui Josh, aspettando Dena nei locali esterni di un centro sauna in odore di ambiente new age, si imbatte nei corpi nudi e cadenti di alcune ospiti, specchio deformato e minaccioso questo, a ben vedere, della placida carnalità giovanile catturata, ad esempio, in “Old joy”). D’altra parte, è il movimento stesso della linea narrativa a riproporre ora il periplo tortuoso ma infecondo di “Meek’s cutoff”, anziché quello, a modo suo schietto dello stesso ”Old joy”, per non dire di quello sconclusionato però, a tratti, spensierato e promettente di “River of grass”: dall’andirivieni per procacciarsi il materiale necessario a portare a termine il sabotaggio (oltre 250 kg. di fertilizzante al nitrato di amile estorto per puro sfinimento al suo riluttante rivenditore/Le Gros), al sopralluogo in barca (la night moves del titolo, che servirà poi da contenitore per l’esplosivo) attraverso una vasta depressione inondata come compensazione dei dislivelli creati a monte dalla diga e ingombra di spogli tronchi a mollo come lapidi vegetali emerse, a futura memoria dei pedaggi dovuti alla modernizzazione; giù fino alla tensione innescata durante la notte fatale da una presenza molesta tale da compromettere il piano, e passando per le incomprensioni che mascherano una qual diffidenza, se non addirittura ostilità, fra i tre caratteri principali, accomunati forse da un massimalismo di principio, per quanto schematico e limitativo (i tre sembrano sussistere solo in ragione dell’autoimposto ruolo di esecutori di un atto materiale - nel caso, scellerato - senza altro a integrarne e giustificarne i giorni, oltreché la militanza), ma di certo non complementari. Josh, infatti, come ricordato, è tanto meticoloso quanto teso oltremodo; Dena dissimula la propria fragilità dietro un contegno e una pignoleria da maestrina (durante il sopraccitato sopralluogo snocciola con precisione ma senza il minimo coinvolgimento le cifre che fotografano il progressivo assottigliarsi della fauna oceanica a fronte del costante incremento della pesca intensiva); Harmon ostenta disinvoltura ma, a volte, sembra persino disinteressato all’impresa o semplicemente assorto in altri pensieri. Ciò che vediamo mano mano delinearsi, cioè, al posto di un rigoroso ed equilibrato alternarsi di piani statici e altrettali inquadrature centrate sull’estrapolazione di dettagli per i quali è decisivo il tempo occorrente a isolarli (a dire, dando loro quella occasione di aprirsi, come visto lungo buona parte della filmografia di Kelly, a un senso ulteriore rispetto alla mera rappresentazione, sul genere di quelle things behind the sun indicate in altro ambito da Nick Drake - il paragone musicale potrebbe non apparire stravagante allorché si riflettesse sull’idea di considerare il percorso delle immagini anche come l’incontro di elementi di una partitura più ampia - And if you see what’s meant to be/Don’t name the day or try to say/It happened before… And see the sun when day is done/If only you see…), in generale sul riproporsi di un moto sotterraneo in grado alla fine di elevare l’opera al di sopra dei suoi moduli ricorrenti (aderenza o ribellione a un genere; plausibilità narrativa; matrice psicologica della recitazione; ruolo del commento sonoro, et.), è altresì un racconto opportunamente raffreddato al centro di una messinscena di impostazione canonica, all’interno della quale non mancano tanto l’elemento spettacolare imprevisto (ad azione compiuta, la sorte cinematografica si incarica di sistemare un villeggiante solitario sulla linea di distruzione della diga così laboriosamente fatta saltare, ampliando di fatto lo spettro delle fattispecie penali a carico dei tre: dall’attentato all’omicidio), quanto la componente emotivo-drammatica (Dena, presto rosa dai sensi di colpa comincia, violando la consegna del silenzio, a telefonare ai suoi complici in cerca di un modo per scrollarsi di dosso l’angoscia montante, innescando un vortice ansioso che travolgerà più il turbato Josh che il compassato Harmon, fino a un esito irrimediabile ma, in una simile logica di scelte stilistico/espressive, scontato, ossia l’eliminazione dell’anello debole/pericoloso: Dena, appunto).  Frangenti che il Cinema di Kelly aveva temperato, almeno fino a “Wendy and Lucy”, grazie alla particolare capacità di orchestrare una stilizzazione delicata dei suoi fondamenti, per cui alla destrezza di comporre immagini ieratiche di efficace caratura simbolica (pensiamo all’inquadratura modernissima, pressoché astratta, che indulge sul merci in partenza nell’incipit di “Wendy and Lucy” o al nitore quasi materno di certi frammenti rubati al cuore della foresta in “Old joy”), si abbinava, in semplice eppure miracolosa simbiosi, l’attenzione/scoperta della minuzia solo di primo acchito inessenziale, in realtà rivelatrice (il fragile incrocio, fra il tenero e l’arreso, degli sguardi di Bobby Lee e Billy Joe, in “Ode”, o le dita longilinee di Wendy che attraverso una recinzione cercano il muso curioso di Lucy, nel finale di “Wendy and Lucy” o, ancora, il passeggiare di Cozy in equilibrio su un muretto, con sullo sfondo l’eterno accordo misterioso tra cielo e mare, in “River of grass”, et.) e che in “Night moves”, invece, assume le fattezze di diligenti spostamenti laterali della mdp; di fugaci primi piani, più esasperati che dispensatori di promesse; di campi medi che portano-avanti-la-storia più che favorirne l’eco della suggestione. Diventa così conseguente l’arretramento su un piano di maggiore convenzionalità del dispositivo prettamente visuale messo all’opera da Kelly. Per dire: si delinea, tra l’altro e via via che Josh, Dena e Harmon si attrezzano per progettare ed eseguire il proprio proposito criminale, una costante diluizione di quell’approccio conoscitivo al paesaggio di reminiscenza fiamminga (che, come è noto, per l’analisi accurata dei particolari, una certa predilezione per i contesti allusivi, sovente evoca intriganti potenzialità allegoriche), presente - un paio di esempi - in “Ode” e in “Old joy”, a favore di una sua lettura più diretta, ossia in primis funzionale alle occorrenze di base del racconto, in accordo con la scelta utilitaristica dei personaggi (la Natura, per i tre eco-dinamitardi, è più che altro - ecco la matrice alla fin fine ideologica del loro agire - un insieme di strumenti da sfruttare in vista di uno scopo concreto, non l’occasione per recuperare/rinnovare il dialogo interrotto con il lato più spirituale della propria condizione umana), di per sé aliena da qualunque prospettiva trascendentale. Allo stesso modo partecipa lo spettro cromatico (e l’apporto offerto da Christopher Blauvelt anche in “Night moves” registra solo l’ennesimo ritorno nel Cinema della Reichardt di collaboratori che replicano la propria presenza al di là delle strettoie imposte dai rapporti di lavoro), con la predilezione, sulle tinte scure, di un grafismo quasi vistoso, in cui corpi, oggetti e sfondi vengono ben delineati per essere subito riconoscibili: vuoi per la presenza pressoché costante di una luce crepuscolare, quindi non troppo invadente, vuoi per la necessità drammaturgica di convogliare l’acme psicologico del film nelle sequenze notturne propriamente dette, emblemi inequivocabili di quel buio interiore che permea le figure cardine di una comunque insidiosa impenetrabilità, soprattutto per ciò che attiene alla traiettoria individuale di Josh, ossessiva e disperata una volta ceduto al precipitare degli avvenimenti come somma di decisioni indotte dalla radicalità di un’idea, spettro fuggiasco a cui non resta che il nulla, un nulla aspro e solitario (“Potremmo andare da qualche parte, in mezzo al nulla”, supplica al telefono a un evasivo e distaccato Harmon) a cui attaccarsi.
Frangenti che il Cinema di Kelly aveva temperato, almeno fino a “Wendy and Lucy”, grazie alla particolare capacità di orchestrare una stilizzazione delicata dei suoi fondamenti, per cui alla destrezza di comporre immagini ieratiche di efficace caratura simbolica (pensiamo all’inquadratura modernissima, pressoché astratta, che indulge sul merci in partenza nell’incipit di “Wendy and Lucy” o al nitore quasi materno di certi frammenti rubati al cuore della foresta in “Old joy”), si abbinava, in semplice eppure miracolosa simbiosi, l’attenzione/scoperta della minuzia solo di primo acchito inessenziale, in realtà rivelatrice (il fragile incrocio, fra il tenero e l’arreso, degli sguardi di Bobby Lee e Billy Joe, in “Ode”, o le dita longilinee di Wendy che attraverso una recinzione cercano il muso curioso di Lucy, nel finale di “Wendy and Lucy” o, ancora, il passeggiare di Cozy in equilibrio su un muretto, con sullo sfondo l’eterno accordo misterioso tra cielo e mare, in “River of grass”, et.) e che in “Night moves”, invece, assume le fattezze di diligenti spostamenti laterali della mdp; di fugaci primi piani, più esasperati che dispensatori di promesse; di campi medi che portano-avanti-la-storia più che favorirne l’eco della suggestione. Diventa così conseguente l’arretramento su un piano di maggiore convenzionalità del dispositivo prettamente visuale messo all’opera da Kelly. Per dire: si delinea, tra l’altro e via via che Josh, Dena e Harmon si attrezzano per progettare ed eseguire il proprio proposito criminale, una costante diluizione di quell’approccio conoscitivo al paesaggio di reminiscenza fiamminga (che, come è noto, per l’analisi accurata dei particolari, una certa predilezione per i contesti allusivi, sovente evoca intriganti potenzialità allegoriche), presente - un paio di esempi - in “Ode” e in “Old joy”, a favore di una sua lettura più diretta, ossia in primis funzionale alle occorrenze di base del racconto, in accordo con la scelta utilitaristica dei personaggi (la Natura, per i tre eco-dinamitardi, è più che altro - ecco la matrice alla fin fine ideologica del loro agire - un insieme di strumenti da sfruttare in vista di uno scopo concreto, non l’occasione per recuperare/rinnovare il dialogo interrotto con il lato più spirituale della propria condizione umana), di per sé aliena da qualunque prospettiva trascendentale. Allo stesso modo partecipa lo spettro cromatico (e l’apporto offerto da Christopher Blauvelt anche in “Night moves” registra solo l’ennesimo ritorno nel Cinema della Reichardt di collaboratori che replicano la propria presenza al di là delle strettoie imposte dai rapporti di lavoro), con la predilezione, sulle tinte scure, di un grafismo quasi vistoso, in cui corpi, oggetti e sfondi vengono ben delineati per essere subito riconoscibili: vuoi per la presenza pressoché costante di una luce crepuscolare, quindi non troppo invadente, vuoi per la necessità drammaturgica di convogliare l’acme psicologico del film nelle sequenze notturne propriamente dette, emblemi inequivocabili di quel buio interiore che permea le figure cardine di una comunque insidiosa impenetrabilità, soprattutto per ciò che attiene alla traiettoria individuale di Josh, ossessiva e disperata una volta ceduto al precipitare degli avvenimenti come somma di decisioni indotte dalla radicalità di un’idea, spettro fuggiasco a cui non resta che il nulla, un nulla aspro e solitario (“Potremmo andare da qualche parte, in mezzo al nulla”, supplica al telefono a un evasivo e distaccato Harmon) a cui attaccarsi.***
Come visto, il Cinema di Kelly Reichardt si è distinto anche per uno slancio volto a concedere, nella confusione interessata dei nostri tempi, nella violenza spesso nemmeno sottesa dei suoi rapporti di forza, una opportunità di redenzione - nel significato di una tregua che richiamasse l’importanza di una dimensione dell’esistenza spiritualmente fuori sincrono dalla tirannia di un determinismo che tutto avoca a sé - prendendo poi a dubitare di essa, tanto in relazione a una particolare circostanza isolata nello spazio e nel tempo (“Night moves”), quanto in merito a una prospettiva più generale capace di elevarsi a rango di ammonimento negletto come risultato di un movimento storico (“Meek’s cutoff”). La collocazione più appropriata da riservare, allora, a un lavoro come Certain women (2016) - tra l’altro, unico film di Kelly ad aver superato il milione di dollari al box office - scritto in solitaria a partire dalla combinazione di tre racconti di Maile Meloy contenuti nell’antologia dal titolo “Both ways is the only way I want”, è forse proprio quella situata in una posizione di raccordo rispetto alle due spinte antagoniste sopraddette, allusione, al tempo, al sospetto di una invincibile inestricabilità di ciò che, per comodità,  abbiamo indicato col termine deserto (e vale a dire la vischiosa doppiezza del reale, tanto più quello forgiato dalla modernità; la sostanziale indifferenza nell’intercambiabilità dei suoi legami; la prepotenza dei suoi attributi materialistici, oggi come oggi in grado di assimilare e normalizzare quasi ogni obiezione) e rifiuto di decretarne la supremazia assoluta limitandosi a un compìto e/o sdegnato descrittivismo se non, persino, chiudendosi sic et simpliciter nel silenzio. Di certo, stante il dilemma tutt’altro che banale e, per costituzione, diciamo così, non adatto a soluzioni di corto respiro, Kelly, in “Certain women”, tenta di incidere tanto sulla progressione dinamica che sul tono psicologico della materia che intende rappresentare (e, volendo, l’immagine cha apre l’opera sta lì a sostenerlo: una ampia inquadratura su un’alba livida che introduce in lontananza l’arrivo di un merci, nulla esclude - idealmente, è chiaro - quello che riporta la Wendy di “Wendy and Lucy” a casa dopo la sua fallimentare odissea). Quindi, dapprincipio, torna un tanto sui suoi passi: dalle ripetute sortite operate negli estremi territori del Nord-Ovest, frequentati per almeno un quindicennio a partire da “Then a year” - vd. - ecco cioè che si ritaglia un semi-inedito campo di applicazione nelle distese non meno immense ma un po’ più interne del Montana (cornice, tanto per restare ai ricorsi e alle circolarità più volte incontrate nel suo Cinema, entro cui prende forma il dramma narrato nell’esordio alla regia di Paul Dano, scritto assieme a Zoe Kazan - entrambi visti in “Meek’s cutoff” - “Wildlife”, tratto dal romanzo di Richard Ford), tra Livingston (in fondo distante nemmeno 200 miglia da Great Falls, scenario centrale del film di Dano), Clyde Park e alcuni cosiddetti census-designated places (conglomerati di piccole e piccolissime dimensioni, tipici per i confini topografici non esattamente definiti e per la popolazione assai scarsa), sul genere di Belfry, Edgar, Laurel, et. Cosicché è in questo angolo appartato degli Stati Uniti settentrionali che, alla fine, si svolgono e quasi si incontrano le vite delle tre interpreti principali della presente storia. Troviamo infatti e da subito Laura/(esordio per Laura Dern con Kelly), avvocato alle prese con un ménage adulterino (quello con Ryan/ancora il LeGros intravisto in “Night moves”) più o meno soddisfacente, di sicuro non tanto impegnativo, almeno non quanto quello professionale che la tiene in contatto a più riprese con un suo vecchio cliente - Fuller/Harris - incapace di rassegnarsi, dopo un incidente verificatosi nel cantiere dove lavora e dopo aver accettato per via extra-giudiziale un accordo con la controparte, all’impossibilità di intraprendere una ulteriore azione legale: circostanze, queste, che concorreranno a spezzare in via definitiva il suo già periclitante matrimonio e lo indurranno a un gesto difficile dire se più grottesco o insensato (la presa in ostaggio della stessa Laura - e di un custode notturno di origine polinesiana, Amituana/Fonokalafi - in un ufficio presso gli archivi del Tribunale, allo scopo di farsi leggere ad alta voce gli atti inerenti alla sua causa, per darsi poi alla macchia assecondando un bislacco - ma più che altro vano - piano di fuga). Di seguito facciamo la conoscenza di Gina (di nuovo Michelle Williams) e della tiepida attrazione che la avvicina al compagno Ryan (quello della relazione con Laura) e a una figlia adolescente, apatica e insofferente, di nome Guthrie/Rodier, con la quale il battibecco è all’ordine del giorno. Senza eccessivo trasporto ma con la mite determinazione di coloro avvezzi a ottenere in un modo o nell’altro ciò che vogliono Gina pungola Ryan per far visita al vecchio e solitario Albert/Auberjonois, la casa del quale sorge su un terreno in passato occupato da una scuola - quella del paese al tempo della sua fondazione - i cui grossi mattoni di arenaria che ne costituivano le pareti e che giacciono ammucchiati all’aperto lei intende acquisire al fine di costruire una nuova dimora fuori dal centro abitato di Livingston. Infine ci si sposta (non di molto: parliamo sempre di vicinanze comprese nel Montana meridionale) a Belfry, dove una ragazza/Gladstone si prende cura di un ranch e di un certo numero di cavalli tenendo in esercizio l’intera attività, come prevedono i termini del suo contratto stagionale. Silenziosa e metodica prova a movimentare le sue giornate una uguale all’altra frequentando verso sera i locali della scuola prestati a corsi integrativi di legislazione interna (nello specifico, quelli che riguardano i diritti degli studenti), che le consentono di fare presto la conoscenza della coetanea Elizabeth/(prima volta con la Reichardt anche per Kristen Stewart), giovane praticante legale e insegnante a tempo perso in cerca di un lavoro stabile che le permetta di sfuggire a un domani già scritto fatto di tran-tran, compensi irrisori e depressione latente. I segmenti esistenziali di cui si compone l’opera (dedicata alla Lucy di “Wendy and Lucy” - vd. -) - quelli con al centro Laura e Gina occupano, più o meno, la prima metà del film e, marginalmente, il finale - esprimono, con varianti minime, nella cruda inesorabilità della loro apparenza e segnalando, al tempo, un altro spostamento del Cinema di Kelly, stavolta, come detto, in direzione di un tentativo atto a organizzare una narrazione tanto più sottotono negli accenti quanto più esplicita negli esiti in vista di coniugare un collaudato proposito di stilizzazione all’insolita urgenza di rappresentazione lineare delle vicissitudini dei personaggi, il panorama emotivo impresso sulla faccia nascosta dell’altra America, quella avvilita ma quieta di minuscoli luoghi che contano mai più di poche manciate di anime; che sopravvive con sempre minore capacità di resistenza ai rigori delle logiche di una economia oramai del tutto globalizzata (si pensi alle ricadute che il sedicente capitalismo maturo comporta sui piccoli proprietari terrieri, sugli allevatori, sugli agricoltori - ovviamente non solo americani - et.); i cui componenti spendono il proprio tempo non produttivo (e il proprio scarso denaro) nei centri commerciali - per quanto sparuti a quelle latitudini - o presso ristoranti e bar di paese o, ancora, assumendo dosi massive del barbiturico più a buon mercato di tutti, la televisione (è proprio lo scoramento indotto dall’idea di sorbirsi l’ennesimo quantitativo giornaliero a spronare la ragazza del ranch a raggiungere la scuola di Belfry dove, come descritto, aggregandosi per pura inerzia a un corso di aggiornamento didattico, stringerà un sincero sebbene infruttuoso - perché abortito - sodalizio con Elizabeth). Scopo palese arginare il più possibile la certezza di quanto possa essere asfissiante la solitudine americana, a dire la comune, idiota e opprimente sofferenza del primate occidentale medio passata al tritacarne di un darwinismo sociale autoproclamatosi, nell’acquiescenza pressoché generale, unico e solo spirito del tempo. Non a caso, tutte e tre le certain women del titolo cercano (o si imbattono) - Laura sbirciando Livingston dall’interno del proprio studio; Gina spiando le brulle distanze del Montana da casa di Albert durante una pausa della sua visita; la ragazza del ranch affacciandosi ogni mattina oltre la porta metallica scorrevole delle stalle - un altrove anche momentaneo, un colpo d’occhio più vasto di quello che una consuetudine sempre uguale a sé stessa apparecchia giorno dopo giorno per loro. In tal senso, il tono dello sguardo di Kelly si fa più intimo, aderisce in maniera discreta epperò inequivocabile al destino di queste donne, retaggio così simile nelle coordinate essenziali del suo tessersi e dipanarsi da non abbisognare di sottolineature o sovrapposizioni (Laura, Gina e la ragazza del ranch, cioè, probabilmente non si conosceranno mai: continueranno magari a sfiorarsi per le ovvie intersezioni dovute al caso. La ragazza del ranch, ad esempio, finirà per chiedere informazioni sugli orari e le poliedriche attività di Elizabeth proprio allo studio di Laura, a Livingston, mentre lei vi sta sopraggiungendo), restando, ovvero e per un certo tempo, idealmente collegate senza che la sostanza della loro connessione si materializzi (vedi anche l’affaire di Laura col compagno di Gina). Di conseguenza, pure il passo cinematografico impresso prova a misurarsi con l’esigenza di orchestrare lo sperimentato assunto filosofico volto a trattenere una essenza ulteriore rispetto alla immediatezza materiale della rappresentazione (”Ode” e “Old joy”, in particolare) con l’insorta urgenza/ridimensionamento in un ambito in cui a prevalere è il lato narrativo della vicenda, quello di più istantaneo coinvolgimento (vedi “Meek’s cutoff” e “Night moves”). Così, in “Certain women”, al ritaglio icastico del dettaglio significativo si sostituisce con gradualità l’interrogazione primaria dei volti (numerosi primi piani fissi o in movimento traducono tanto le aspettative recondite delle protagoniste quanto il potenziale allusivo delle loro intenzioni proiettato oltre la trama delle parole e dei gesti); alla meditativa contemplazione paesaggistica misurata su intervalli dilatati utili a prospettarne la valenza simbolica, si privilegia il ritratto naturalistico atto più a caratterizzare l’universo materiale dei fatti raccontati che la loro teorica qualità allegorica, in una accorta ricerca di nessi e giunti la cui mimesi con l‘impianto narrativo corre quasi esclusivamente sulla superficie del visibile. Il risultato è una messinscena ibrida, se così si può dire, all’interno della quale l’iterazione/reiterazione dei dialoghi, degli atteggiamenti, delle emozioni, l’eventualità del loro trascendere l’evidenza, viene costruita e proposta in genere a partire da una singola inquadratura o da un campo medio il più delle volte proteso - nel caso - verso un immoto paesaggio invernale, espediente adatto a indirizzare l’attenzione - per dire - sulla alacrità della ragazza del ranch, sulle sue costanti premure, senza però escludere mai l’ambiente in cui tutto ciò accade, ossia riconoscendo parimenti sempre a esso la peculiarità/intenzione virtuale di sovvertirne l’equilibrio, in un rincorrersi di scenari - drammatici, sentimentali, ironici, patetici, interlocutori - che ricorda, tra i tanti, l’esprit della prosa di una scrittrice come Amy Hempel, il suo procedere falsamente arreso, in verità sintomatico e sempre disponibile nei confronti di qualcosa di imminente. Ascoltiamola: Quello che sembra pericoloso spesso non lo è: i serpenti neri, per esempio, o i vuoti d’aria. Mentre le cose che stanno lì, immobili, come questa spiaggia, sono dense di pericoli. Una polvere gialla che si alza dalla terra, un caldo che fa maturare i meloni dall’oggi al domani: tempo da terremoto. Sei seduta a intrecciare la frangia dell’asciugamano, e d’un tratto la sabbia viene risucchiata come in una clessidra. C’è un rombo nell’aria. Negli appartamenti a buon mercato davanti alla spiaggia, le vasche da bagno si riempiono da sole, e i giardini si sollevano e si arrotolano come onde verdi. Se non succede niente, la polvere continuerà a disperdersi e il caldo a crescere finché la paura non si muterà in desiderio. Una tensione del genere può venire allentata solo da una catastrofe. O anche: I fiori galoppavano nei campi senza spine, fermandosi solo quando venivano recisi e messi nell’acqua. Le liste della spesa si allungavano fino a comprendere le carote per il cavallo dei vicini, tutto nero a eccezione della groppa, che sembrava spruzzata di bianco e di nero: un cavallo che al crepuscolo correva come un matto dentro al recinto, e che si chiamava Fury.
abbiamo indicato col termine deserto (e vale a dire la vischiosa doppiezza del reale, tanto più quello forgiato dalla modernità; la sostanziale indifferenza nell’intercambiabilità dei suoi legami; la prepotenza dei suoi attributi materialistici, oggi come oggi in grado di assimilare e normalizzare quasi ogni obiezione) e rifiuto di decretarne la supremazia assoluta limitandosi a un compìto e/o sdegnato descrittivismo se non, persino, chiudendosi sic et simpliciter nel silenzio. Di certo, stante il dilemma tutt’altro che banale e, per costituzione, diciamo così, non adatto a soluzioni di corto respiro, Kelly, in “Certain women”, tenta di incidere tanto sulla progressione dinamica che sul tono psicologico della materia che intende rappresentare (e, volendo, l’immagine cha apre l’opera sta lì a sostenerlo: una ampia inquadratura su un’alba livida che introduce in lontananza l’arrivo di un merci, nulla esclude - idealmente, è chiaro - quello che riporta la Wendy di “Wendy and Lucy” a casa dopo la sua fallimentare odissea). Quindi, dapprincipio, torna un tanto sui suoi passi: dalle ripetute sortite operate negli estremi territori del Nord-Ovest, frequentati per almeno un quindicennio a partire da “Then a year” - vd. - ecco cioè che si ritaglia un semi-inedito campo di applicazione nelle distese non meno immense ma un po’ più interne del Montana (cornice, tanto per restare ai ricorsi e alle circolarità più volte incontrate nel suo Cinema, entro cui prende forma il dramma narrato nell’esordio alla regia di Paul Dano, scritto assieme a Zoe Kazan - entrambi visti in “Meek’s cutoff” - “Wildlife”, tratto dal romanzo di Richard Ford), tra Livingston (in fondo distante nemmeno 200 miglia da Great Falls, scenario centrale del film di Dano), Clyde Park e alcuni cosiddetti census-designated places (conglomerati di piccole e piccolissime dimensioni, tipici per i confini topografici non esattamente definiti e per la popolazione assai scarsa), sul genere di Belfry, Edgar, Laurel, et. Cosicché è in questo angolo appartato degli Stati Uniti settentrionali che, alla fine, si svolgono e quasi si incontrano le vite delle tre interpreti principali della presente storia. Troviamo infatti e da subito Laura/(esordio per Laura Dern con Kelly), avvocato alle prese con un ménage adulterino (quello con Ryan/ancora il LeGros intravisto in “Night moves”) più o meno soddisfacente, di sicuro non tanto impegnativo, almeno non quanto quello professionale che la tiene in contatto a più riprese con un suo vecchio cliente - Fuller/Harris - incapace di rassegnarsi, dopo un incidente verificatosi nel cantiere dove lavora e dopo aver accettato per via extra-giudiziale un accordo con la controparte, all’impossibilità di intraprendere una ulteriore azione legale: circostanze, queste, che concorreranno a spezzare in via definitiva il suo già periclitante matrimonio e lo indurranno a un gesto difficile dire se più grottesco o insensato (la presa in ostaggio della stessa Laura - e di un custode notturno di origine polinesiana, Amituana/Fonokalafi - in un ufficio presso gli archivi del Tribunale, allo scopo di farsi leggere ad alta voce gli atti inerenti alla sua causa, per darsi poi alla macchia assecondando un bislacco - ma più che altro vano - piano di fuga). Di seguito facciamo la conoscenza di Gina (di nuovo Michelle Williams) e della tiepida attrazione che la avvicina al compagno Ryan (quello della relazione con Laura) e a una figlia adolescente, apatica e insofferente, di nome Guthrie/Rodier, con la quale il battibecco è all’ordine del giorno. Senza eccessivo trasporto ma con la mite determinazione di coloro avvezzi a ottenere in un modo o nell’altro ciò che vogliono Gina pungola Ryan per far visita al vecchio e solitario Albert/Auberjonois, la casa del quale sorge su un terreno in passato occupato da una scuola - quella del paese al tempo della sua fondazione - i cui grossi mattoni di arenaria che ne costituivano le pareti e che giacciono ammucchiati all’aperto lei intende acquisire al fine di costruire una nuova dimora fuori dal centro abitato di Livingston. Infine ci si sposta (non di molto: parliamo sempre di vicinanze comprese nel Montana meridionale) a Belfry, dove una ragazza/Gladstone si prende cura di un ranch e di un certo numero di cavalli tenendo in esercizio l’intera attività, come prevedono i termini del suo contratto stagionale. Silenziosa e metodica prova a movimentare le sue giornate una uguale all’altra frequentando verso sera i locali della scuola prestati a corsi integrativi di legislazione interna (nello specifico, quelli che riguardano i diritti degli studenti), che le consentono di fare presto la conoscenza della coetanea Elizabeth/(prima volta con la Reichardt anche per Kristen Stewart), giovane praticante legale e insegnante a tempo perso in cerca di un lavoro stabile che le permetta di sfuggire a un domani già scritto fatto di tran-tran, compensi irrisori e depressione latente. I segmenti esistenziali di cui si compone l’opera (dedicata alla Lucy di “Wendy and Lucy” - vd. -) - quelli con al centro Laura e Gina occupano, più o meno, la prima metà del film e, marginalmente, il finale - esprimono, con varianti minime, nella cruda inesorabilità della loro apparenza e segnalando, al tempo, un altro spostamento del Cinema di Kelly, stavolta, come detto, in direzione di un tentativo atto a organizzare una narrazione tanto più sottotono negli accenti quanto più esplicita negli esiti in vista di coniugare un collaudato proposito di stilizzazione all’insolita urgenza di rappresentazione lineare delle vicissitudini dei personaggi, il panorama emotivo impresso sulla faccia nascosta dell’altra America, quella avvilita ma quieta di minuscoli luoghi che contano mai più di poche manciate di anime; che sopravvive con sempre minore capacità di resistenza ai rigori delle logiche di una economia oramai del tutto globalizzata (si pensi alle ricadute che il sedicente capitalismo maturo comporta sui piccoli proprietari terrieri, sugli allevatori, sugli agricoltori - ovviamente non solo americani - et.); i cui componenti spendono il proprio tempo non produttivo (e il proprio scarso denaro) nei centri commerciali - per quanto sparuti a quelle latitudini - o presso ristoranti e bar di paese o, ancora, assumendo dosi massive del barbiturico più a buon mercato di tutti, la televisione (è proprio lo scoramento indotto dall’idea di sorbirsi l’ennesimo quantitativo giornaliero a spronare la ragazza del ranch a raggiungere la scuola di Belfry dove, come descritto, aggregandosi per pura inerzia a un corso di aggiornamento didattico, stringerà un sincero sebbene infruttuoso - perché abortito - sodalizio con Elizabeth). Scopo palese arginare il più possibile la certezza di quanto possa essere asfissiante la solitudine americana, a dire la comune, idiota e opprimente sofferenza del primate occidentale medio passata al tritacarne di un darwinismo sociale autoproclamatosi, nell’acquiescenza pressoché generale, unico e solo spirito del tempo. Non a caso, tutte e tre le certain women del titolo cercano (o si imbattono) - Laura sbirciando Livingston dall’interno del proprio studio; Gina spiando le brulle distanze del Montana da casa di Albert durante una pausa della sua visita; la ragazza del ranch affacciandosi ogni mattina oltre la porta metallica scorrevole delle stalle - un altrove anche momentaneo, un colpo d’occhio più vasto di quello che una consuetudine sempre uguale a sé stessa apparecchia giorno dopo giorno per loro. In tal senso, il tono dello sguardo di Kelly si fa più intimo, aderisce in maniera discreta epperò inequivocabile al destino di queste donne, retaggio così simile nelle coordinate essenziali del suo tessersi e dipanarsi da non abbisognare di sottolineature o sovrapposizioni (Laura, Gina e la ragazza del ranch, cioè, probabilmente non si conosceranno mai: continueranno magari a sfiorarsi per le ovvie intersezioni dovute al caso. La ragazza del ranch, ad esempio, finirà per chiedere informazioni sugli orari e le poliedriche attività di Elizabeth proprio allo studio di Laura, a Livingston, mentre lei vi sta sopraggiungendo), restando, ovvero e per un certo tempo, idealmente collegate senza che la sostanza della loro connessione si materializzi (vedi anche l’affaire di Laura col compagno di Gina). Di conseguenza, pure il passo cinematografico impresso prova a misurarsi con l’esigenza di orchestrare lo sperimentato assunto filosofico volto a trattenere una essenza ulteriore rispetto alla immediatezza materiale della rappresentazione (”Ode” e “Old joy”, in particolare) con l’insorta urgenza/ridimensionamento in un ambito in cui a prevalere è il lato narrativo della vicenda, quello di più istantaneo coinvolgimento (vedi “Meek’s cutoff” e “Night moves”). Così, in “Certain women”, al ritaglio icastico del dettaglio significativo si sostituisce con gradualità l’interrogazione primaria dei volti (numerosi primi piani fissi o in movimento traducono tanto le aspettative recondite delle protagoniste quanto il potenziale allusivo delle loro intenzioni proiettato oltre la trama delle parole e dei gesti); alla meditativa contemplazione paesaggistica misurata su intervalli dilatati utili a prospettarne la valenza simbolica, si privilegia il ritratto naturalistico atto più a caratterizzare l’universo materiale dei fatti raccontati che la loro teorica qualità allegorica, in una accorta ricerca di nessi e giunti la cui mimesi con l‘impianto narrativo corre quasi esclusivamente sulla superficie del visibile. Il risultato è una messinscena ibrida, se così si può dire, all’interno della quale l’iterazione/reiterazione dei dialoghi, degli atteggiamenti, delle emozioni, l’eventualità del loro trascendere l’evidenza, viene costruita e proposta in genere a partire da una singola inquadratura o da un campo medio il più delle volte proteso - nel caso - verso un immoto paesaggio invernale, espediente adatto a indirizzare l’attenzione - per dire - sulla alacrità della ragazza del ranch, sulle sue costanti premure, senza però escludere mai l’ambiente in cui tutto ciò accade, ossia riconoscendo parimenti sempre a esso la peculiarità/intenzione virtuale di sovvertirne l’equilibrio, in un rincorrersi di scenari - drammatici, sentimentali, ironici, patetici, interlocutori - che ricorda, tra i tanti, l’esprit della prosa di una scrittrice come Amy Hempel, il suo procedere falsamente arreso, in verità sintomatico e sempre disponibile nei confronti di qualcosa di imminente. Ascoltiamola: Quello che sembra pericoloso spesso non lo è: i serpenti neri, per esempio, o i vuoti d’aria. Mentre le cose che stanno lì, immobili, come questa spiaggia, sono dense di pericoli. Una polvere gialla che si alza dalla terra, un caldo che fa maturare i meloni dall’oggi al domani: tempo da terremoto. Sei seduta a intrecciare la frangia dell’asciugamano, e d’un tratto la sabbia viene risucchiata come in una clessidra. C’è un rombo nell’aria. Negli appartamenti a buon mercato davanti alla spiaggia, le vasche da bagno si riempiono da sole, e i giardini si sollevano e si arrotolano come onde verdi. Se non succede niente, la polvere continuerà a disperdersi e il caldo a crescere finché la paura non si muterà in desiderio. Una tensione del genere può venire allentata solo da una catastrofe. O anche: I fiori galoppavano nei campi senza spine, fermandosi solo quando venivano recisi e messi nell’acqua. Le liste della spesa si allungavano fino a comprendere le carote per il cavallo dei vicini, tutto nero a eccezione della groppa, che sembrava spruzzata di bianco e di nero: un cavallo che al crepuscolo correva come un matto dentro al recinto, e che si chiamava Fury.  E ancora: Il mohair pizzicava, le strisce ingoffavano, ma il tweed filato a mano era perfetto per una taglia piccola. Comprai alcune matasse, di un blu ardesia addolcito da puntini rosa, e due ferri numero sei, per un maglione caldo ma leggero. Scelsi un modello bicolore, con lo scollo a V e una treccia su sei maglie, facoltativa, sul davanti. I pullover scompigliano i capelli, ma non volevo cimentarmi subito con le asole. Brani disparati che, con la dovuta cautela, sembrano però davvero riprodurre i caratteri delle protagoniste del, fino a ora, ultimo film di Kelly disponibile (“First cow”, ritorno alla collaborazione con Jon Raymond, al momento della redazione di questo scritto, è in post-produzione): fiducioso ma apprensivo, quello di Laura; riservato e ingenuo, quello della ragazza del ranch; volitivo quanto inappagato, quello di Gina. Ciascuno diverso e irripetibile, cionondimeno messaggero di un desiderio che non si esaurisce nell’esaudimento di un suo anche a lungo coltivato capriccio. Su una similare lunghezza d’onda oscilla, inoltre, anche il registro delle cromie adottate, buona parte delle quali - e non solo perché a disciplinarle troviamo per la terza volta Christopher Blauvelt - ripropone e amplia le soluzioni sperimentate per lo più in “Night moves”. Si nota, in altre parole e di nuovo, una qual preminenza delle tonalità scure, in specie per ciò che attiene agli interni e al profilo dei volti per contro irradiati da una luce diafana, quasi alabastrina che, qua e là, ricorda la suggestiva ritrattistica di Eakins. Meno contrastata e più uniforme, a evidenziare una sorta di continuità palpabile entro un mondo che sotto il brulicare irruente delle prestazioni mercantili mantiene un suo indelebile, tutto sommato ambiguo pallore (esaltato, peraltro, dal clima rigido di stagione), è la luminosità che descrive i contorni dell’ambiente fisico - vallate, fiumi, boschi, montagne - e i limiti dell’intraprendenza umana - le architetture degli edifici di Livingston; le strade poco trafficate di Belfry; i negozi quasi senza avventori; gli spazi scostanti degli uffici, et. - omologa, per tanti versi, al chiarore freddo che effonde dagli squarci innevati di un altro pensabile riferimento pittorico, quello di Lawson. Entrambe le gradazioni accompagnate, di quando in quando, dalla malinconia trattenuta del commento musicale di Jeff Grace (anche lui alla terza collaborazione con Kelly) e, più ancora, dalla grazia timida tessuta dalla chitarra di Smokey Hormel (della partita già da “Old joy”). Malinconia e grazia che - è appena il caso di ricordarlo qui, in chiusura, e allargando la visuale - si intrecciano senza sforzo e di continuo al corso delle nostre stesse vite, così spesso smarrite e dolenti, eppure talvolta alleggerite da una singolare istanza di compassione e innalzamento, esattamente quella che Kelly Reichardt col suo Cinema prova a inseguire e con dolce tristezza si ostina a celebrare, prima che il deserto ci sommerga.
E ancora: Il mohair pizzicava, le strisce ingoffavano, ma il tweed filato a mano era perfetto per una taglia piccola. Comprai alcune matasse, di un blu ardesia addolcito da puntini rosa, e due ferri numero sei, per un maglione caldo ma leggero. Scelsi un modello bicolore, con lo scollo a V e una treccia su sei maglie, facoltativa, sul davanti. I pullover scompigliano i capelli, ma non volevo cimentarmi subito con le asole. Brani disparati che, con la dovuta cautela, sembrano però davvero riprodurre i caratteri delle protagoniste del, fino a ora, ultimo film di Kelly disponibile (“First cow”, ritorno alla collaborazione con Jon Raymond, al momento della redazione di questo scritto, è in post-produzione): fiducioso ma apprensivo, quello di Laura; riservato e ingenuo, quello della ragazza del ranch; volitivo quanto inappagato, quello di Gina. Ciascuno diverso e irripetibile, cionondimeno messaggero di un desiderio che non si esaurisce nell’esaudimento di un suo anche a lungo coltivato capriccio. Su una similare lunghezza d’onda oscilla, inoltre, anche il registro delle cromie adottate, buona parte delle quali - e non solo perché a disciplinarle troviamo per la terza volta Christopher Blauvelt - ripropone e amplia le soluzioni sperimentate per lo più in “Night moves”. Si nota, in altre parole e di nuovo, una qual preminenza delle tonalità scure, in specie per ciò che attiene agli interni e al profilo dei volti per contro irradiati da una luce diafana, quasi alabastrina che, qua e là, ricorda la suggestiva ritrattistica di Eakins. Meno contrastata e più uniforme, a evidenziare una sorta di continuità palpabile entro un mondo che sotto il brulicare irruente delle prestazioni mercantili mantiene un suo indelebile, tutto sommato ambiguo pallore (esaltato, peraltro, dal clima rigido di stagione), è la luminosità che descrive i contorni dell’ambiente fisico - vallate, fiumi, boschi, montagne - e i limiti dell’intraprendenza umana - le architetture degli edifici di Livingston; le strade poco trafficate di Belfry; i negozi quasi senza avventori; gli spazi scostanti degli uffici, et. - omologa, per tanti versi, al chiarore freddo che effonde dagli squarci innevati di un altro pensabile riferimento pittorico, quello di Lawson. Entrambe le gradazioni accompagnate, di quando in quando, dalla malinconia trattenuta del commento musicale di Jeff Grace (anche lui alla terza collaborazione con Kelly) e, più ancora, dalla grazia timida tessuta dalla chitarra di Smokey Hormel (della partita già da “Old joy”). Malinconia e grazia che - è appena il caso di ricordarlo qui, in chiusura, e allargando la visuale - si intrecciano senza sforzo e di continuo al corso delle nostre stesse vite, così spesso smarrite e dolenti, eppure talvolta alleggerite da una singolare istanza di compassione e innalzamento, esattamente quella che Kelly Reichardt col suo Cinema prova a inseguire e con dolce tristezza si ostina a celebrare, prima che il deserto ci sommerga.
 abbiamo indicato col termine deserto (e vale a dire la vischiosa doppiezza del reale, tanto più quello forgiato dalla modernità; la sostanziale indifferenza nell’intercambiabilità dei suoi legami; la prepotenza dei suoi attributi materialistici, oggi come oggi in grado di assimilare e normalizzare quasi ogni obiezione) e rifiuto di decretarne la supremazia assoluta limitandosi a un compìto e/o sdegnato descrittivismo se non, persino, chiudendosi sic et simpliciter nel silenzio. Di certo, stante il dilemma tutt’altro che banale e, per costituzione, diciamo così, non adatto a soluzioni di corto respiro, Kelly, in “Certain women”, tenta di incidere tanto sulla progressione dinamica che sul tono psicologico della materia che intende rappresentare (e, volendo, l’immagine cha apre l’opera sta lì a sostenerlo: una ampia inquadratura su un’alba livida che introduce in lontananza l’arrivo di un merci, nulla esclude - idealmente, è chiaro - quello che riporta la Wendy di “Wendy and Lucy” a casa dopo la sua fallimentare odissea). Quindi, dapprincipio, torna un tanto sui suoi passi: dalle ripetute sortite operate negli estremi territori del Nord-Ovest, frequentati per almeno un quindicennio a partire da “Then a year” - vd. - ecco cioè che si ritaglia un semi-inedito campo di applicazione nelle distese non meno immense ma un po’ più interne del Montana (cornice, tanto per restare ai ricorsi e alle circolarità più volte incontrate nel suo Cinema, entro cui prende forma il dramma narrato nell’esordio alla regia di Paul Dano, scritto assieme a Zoe Kazan - entrambi visti in “Meek’s cutoff” - “Wildlife”, tratto dal romanzo di Richard Ford), tra Livingston (in fondo distante nemmeno 200 miglia da Great Falls, scenario centrale del film di Dano), Clyde Park e alcuni cosiddetti census-designated places (conglomerati di piccole e piccolissime dimensioni, tipici per i confini topografici non esattamente definiti e per la popolazione assai scarsa), sul genere di Belfry, Edgar, Laurel, et. Cosicché è in questo angolo appartato degli Stati Uniti settentrionali che, alla fine, si svolgono e quasi si incontrano le vite delle tre interpreti principali della presente storia. Troviamo infatti e da subito Laura/(esordio per Laura Dern con Kelly), avvocato alle prese con un ménage adulterino (quello con Ryan/ancora il LeGros intravisto in “Night moves”) più o meno soddisfacente, di sicuro non tanto impegnativo, almeno non quanto quello professionale che la tiene in contatto a più riprese con un suo vecchio cliente - Fuller/Harris - incapace di rassegnarsi, dopo un incidente verificatosi nel cantiere dove lavora e dopo aver accettato per via extra-giudiziale un accordo con la controparte, all’impossibilità di intraprendere una ulteriore azione legale: circostanze, queste, che concorreranno a spezzare in via definitiva il suo già periclitante matrimonio e lo indurranno a un gesto difficile dire se più grottesco o insensato (la presa in ostaggio della stessa Laura - e di un custode notturno di origine polinesiana, Amituana/Fonokalafi - in un ufficio presso gli archivi del Tribunale, allo scopo di farsi leggere ad alta voce gli atti inerenti alla sua causa, per darsi poi alla macchia assecondando un bislacco - ma più che altro vano - piano di fuga). Di seguito facciamo la conoscenza di Gina (di nuovo Michelle Williams) e della tiepida attrazione che la avvicina al compagno Ryan (quello della relazione con Laura) e a una figlia adolescente, apatica e insofferente, di nome Guthrie/Rodier, con la quale il battibecco è all’ordine del giorno. Senza eccessivo trasporto ma con la mite determinazione di coloro avvezzi a ottenere in un modo o nell’altro ciò che vogliono Gina pungola Ryan per far visita al vecchio e solitario Albert/Auberjonois, la casa del quale sorge su un terreno in passato occupato da una scuola - quella del paese al tempo della sua fondazione - i cui grossi mattoni di arenaria che ne costituivano le pareti e che giacciono ammucchiati all’aperto lei intende acquisire al fine di costruire una nuova dimora fuori dal centro abitato di Livingston. Infine ci si sposta (non di molto: parliamo sempre di vicinanze comprese nel Montana meridionale) a Belfry, dove una ragazza/Gladstone si prende cura di un ranch e di un certo numero di cavalli tenendo in esercizio l’intera attività, come prevedono i termini del suo contratto stagionale. Silenziosa e metodica prova a movimentare le sue giornate una uguale all’altra frequentando verso sera i locali della scuola prestati a corsi integrativi di legislazione interna (nello specifico, quelli che riguardano i diritti degli studenti), che le consentono di fare presto la conoscenza della coetanea Elizabeth/(prima volta con la Reichardt anche per Kristen Stewart), giovane praticante legale e insegnante a tempo perso in cerca di un lavoro stabile che le permetta di sfuggire a un domani già scritto fatto di tran-tran, compensi irrisori e depressione latente. I segmenti esistenziali di cui si compone l’opera (dedicata alla Lucy di “Wendy and Lucy” - vd. -) - quelli con al centro Laura e Gina occupano, più o meno, la prima metà del film e, marginalmente, il finale - esprimono, con varianti minime, nella cruda inesorabilità della loro apparenza e segnalando, al tempo, un altro spostamento del Cinema di Kelly, stavolta, come detto, in direzione di un tentativo atto a organizzare una narrazione tanto più sottotono negli accenti quanto più esplicita negli esiti in vista di coniugare un collaudato proposito di stilizzazione all’insolita urgenza di rappresentazione lineare delle vicissitudini dei personaggi, il panorama emotivo impresso sulla faccia nascosta dell’altra America, quella avvilita ma quieta di minuscoli luoghi che contano mai più di poche manciate di anime; che sopravvive con sempre minore capacità di resistenza ai rigori delle logiche di una economia oramai del tutto globalizzata (si pensi alle ricadute che il sedicente capitalismo maturo comporta sui piccoli proprietari terrieri, sugli allevatori, sugli agricoltori - ovviamente non solo americani - et.); i cui componenti spendono il proprio tempo non produttivo (e il proprio scarso denaro) nei centri commerciali - per quanto sparuti a quelle latitudini - o presso ristoranti e bar di paese o, ancora, assumendo dosi massive del barbiturico più a buon mercato di tutti, la televisione (è proprio lo scoramento indotto dall’idea di sorbirsi l’ennesimo quantitativo giornaliero a spronare la ragazza del ranch a raggiungere la scuola di Belfry dove, come descritto, aggregandosi per pura inerzia a un corso di aggiornamento didattico, stringerà un sincero sebbene infruttuoso - perché abortito - sodalizio con Elizabeth). Scopo palese arginare il più possibile la certezza di quanto possa essere asfissiante la solitudine americana, a dire la comune, idiota e opprimente sofferenza del primate occidentale medio passata al tritacarne di un darwinismo sociale autoproclamatosi, nell’acquiescenza pressoché generale, unico e solo spirito del tempo. Non a caso, tutte e tre le certain women del titolo cercano (o si imbattono) - Laura sbirciando Livingston dall’interno del proprio studio; Gina spiando le brulle distanze del Montana da casa di Albert durante una pausa della sua visita; la ragazza del ranch affacciandosi ogni mattina oltre la porta metallica scorrevole delle stalle - un altrove anche momentaneo, un colpo d’occhio più vasto di quello che una consuetudine sempre uguale a sé stessa apparecchia giorno dopo giorno per loro. In tal senso, il tono dello sguardo di Kelly si fa più intimo, aderisce in maniera discreta epperò inequivocabile al destino di queste donne, retaggio così simile nelle coordinate essenziali del suo tessersi e dipanarsi da non abbisognare di sottolineature o sovrapposizioni (Laura, Gina e la ragazza del ranch, cioè, probabilmente non si conosceranno mai: continueranno magari a sfiorarsi per le ovvie intersezioni dovute al caso. La ragazza del ranch, ad esempio, finirà per chiedere informazioni sugli orari e le poliedriche attività di Elizabeth proprio allo studio di Laura, a Livingston, mentre lei vi sta sopraggiungendo), restando, ovvero e per un certo tempo, idealmente collegate senza che la sostanza della loro connessione si materializzi (vedi anche l’affaire di Laura col compagno di Gina). Di conseguenza, pure il passo cinematografico impresso prova a misurarsi con l’esigenza di orchestrare lo sperimentato assunto filosofico volto a trattenere una essenza ulteriore rispetto alla immediatezza materiale della rappresentazione (”Ode” e “Old joy”, in particolare) con l’insorta urgenza/ridimensionamento in un ambito in cui a prevalere è il lato narrativo della vicenda, quello di più istantaneo coinvolgimento (vedi “Meek’s cutoff” e “Night moves”). Così, in “Certain women”, al ritaglio icastico del dettaglio significativo si sostituisce con gradualità l’interrogazione primaria dei volti (numerosi primi piani fissi o in movimento traducono tanto le aspettative recondite delle protagoniste quanto il potenziale allusivo delle loro intenzioni proiettato oltre la trama delle parole e dei gesti); alla meditativa contemplazione paesaggistica misurata su intervalli dilatati utili a prospettarne la valenza simbolica, si privilegia il ritratto naturalistico atto più a caratterizzare l’universo materiale dei fatti raccontati che la loro teorica qualità allegorica, in una accorta ricerca di nessi e giunti la cui mimesi con l‘impianto narrativo corre quasi esclusivamente sulla superficie del visibile. Il risultato è una messinscena ibrida, se così si può dire, all’interno della quale l’iterazione/reiterazione dei dialoghi, degli atteggiamenti, delle emozioni, l’eventualità del loro trascendere l’evidenza, viene costruita e proposta in genere a partire da una singola inquadratura o da un campo medio il più delle volte proteso - nel caso - verso un immoto paesaggio invernale, espediente adatto a indirizzare l’attenzione - per dire - sulla alacrità della ragazza del ranch, sulle sue costanti premure, senza però escludere mai l’ambiente in cui tutto ciò accade, ossia riconoscendo parimenti sempre a esso la peculiarità/intenzione virtuale di sovvertirne l’equilibrio, in un rincorrersi di scenari - drammatici, sentimentali, ironici, patetici, interlocutori - che ricorda, tra i tanti, l’esprit della prosa di una scrittrice come Amy Hempel, il suo procedere falsamente arreso, in verità sintomatico e sempre disponibile nei confronti di qualcosa di imminente. Ascoltiamola: Quello che sembra pericoloso spesso non lo è: i serpenti neri, per esempio, o i vuoti d’aria. Mentre le cose che stanno lì, immobili, come questa spiaggia, sono dense di pericoli. Una polvere gialla che si alza dalla terra, un caldo che fa maturare i meloni dall’oggi al domani: tempo da terremoto. Sei seduta a intrecciare la frangia dell’asciugamano, e d’un tratto la sabbia viene risucchiata come in una clessidra. C’è un rombo nell’aria. Negli appartamenti a buon mercato davanti alla spiaggia, le vasche da bagno si riempiono da sole, e i giardini si sollevano e si arrotolano come onde verdi. Se non succede niente, la polvere continuerà a disperdersi e il caldo a crescere finché la paura non si muterà in desiderio. Una tensione del genere può venire allentata solo da una catastrofe. O anche: I fiori galoppavano nei campi senza spine, fermandosi solo quando venivano recisi e messi nell’acqua. Le liste della spesa si allungavano fino a comprendere le carote per il cavallo dei vicini, tutto nero a eccezione della groppa, che sembrava spruzzata di bianco e di nero: un cavallo che al crepuscolo correva come un matto dentro al recinto, e che si chiamava Fury.
abbiamo indicato col termine deserto (e vale a dire la vischiosa doppiezza del reale, tanto più quello forgiato dalla modernità; la sostanziale indifferenza nell’intercambiabilità dei suoi legami; la prepotenza dei suoi attributi materialistici, oggi come oggi in grado di assimilare e normalizzare quasi ogni obiezione) e rifiuto di decretarne la supremazia assoluta limitandosi a un compìto e/o sdegnato descrittivismo se non, persino, chiudendosi sic et simpliciter nel silenzio. Di certo, stante il dilemma tutt’altro che banale e, per costituzione, diciamo così, non adatto a soluzioni di corto respiro, Kelly, in “Certain women”, tenta di incidere tanto sulla progressione dinamica che sul tono psicologico della materia che intende rappresentare (e, volendo, l’immagine cha apre l’opera sta lì a sostenerlo: una ampia inquadratura su un’alba livida che introduce in lontananza l’arrivo di un merci, nulla esclude - idealmente, è chiaro - quello che riporta la Wendy di “Wendy and Lucy” a casa dopo la sua fallimentare odissea). Quindi, dapprincipio, torna un tanto sui suoi passi: dalle ripetute sortite operate negli estremi territori del Nord-Ovest, frequentati per almeno un quindicennio a partire da “Then a year” - vd. - ecco cioè che si ritaglia un semi-inedito campo di applicazione nelle distese non meno immense ma un po’ più interne del Montana (cornice, tanto per restare ai ricorsi e alle circolarità più volte incontrate nel suo Cinema, entro cui prende forma il dramma narrato nell’esordio alla regia di Paul Dano, scritto assieme a Zoe Kazan - entrambi visti in “Meek’s cutoff” - “Wildlife”, tratto dal romanzo di Richard Ford), tra Livingston (in fondo distante nemmeno 200 miglia da Great Falls, scenario centrale del film di Dano), Clyde Park e alcuni cosiddetti census-designated places (conglomerati di piccole e piccolissime dimensioni, tipici per i confini topografici non esattamente definiti e per la popolazione assai scarsa), sul genere di Belfry, Edgar, Laurel, et. Cosicché è in questo angolo appartato degli Stati Uniti settentrionali che, alla fine, si svolgono e quasi si incontrano le vite delle tre interpreti principali della presente storia. Troviamo infatti e da subito Laura/(esordio per Laura Dern con Kelly), avvocato alle prese con un ménage adulterino (quello con Ryan/ancora il LeGros intravisto in “Night moves”) più o meno soddisfacente, di sicuro non tanto impegnativo, almeno non quanto quello professionale che la tiene in contatto a più riprese con un suo vecchio cliente - Fuller/Harris - incapace di rassegnarsi, dopo un incidente verificatosi nel cantiere dove lavora e dopo aver accettato per via extra-giudiziale un accordo con la controparte, all’impossibilità di intraprendere una ulteriore azione legale: circostanze, queste, che concorreranno a spezzare in via definitiva il suo già periclitante matrimonio e lo indurranno a un gesto difficile dire se più grottesco o insensato (la presa in ostaggio della stessa Laura - e di un custode notturno di origine polinesiana, Amituana/Fonokalafi - in un ufficio presso gli archivi del Tribunale, allo scopo di farsi leggere ad alta voce gli atti inerenti alla sua causa, per darsi poi alla macchia assecondando un bislacco - ma più che altro vano - piano di fuga). Di seguito facciamo la conoscenza di Gina (di nuovo Michelle Williams) e della tiepida attrazione che la avvicina al compagno Ryan (quello della relazione con Laura) e a una figlia adolescente, apatica e insofferente, di nome Guthrie/Rodier, con la quale il battibecco è all’ordine del giorno. Senza eccessivo trasporto ma con la mite determinazione di coloro avvezzi a ottenere in un modo o nell’altro ciò che vogliono Gina pungola Ryan per far visita al vecchio e solitario Albert/Auberjonois, la casa del quale sorge su un terreno in passato occupato da una scuola - quella del paese al tempo della sua fondazione - i cui grossi mattoni di arenaria che ne costituivano le pareti e che giacciono ammucchiati all’aperto lei intende acquisire al fine di costruire una nuova dimora fuori dal centro abitato di Livingston. Infine ci si sposta (non di molto: parliamo sempre di vicinanze comprese nel Montana meridionale) a Belfry, dove una ragazza/Gladstone si prende cura di un ranch e di un certo numero di cavalli tenendo in esercizio l’intera attività, come prevedono i termini del suo contratto stagionale. Silenziosa e metodica prova a movimentare le sue giornate una uguale all’altra frequentando verso sera i locali della scuola prestati a corsi integrativi di legislazione interna (nello specifico, quelli che riguardano i diritti degli studenti), che le consentono di fare presto la conoscenza della coetanea Elizabeth/(prima volta con la Reichardt anche per Kristen Stewart), giovane praticante legale e insegnante a tempo perso in cerca di un lavoro stabile che le permetta di sfuggire a un domani già scritto fatto di tran-tran, compensi irrisori e depressione latente. I segmenti esistenziali di cui si compone l’opera (dedicata alla Lucy di “Wendy and Lucy” - vd. -) - quelli con al centro Laura e Gina occupano, più o meno, la prima metà del film e, marginalmente, il finale - esprimono, con varianti minime, nella cruda inesorabilità della loro apparenza e segnalando, al tempo, un altro spostamento del Cinema di Kelly, stavolta, come detto, in direzione di un tentativo atto a organizzare una narrazione tanto più sottotono negli accenti quanto più esplicita negli esiti in vista di coniugare un collaudato proposito di stilizzazione all’insolita urgenza di rappresentazione lineare delle vicissitudini dei personaggi, il panorama emotivo impresso sulla faccia nascosta dell’altra America, quella avvilita ma quieta di minuscoli luoghi che contano mai più di poche manciate di anime; che sopravvive con sempre minore capacità di resistenza ai rigori delle logiche di una economia oramai del tutto globalizzata (si pensi alle ricadute che il sedicente capitalismo maturo comporta sui piccoli proprietari terrieri, sugli allevatori, sugli agricoltori - ovviamente non solo americani - et.); i cui componenti spendono il proprio tempo non produttivo (e il proprio scarso denaro) nei centri commerciali - per quanto sparuti a quelle latitudini - o presso ristoranti e bar di paese o, ancora, assumendo dosi massive del barbiturico più a buon mercato di tutti, la televisione (è proprio lo scoramento indotto dall’idea di sorbirsi l’ennesimo quantitativo giornaliero a spronare la ragazza del ranch a raggiungere la scuola di Belfry dove, come descritto, aggregandosi per pura inerzia a un corso di aggiornamento didattico, stringerà un sincero sebbene infruttuoso - perché abortito - sodalizio con Elizabeth). Scopo palese arginare il più possibile la certezza di quanto possa essere asfissiante la solitudine americana, a dire la comune, idiota e opprimente sofferenza del primate occidentale medio passata al tritacarne di un darwinismo sociale autoproclamatosi, nell’acquiescenza pressoché generale, unico e solo spirito del tempo. Non a caso, tutte e tre le certain women del titolo cercano (o si imbattono) - Laura sbirciando Livingston dall’interno del proprio studio; Gina spiando le brulle distanze del Montana da casa di Albert durante una pausa della sua visita; la ragazza del ranch affacciandosi ogni mattina oltre la porta metallica scorrevole delle stalle - un altrove anche momentaneo, un colpo d’occhio più vasto di quello che una consuetudine sempre uguale a sé stessa apparecchia giorno dopo giorno per loro. In tal senso, il tono dello sguardo di Kelly si fa più intimo, aderisce in maniera discreta epperò inequivocabile al destino di queste donne, retaggio così simile nelle coordinate essenziali del suo tessersi e dipanarsi da non abbisognare di sottolineature o sovrapposizioni (Laura, Gina e la ragazza del ranch, cioè, probabilmente non si conosceranno mai: continueranno magari a sfiorarsi per le ovvie intersezioni dovute al caso. La ragazza del ranch, ad esempio, finirà per chiedere informazioni sugli orari e le poliedriche attività di Elizabeth proprio allo studio di Laura, a Livingston, mentre lei vi sta sopraggiungendo), restando, ovvero e per un certo tempo, idealmente collegate senza che la sostanza della loro connessione si materializzi (vedi anche l’affaire di Laura col compagno di Gina). Di conseguenza, pure il passo cinematografico impresso prova a misurarsi con l’esigenza di orchestrare lo sperimentato assunto filosofico volto a trattenere una essenza ulteriore rispetto alla immediatezza materiale della rappresentazione (”Ode” e “Old joy”, in particolare) con l’insorta urgenza/ridimensionamento in un ambito in cui a prevalere è il lato narrativo della vicenda, quello di più istantaneo coinvolgimento (vedi “Meek’s cutoff” e “Night moves”). Così, in “Certain women”, al ritaglio icastico del dettaglio significativo si sostituisce con gradualità l’interrogazione primaria dei volti (numerosi primi piani fissi o in movimento traducono tanto le aspettative recondite delle protagoniste quanto il potenziale allusivo delle loro intenzioni proiettato oltre la trama delle parole e dei gesti); alla meditativa contemplazione paesaggistica misurata su intervalli dilatati utili a prospettarne la valenza simbolica, si privilegia il ritratto naturalistico atto più a caratterizzare l’universo materiale dei fatti raccontati che la loro teorica qualità allegorica, in una accorta ricerca di nessi e giunti la cui mimesi con l‘impianto narrativo corre quasi esclusivamente sulla superficie del visibile. Il risultato è una messinscena ibrida, se così si può dire, all’interno della quale l’iterazione/reiterazione dei dialoghi, degli atteggiamenti, delle emozioni, l’eventualità del loro trascendere l’evidenza, viene costruita e proposta in genere a partire da una singola inquadratura o da un campo medio il più delle volte proteso - nel caso - verso un immoto paesaggio invernale, espediente adatto a indirizzare l’attenzione - per dire - sulla alacrità della ragazza del ranch, sulle sue costanti premure, senza però escludere mai l’ambiente in cui tutto ciò accade, ossia riconoscendo parimenti sempre a esso la peculiarità/intenzione virtuale di sovvertirne l’equilibrio, in un rincorrersi di scenari - drammatici, sentimentali, ironici, patetici, interlocutori - che ricorda, tra i tanti, l’esprit della prosa di una scrittrice come Amy Hempel, il suo procedere falsamente arreso, in verità sintomatico e sempre disponibile nei confronti di qualcosa di imminente. Ascoltiamola: Quello che sembra pericoloso spesso non lo è: i serpenti neri, per esempio, o i vuoti d’aria. Mentre le cose che stanno lì, immobili, come questa spiaggia, sono dense di pericoli. Una polvere gialla che si alza dalla terra, un caldo che fa maturare i meloni dall’oggi al domani: tempo da terremoto. Sei seduta a intrecciare la frangia dell’asciugamano, e d’un tratto la sabbia viene risucchiata come in una clessidra. C’è un rombo nell’aria. Negli appartamenti a buon mercato davanti alla spiaggia, le vasche da bagno si riempiono da sole, e i giardini si sollevano e si arrotolano come onde verdi. Se non succede niente, la polvere continuerà a disperdersi e il caldo a crescere finché la paura non si muterà in desiderio. Una tensione del genere può venire allentata solo da una catastrofe. O anche: I fiori galoppavano nei campi senza spine, fermandosi solo quando venivano recisi e messi nell’acqua. Le liste della spesa si allungavano fino a comprendere le carote per il cavallo dei vicini, tutto nero a eccezione della groppa, che sembrava spruzzata di bianco e di nero: un cavallo che al crepuscolo correva come un matto dentro al recinto, e che si chiamava Fury.  E ancora: Il mohair pizzicava, le strisce ingoffavano, ma il tweed filato a mano era perfetto per una taglia piccola. Comprai alcune matasse, di un blu ardesia addolcito da puntini rosa, e due ferri numero sei, per un maglione caldo ma leggero. Scelsi un modello bicolore, con lo scollo a V e una treccia su sei maglie, facoltativa, sul davanti. I pullover scompigliano i capelli, ma non volevo cimentarmi subito con le asole. Brani disparati che, con la dovuta cautela, sembrano però davvero riprodurre i caratteri delle protagoniste del, fino a ora, ultimo film di Kelly disponibile (“First cow”, ritorno alla collaborazione con Jon Raymond, al momento della redazione di questo scritto, è in post-produzione): fiducioso ma apprensivo, quello di Laura; riservato e ingenuo, quello della ragazza del ranch; volitivo quanto inappagato, quello di Gina. Ciascuno diverso e irripetibile, cionondimeno messaggero di un desiderio che non si esaurisce nell’esaudimento di un suo anche a lungo coltivato capriccio. Su una similare lunghezza d’onda oscilla, inoltre, anche il registro delle cromie adottate, buona parte delle quali - e non solo perché a disciplinarle troviamo per la terza volta Christopher Blauvelt - ripropone e amplia le soluzioni sperimentate per lo più in “Night moves”. Si nota, in altre parole e di nuovo, una qual preminenza delle tonalità scure, in specie per ciò che attiene agli interni e al profilo dei volti per contro irradiati da una luce diafana, quasi alabastrina che, qua e là, ricorda la suggestiva ritrattistica di Eakins. Meno contrastata e più uniforme, a evidenziare una sorta di continuità palpabile entro un mondo che sotto il brulicare irruente delle prestazioni mercantili mantiene un suo indelebile, tutto sommato ambiguo pallore (esaltato, peraltro, dal clima rigido di stagione), è la luminosità che descrive i contorni dell’ambiente fisico - vallate, fiumi, boschi, montagne - e i limiti dell’intraprendenza umana - le architetture degli edifici di Livingston; le strade poco trafficate di Belfry; i negozi quasi senza avventori; gli spazi scostanti degli uffici, et. - omologa, per tanti versi, al chiarore freddo che effonde dagli squarci innevati di un altro pensabile riferimento pittorico, quello di Lawson. Entrambe le gradazioni accompagnate, di quando in quando, dalla malinconia trattenuta del commento musicale di Jeff Grace (anche lui alla terza collaborazione con Kelly) e, più ancora, dalla grazia timida tessuta dalla chitarra di Smokey Hormel (della partita già da “Old joy”). Malinconia e grazia che - è appena il caso di ricordarlo qui, in chiusura, e allargando la visuale - si intrecciano senza sforzo e di continuo al corso delle nostre stesse vite, così spesso smarrite e dolenti, eppure talvolta alleggerite da una singolare istanza di compassione e innalzamento, esattamente quella che Kelly Reichardt col suo Cinema prova a inseguire e con dolce tristezza si ostina a celebrare, prima che il deserto ci sommerga.
E ancora: Il mohair pizzicava, le strisce ingoffavano, ma il tweed filato a mano era perfetto per una taglia piccola. Comprai alcune matasse, di un blu ardesia addolcito da puntini rosa, e due ferri numero sei, per un maglione caldo ma leggero. Scelsi un modello bicolore, con lo scollo a V e una treccia su sei maglie, facoltativa, sul davanti. I pullover scompigliano i capelli, ma non volevo cimentarmi subito con le asole. Brani disparati che, con la dovuta cautela, sembrano però davvero riprodurre i caratteri delle protagoniste del, fino a ora, ultimo film di Kelly disponibile (“First cow”, ritorno alla collaborazione con Jon Raymond, al momento della redazione di questo scritto, è in post-produzione): fiducioso ma apprensivo, quello di Laura; riservato e ingenuo, quello della ragazza del ranch; volitivo quanto inappagato, quello di Gina. Ciascuno diverso e irripetibile, cionondimeno messaggero di un desiderio che non si esaurisce nell’esaudimento di un suo anche a lungo coltivato capriccio. Su una similare lunghezza d’onda oscilla, inoltre, anche il registro delle cromie adottate, buona parte delle quali - e non solo perché a disciplinarle troviamo per la terza volta Christopher Blauvelt - ripropone e amplia le soluzioni sperimentate per lo più in “Night moves”. Si nota, in altre parole e di nuovo, una qual preminenza delle tonalità scure, in specie per ciò che attiene agli interni e al profilo dei volti per contro irradiati da una luce diafana, quasi alabastrina che, qua e là, ricorda la suggestiva ritrattistica di Eakins. Meno contrastata e più uniforme, a evidenziare una sorta di continuità palpabile entro un mondo che sotto il brulicare irruente delle prestazioni mercantili mantiene un suo indelebile, tutto sommato ambiguo pallore (esaltato, peraltro, dal clima rigido di stagione), è la luminosità che descrive i contorni dell’ambiente fisico - vallate, fiumi, boschi, montagne - e i limiti dell’intraprendenza umana - le architetture degli edifici di Livingston; le strade poco trafficate di Belfry; i negozi quasi senza avventori; gli spazi scostanti degli uffici, et. - omologa, per tanti versi, al chiarore freddo che effonde dagli squarci innevati di un altro pensabile riferimento pittorico, quello di Lawson. Entrambe le gradazioni accompagnate, di quando in quando, dalla malinconia trattenuta del commento musicale di Jeff Grace (anche lui alla terza collaborazione con Kelly) e, più ancora, dalla grazia timida tessuta dalla chitarra di Smokey Hormel (della partita già da “Old joy”). Malinconia e grazia che - è appena il caso di ricordarlo qui, in chiusura, e allargando la visuale - si intrecciano senza sforzo e di continuo al corso delle nostre stesse vite, così spesso smarrite e dolenti, eppure talvolta alleggerite da una singolare istanza di compassione e innalzamento, esattamente quella che Kelly Reichardt col suo Cinema prova a inseguire e con dolce tristezza si ostina a celebrare, prima che il deserto ci sommerga.***






0 commenti:
Posta un commento